di Diego Gabutti
 «Una volta», racconta Bob Dylan in Chronicle (Feltrinelli 2005), «ero in macchina con Robbie Robertson, chitarrista del gruppo che poi sarebbe diventato The Band. Mi dice: “Dove pensi di portarla, Bob?” “Portare cosa?” chiesi io. “Lo sai, l’intera scena musicale.” L’intera scena musicale! […] Non so cosa gli altri avessero per la testa, ma quello di cui stavo fantasticando io era una vita con un lavoro dalle nove alle cinque, una casa in un quartiere con le case fiancheggiate da alberi, con una staccionata bianca e le rose nel cortile sul retro».
«Una volta», racconta Bob Dylan in Chronicle (Feltrinelli 2005), «ero in macchina con Robbie Robertson, chitarrista del gruppo che poi sarebbe diventato The Band. Mi dice: “Dove pensi di portarla, Bob?” “Portare cosa?” chiesi io. “Lo sai, l’intera scena musicale.” L’intera scena musicale! […] Non so cosa gli altri avessero per la testa, ma quello di cui stavo fantasticando io era una vita con un lavoro dalle nove alle cinque, una casa in un quartiere con le case fiancheggiate da alberi, con una staccionata bianca e le rose nel cortile sul retro».
Robbie Robertson, scomparso ottantenne a Los Angeles qualche settimana fa, pensava in grande, anche a costo d’irritare Bob Dylan, col quale aveva inciso dischi immortali, e di cui fu complice, insieme al resto della Band, nello scantinato di Big Pink, la leggendaria casa rosa nei boschi intorno a Woodstok, dove furono incisi su registratori di fortuna i Basement Tapes, una miniera di classici song americani, di scherzi musicali mozartiani, di blues semidimenticati, di canzoni nuove di zecca. A lungo segreti, o meglio occulti, i Basement Tapes furono vastamente piratati prima d’essere parzialmente pubblicati, nel 1975, in via ufficiale.
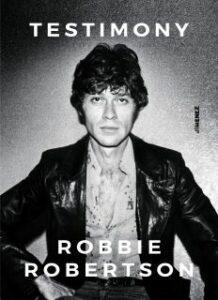 Erano gli anni sessanta e Robertson – come racconta nella sua autobiografia, Testimony, un grande libro sull’America e sulla giovinezza del mondo – era sulla strada dagli ultimi anni cinquanta, quando appena sedicenne era stato reclutato dallo sfrenato «Rompin’» Ronnie Hawkins, leader degli Hawks, «la rock’n’roll band più fica che c’era». Gli Hawks erano una band sudista, puro Arkansas, dove «l’aria sapeva dei pini di Ozark e di cibo fritto», mentre Robertson era canadese, di Toronto, dove alla band capitava spesso di passare, e dove una volta furono tutti arrestati per possesso di marijuana. Madre pellerossa e padre biologico ebreo, un gambler o pokerista di professione morto in un incidente stradale, anche se alcuni pronunciavano la parola «incidente» con aria dubbiosa, Robertson aveva uno «zio Natie» nel traffico dei diamanti rubati e zii, amici e cugini nelle Sei Nazioni: i Mohawk, i Cayuga, gli Onondaga, i Seneca, gli Oneida e i Tuscarora. Ai suoi geni pellerossa avrebbe dedicato parecchi anni dopo Music for the Native Americans. Al sud degli States, dove l’aveva portato la chitarra vibrando come una bacchetta di rabdomante, dedicò The Night They Drove Old Dixie Down, una malinconica ballata del 1969 che Joan Baez portò al primo posto in hit parade e che oggi, con quella sua dichiarata nostalgia per il Generale Lee e per il vecchio sud, finirebbe sul rogo insieme all’Amleto di Shakespeare e ai poster dei film di Harry Potter.
Erano gli anni sessanta e Robertson – come racconta nella sua autobiografia, Testimony, un grande libro sull’America e sulla giovinezza del mondo – era sulla strada dagli ultimi anni cinquanta, quando appena sedicenne era stato reclutato dallo sfrenato «Rompin’» Ronnie Hawkins, leader degli Hawks, «la rock’n’roll band più fica che c’era». Gli Hawks erano una band sudista, puro Arkansas, dove «l’aria sapeva dei pini di Ozark e di cibo fritto», mentre Robertson era canadese, di Toronto, dove alla band capitava spesso di passare, e dove una volta furono tutti arrestati per possesso di marijuana. Madre pellerossa e padre biologico ebreo, un gambler o pokerista di professione morto in un incidente stradale, anche se alcuni pronunciavano la parola «incidente» con aria dubbiosa, Robertson aveva uno «zio Natie» nel traffico dei diamanti rubati e zii, amici e cugini nelle Sei Nazioni: i Mohawk, i Cayuga, gli Onondaga, i Seneca, gli Oneida e i Tuscarora. Ai suoi geni pellerossa avrebbe dedicato parecchi anni dopo Music for the Native Americans. Al sud degli States, dove l’aveva portato la chitarra vibrando come una bacchetta di rabdomante, dedicò The Night They Drove Old Dixie Down, una malinconica ballata del 1969 che Joan Baez portò al primo posto in hit parade e che oggi, con quella sua dichiarata nostalgia per il Generale Lee e per il vecchio sud, finirebbe sul rogo insieme all’Amleto di Shakespeare e ai poster dei film di Harry Potter.
 Canadese di nascita e southerner, sudista, per autoproclamazione, Mohawk ed ebreo, Robertson suonava po’ come il verso vivente d’una canzone di Dylan, tipo Mister Tamburino nel «mattino tintinnante» o Mack il Dito e Louis il Re con i loro «quaranta lacci da scarpe rossi bianchi e blu» o come qualunque altro, a piacere, dei tanti Arlecchini e Pierrot etnici e culturali che avrebbero guadagnato, col tempo e le melodie evergreen, un Nobel al loro puparo simbolista.
Canadese di nascita e southerner, sudista, per autoproclamazione, Mohawk ed ebreo, Robertson suonava po’ come il verso vivente d’una canzone di Dylan, tipo Mister Tamburino nel «mattino tintinnante» o Mack il Dito e Louis il Re con i loro «quaranta lacci da scarpe rossi bianchi e blu» o come qualunque altro, a piacere, dei tanti Arlecchini e Pierrot etnici e culturali che avrebbero guadagnato, col tempo e le melodie evergreen, un Nobel al loro puparo simbolista.
 Robertson scrisse le sue prime canzoni a sedici anni. Hey Boba Lou e Someone Like You, due pezzi indiavolati alla Jerry Lee Lewis, apparvero in un album di Ronnie Hawkins, Dynamo, nel 1960. Solo che al suo nome era affiancato, come coautore e dunque «co-incassatore» delle eventuali royalties, un testa di legno della casa discografica, la Roulette Records, con uffici a Broadway, NYC. Robertson voleva protestare, «ma Ron mi disse: “Figliolo, in questo ambiente ci sono cose che non devi neanche provare a mettere in discussione. Ci sono dei tizi a New York City che non ti conviene far incazzare”». Erano «tempi duri in città», per citare sempre Dylan: «Una frotta di gente ti turbina intorno / che quando ti va bene sono calci e appena ti va male sono pugni». Morris Levy, boss della Roulette Records, quando Robertson entrò nel suo ufficio, lo squadrò per bene e poi, rivolto a Hawkins, ringhiando: «Proprio un bel ragazzino. Se finiamo in carcere non sarebbe male portarlo con noi. Scommetto che sei indeciso se assumerlo o scopartelo». Robertson, «in quel preciso istante», decise «di rinunciare a sollevare una qualunque disputa sulla questione diritti».
Robertson scrisse le sue prime canzoni a sedici anni. Hey Boba Lou e Someone Like You, due pezzi indiavolati alla Jerry Lee Lewis, apparvero in un album di Ronnie Hawkins, Dynamo, nel 1960. Solo che al suo nome era affiancato, come coautore e dunque «co-incassatore» delle eventuali royalties, un testa di legno della casa discografica, la Roulette Records, con uffici a Broadway, NYC. Robertson voleva protestare, «ma Ron mi disse: “Figliolo, in questo ambiente ci sono cose che non devi neanche provare a mettere in discussione. Ci sono dei tizi a New York City che non ti conviene far incazzare”». Erano «tempi duri in città», per citare sempre Dylan: «Una frotta di gente ti turbina intorno / che quando ti va bene sono calci e appena ti va male sono pugni». Morris Levy, boss della Roulette Records, quando Robertson entrò nel suo ufficio, lo squadrò per bene e poi, rivolto a Hawkins, ringhiando: «Proprio un bel ragazzino. Se finiamo in carcere non sarebbe male portarlo con noi. Scommetto che sei indeciso se assumerlo o scopartelo». Robertson, «in quel preciso istante», decise «di rinunciare a sollevare una qualunque disputa sulla questione diritti».
 C’era una rivoluzione in corso, solo che riguardava quasi esclusivamente la musica, e non ancora la vita quotidiana dei giovani, la loro cultura, i costumi. Elvis Presley era solo in parte un fenomeno culturale. Nessuno si scandalizzò né sacramentò o lanciò lattine di Coca-Cola sul palco quando il Re passò da Nashville a Hollywood, dal rock duro al pop. Non c’era una grande distanza tra lui nel Delinquente del rock’n’roll e Pat Boone in Viaggio al centro della Terra. Ma qualcosa stava cambiando, e stava cambiando in fretta: i Beatles, i movimenti studenteschi in California, la scena radical sempre più estesa. Musica e controculture cominciavano a intrecciarsi strettamente tra loro, e quando a saltare dal folk impegnato e «di protesta» (come si diceva) al rock’n’roll dada-astrattista fu Bob Dylan, zompando da Masters of War e Hard Rain a Like a Rolling Stone e Memphis Blues Again, il pubblico dei concerti insorse. Sul palco, con Bob Dylan, in quei drammatici tour del 1965 e 1966, quando a Dylan davano del «venduto» e del «rinnegato», c’erano anche Robertson e la neonata Band (band e basta, senza nome) che aveva appena divorziato da Ronnie Hawkins.
C’era una rivoluzione in corso, solo che riguardava quasi esclusivamente la musica, e non ancora la vita quotidiana dei giovani, la loro cultura, i costumi. Elvis Presley era solo in parte un fenomeno culturale. Nessuno si scandalizzò né sacramentò o lanciò lattine di Coca-Cola sul palco quando il Re passò da Nashville a Hollywood, dal rock duro al pop. Non c’era una grande distanza tra lui nel Delinquente del rock’n’roll e Pat Boone in Viaggio al centro della Terra. Ma qualcosa stava cambiando, e stava cambiando in fretta: i Beatles, i movimenti studenteschi in California, la scena radical sempre più estesa. Musica e controculture cominciavano a intrecciarsi strettamente tra loro, e quando a saltare dal folk impegnato e «di protesta» (come si diceva) al rock’n’roll dada-astrattista fu Bob Dylan, zompando da Masters of War e Hard Rain a Like a Rolling Stone e Memphis Blues Again, il pubblico dei concerti insorse. Sul palco, con Bob Dylan, in quei drammatici tour del 1965 e 1966, quando a Dylan davano del «venduto» e del «rinnegato», c’erano anche Robertson e la neonata Band (band e basta, senza nome) che aveva appena divorziato da Ronnie Hawkins.
 Quando dal pubblico saliva lo schiamazzo contro la voce raspante di Dylan, contro la chitarra elettrica di Robertson e contro la batteria del grande Levon Helm, l’ex folksinger urlava: «Più forte! Suoniamo più veloci e più forte!» Era il nuovo mondo, un altro pianeta. Scrive Robertson: «Eravamo nel bel mezzo d’una rivoluzione rock’n’roll. O aveva ragione il pubblico, o avevamo ragione noi». Avevano ragione (e torto) tutti quanti. Era Il Decennio dell’Io (Castelvecchi 2013), come lo chiamò Tom Wolfe in un fortunato pamphlet di quegli anni, e ciascuno stava dietro alle proprie alienazioni e idiosincrasie. Quanto ai musicisti, più che suonare forte e veloce, vivevano pericolosamente, in molti sensi: «Quando qualcuno cambiava accordatura nel mezzo d’un assolo, io mi sentivo come Doc Holliday che cerca di smaltire la sbornia prima di buttarsi in una sparatoria al fianco di Wyatt Earp».
Quando dal pubblico saliva lo schiamazzo contro la voce raspante di Dylan, contro la chitarra elettrica di Robertson e contro la batteria del grande Levon Helm, l’ex folksinger urlava: «Più forte! Suoniamo più veloci e più forte!» Era il nuovo mondo, un altro pianeta. Scrive Robertson: «Eravamo nel bel mezzo d’una rivoluzione rock’n’roll. O aveva ragione il pubblico, o avevamo ragione noi». Avevano ragione (e torto) tutti quanti. Era Il Decennio dell’Io (Castelvecchi 2013), come lo chiamò Tom Wolfe in un fortunato pamphlet di quegli anni, e ciascuno stava dietro alle proprie alienazioni e idiosincrasie. Quanto ai musicisti, più che suonare forte e veloce, vivevano pericolosamente, in molti sensi: «Quando qualcuno cambiava accordatura nel mezzo d’un assolo, io mi sentivo come Doc Holliday che cerca di smaltire la sbornia prima di buttarsi in una sparatoria al fianco di Wyatt Earp».
 Ai tempi degli Hawks, solo un paio d’anni prima, «in un sacco di locali, se avevi i capelli lunghi, ti pestavano di brutto o ti sparavano. Frequentavamo un sacco di gangster, e secondo loro se avevi i capelli lunghi eri un finocchio». Adesso «nuove vibrazioni attraversavano il paese: le Pantere Nere, gli Hell’s Angels di Oakland, i poeti Beatnik, e una fiorente scena musicale che combaciava col nostro indirizzo musicale. Un giorno accompagnai Bob alla City Lights, la libreria di Lawrence Ferlinghetti a Frisco. Fummo accolti dai poeti Michael McClure e Allen Ginsberg. Vedere Allen, Michael e Bob chiacchierare con disinvoltura di scrittori e poeti mi fece ripensare agli anni passati con Ronnie, quando anche soltanto parlare di poesia era una buona ragione per essere presi a calci nel culo». Ma ogni Eden ha il suo serpente, come Robertson e la Band, insieme all’intera «scena musicale», avrebbero scoperto presto, quando le droghe cominciarono a dilagare, quando ad Altamont un concerto dei Rolling Stones finì in tragedia e l’«estate dell’amore» generò la Famiglia Manson e la strage di Bel Air.
Ai tempi degli Hawks, solo un paio d’anni prima, «in un sacco di locali, se avevi i capelli lunghi, ti pestavano di brutto o ti sparavano. Frequentavamo un sacco di gangster, e secondo loro se avevi i capelli lunghi eri un finocchio». Adesso «nuove vibrazioni attraversavano il paese: le Pantere Nere, gli Hell’s Angels di Oakland, i poeti Beatnik, e una fiorente scena musicale che combaciava col nostro indirizzo musicale. Un giorno accompagnai Bob alla City Lights, la libreria di Lawrence Ferlinghetti a Frisco. Fummo accolti dai poeti Michael McClure e Allen Ginsberg. Vedere Allen, Michael e Bob chiacchierare con disinvoltura di scrittori e poeti mi fece ripensare agli anni passati con Ronnie, quando anche soltanto parlare di poesia era una buona ragione per essere presi a calci nel culo». Ma ogni Eden ha il suo serpente, come Robertson e la Band, insieme all’intera «scena musicale», avrebbero scoperto presto, quando le droghe cominciarono a dilagare, quando ad Altamont un concerto dei Rolling Stones finì in tragedia e l’«estate dell’amore» generò la Famiglia Manson e la strage di Bel Air.
 Nell’ultima formazione degli Hawks, prima che lui e altri membri del gruppo si separassero da Ronnie Hawkins, rocker vecchio stile in un’America alternata, irriconoscibile, c’erano più canadesi che «native dixieland», per chiamarli così. Tranne Helm, un sudista di sangue puro, tutti gli altri (Robertson, Richard Manuel, Garth Hudson, Rick Danko) erano nati oltre frontiera, nella terra delle alci e dei Mounties, le Giubbe Rosse. Quando suonavano a Toronto «amici e parenti accorrevano in massa per vedere i figli della loro terra suonare ai massimi livelli. C’erano gangster e ladri, sarti, truffatori, cuochi e contorsionisti, biscazzieri e giostrai, di tutto». Anche qui, in Canada, i personaggi da vaudeville pulp che s’affaccendavano e spintonavano nei versi di Bob Dylan e della Band avevano preso sostanza, a dimostrazione che non c’era niente d’inventato. Era tutto vero: ogni canzone un fotocolor, il mondo un circo a tre piste.
Nell’ultima formazione degli Hawks, prima che lui e altri membri del gruppo si separassero da Ronnie Hawkins, rocker vecchio stile in un’America alternata, irriconoscibile, c’erano più canadesi che «native dixieland», per chiamarli così. Tranne Helm, un sudista di sangue puro, tutti gli altri (Robertson, Richard Manuel, Garth Hudson, Rick Danko) erano nati oltre frontiera, nella terra delle alci e dei Mounties, le Giubbe Rosse. Quando suonavano a Toronto «amici e parenti accorrevano in massa per vedere i figli della loro terra suonare ai massimi livelli. C’erano gangster e ladri, sarti, truffatori, cuochi e contorsionisti, biscazzieri e giostrai, di tutto». Anche qui, in Canada, i personaggi da vaudeville pulp che s’affaccendavano e spintonavano nei versi di Bob Dylan e della Band avevano preso sostanza, a dimostrazione che non c’era niente d’inventato. Era tutto vero: ogni canzone un fotocolor, il mondo un circo a tre piste.
 Poco più che trentenne, ma sulla strada ormai da quattordici anni, Robertson cominciava a sentire la fatica. Idem Helm e gli altri, tutti ormai più o meno persi dietro le droghe, inclusa l’eroina. Pochi concerti, e poco da incidere. Valeva per la Band come per ogni altra band: il decennio dell’Io e del rock era finito, soffocato dalla vanitas e dalla sfiga, che rovesciano invariabilmente ogni utopia nel suo contrario. Di questa breve, brevissima parentesi, dalla stagione cioè di Elvis e di Ronnie Hawkins all’età del Sgt. Pepper e della cultura delle droghe, Robbie Robertson – che la visse da un capo all’altro, scrivendo «along the road» canzoni memorabili: The Weight, Up on Cripple Creek, The Shape I’m In – è stato un grande testimone, e il suo libro forse la migliore (e comunque un’eccezionale) testimonianza umana e letteraria. Presente all’inizio della festa, quando «il rock’n’roll era violento, dinamico, primitivo e creava dipendenza», fu lui a spegnere i riflettori quando la festa gli sembrò finita (ma restavano le dipendenze, e non c’era più, come disse Dylan, «nessuna cazzo di magia»).
Poco più che trentenne, ma sulla strada ormai da quattordici anni, Robertson cominciava a sentire la fatica. Idem Helm e gli altri, tutti ormai più o meno persi dietro le droghe, inclusa l’eroina. Pochi concerti, e poco da incidere. Valeva per la Band come per ogni altra band: il decennio dell’Io e del rock era finito, soffocato dalla vanitas e dalla sfiga, che rovesciano invariabilmente ogni utopia nel suo contrario. Di questa breve, brevissima parentesi, dalla stagione cioè di Elvis e di Ronnie Hawkins all’età del Sgt. Pepper e della cultura delle droghe, Robbie Robertson – che la visse da un capo all’altro, scrivendo «along the road» canzoni memorabili: The Weight, Up on Cripple Creek, The Shape I’m In – è stato un grande testimone, e il suo libro forse la migliore (e comunque un’eccezionale) testimonianza umana e letteraria. Presente all’inizio della festa, quando «il rock’n’roll era violento, dinamico, primitivo e creava dipendenza», fu lui a spegnere i riflettori quando la festa gli sembrò finita (ma restavano le dipendenze, e non c’era più, come disse Dylan, «nessuna cazzo di magia»).
 Era tempo di sciogliere la Band e di passare ad altro. Fu un evento, celebrato dal primo grande film rock’n’roll, The Last Waltz, diretto da Martin Scorsese, che all’epoca aveva già diretto film memorabili come Taxi Driver, Mean Streets, New York New York. A celebrare il tramonto della «rivoluzione rock’n’roll» e lo scioglimento della Band c’erano tutti: Neil Young, Joni Mitchell, Ronnie Hawkins, Bob Dylan, Eric Clapton, Van Morrison, Muddy Waters, Ron Wood, Neil Diamond, Ringo Starr.
Era tempo di sciogliere la Band e di passare ad altro. Fu un evento, celebrato dal primo grande film rock’n’roll, The Last Waltz, diretto da Martin Scorsese, che all’epoca aveva già diretto film memorabili come Taxi Driver, Mean Streets, New York New York. A celebrare il tramonto della «rivoluzione rock’n’roll» e lo scioglimento della Band c’erano tutti: Neil Young, Joni Mitchell, Ronnie Hawkins, Bob Dylan, Eric Clapton, Van Morrison, Muddy Waters, Ron Wood, Neil Diamond, Ringo Starr.
Robertson, dopo di allora, incise qualche disco da solista, nessuno particolarmente notevole. Scrisse numerose colonne sonore per Wim Wenders e Barry Levinson, per Oliver Stone, ma soprattutto per Scorsese, col quale collaborò per Toro Scatenato, Casinò, The Wolf of Wall Street, Gangs of New York e numerosi altri film, compreso l’ultimo, Killers of the Flower Moon, presentato quest’anno a Cannes e in uscita nei prossimi mesi. The Band tornò in pista nei primi ottanta senza di lui, e senza che ne uscisse niente di paragonabile ai trionfi dei vecchi tempi.
 Di Robertson circola su Internet, qui, un bellissimo video che celebra il cinquantenario di The Weight, una delle più belle canzoni mai registrate. Artisti di tutto il mondo, dal Tibet al Texas, dal Congo al Bahrein, dall’Italia al Giappone, dall’Argentina alla Giamaica, la cantano in coro, ciascuno dalla propria location. Vecchio e divertito, Robbie impugna la sua chitarra, come in giovinezza, e il suo sorriso illumina il mondo, che lui chiamava «la scena musicale».
Di Robertson circola su Internet, qui, un bellissimo video che celebra il cinquantenario di The Weight, una delle più belle canzoni mai registrate. Artisti di tutto il mondo, dal Tibet al Texas, dal Congo al Bahrein, dall’Italia al Giappone, dall’Argentina alla Giamaica, la cantano in coro, ciascuno dalla propria location. Vecchio e divertito, Robbie impugna la sua chitarra, come in giovinezza, e il suo sorriso illumina il mondo, che lui chiamava «la scena musicale».



