di Franco Pezzini
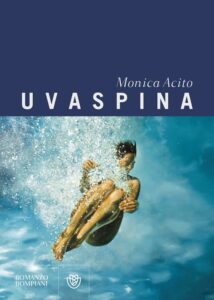 Alcune delle considerazioni svolte nella prima parte di questo itinerario appaiono particolarmente calzanti a un romanzo da poco apparso che sta conquistandosi meritate attenzioni e lodi, Uvaspina di Monica Acito (pp. 405, € 20, Bompiani, Milano 2023). Un romanzo drammatico ma con ampie, visionarie, urticanti concessioni al grottesco; un romanzo sicuramente mainstream, riccamente letterario e focalizzato su concretissimi rapporti tra personaggi umani – anche quando l’umanità si rattrappisce in buchi, vasci e palazzi fatiscenti, confinata dai suoi lividi – ma dove pure la componente fantastica non latita. In scena è un fantastico della carne, in tutte le accezioni possibili, e che piazza sul tavolo operatorio senza troppi complimenti non una macchina da cucire e un ombrello, ma le contraddizioni familiari, affettive, sociali e sessuali di un’intera città di corpi fradici e acidi di sigarette di contrabbando; una città che è la vera e propria protagonista – ben più del personaggio eponimo attorno al quale tutto ruota – in una giostra di amori e altri demoni echeggianti interi corpora di letture della giovanissima autrice (Rea, Di Giacomo, Serao, Marotta, La Capria, Ortese, ma anche il Basile… e poi tanti sudamericani). Una Napoli ctonia e crudelmente barocca dove i presepi lasciano spazio alla ceroplastica di Zumbo e neppure il viaggiatore Sade e la sua Juliette sarebbero a proprio agio: una Napoli pirotecnicamente eccessiva – lontana anni luce dalle due letture di successo popolare, la cartolina da commedia (magari amara, non si discute) da film con Totò, Loren e De Sica su una linea che arriva fino a Eduardo, e la Gomorra alla Saviano – e che spurga pulsioni e miti, incubi e odori nell’acqua sporca di un mare che “odorava di bestia cruda e bolliva come un pentolone di ragù” e lungo i vicoli.
Alcune delle considerazioni svolte nella prima parte di questo itinerario appaiono particolarmente calzanti a un romanzo da poco apparso che sta conquistandosi meritate attenzioni e lodi, Uvaspina di Monica Acito (pp. 405, € 20, Bompiani, Milano 2023). Un romanzo drammatico ma con ampie, visionarie, urticanti concessioni al grottesco; un romanzo sicuramente mainstream, riccamente letterario e focalizzato su concretissimi rapporti tra personaggi umani – anche quando l’umanità si rattrappisce in buchi, vasci e palazzi fatiscenti, confinata dai suoi lividi – ma dove pure la componente fantastica non latita. In scena è un fantastico della carne, in tutte le accezioni possibili, e che piazza sul tavolo operatorio senza troppi complimenti non una macchina da cucire e un ombrello, ma le contraddizioni familiari, affettive, sociali e sessuali di un’intera città di corpi fradici e acidi di sigarette di contrabbando; una città che è la vera e propria protagonista – ben più del personaggio eponimo attorno al quale tutto ruota – in una giostra di amori e altri demoni echeggianti interi corpora di letture della giovanissima autrice (Rea, Di Giacomo, Serao, Marotta, La Capria, Ortese, ma anche il Basile… e poi tanti sudamericani). Una Napoli ctonia e crudelmente barocca dove i presepi lasciano spazio alla ceroplastica di Zumbo e neppure il viaggiatore Sade e la sua Juliette sarebbero a proprio agio: una Napoli pirotecnicamente eccessiva – lontana anni luce dalle due letture di successo popolare, la cartolina da commedia (magari amara, non si discute) da film con Totò, Loren e De Sica su una linea che arriva fino a Eduardo, e la Gomorra alla Saviano – e che spurga pulsioni e miti, incubi e odori nell’acqua sporca di un mare che “odorava di bestia cruda e bolliva come un pentolone di ragù” e lungo i vicoli.
Tanto più che la storia non ha il suo focus nella città popolare – benché Forcella vi trovi un ruolo importante – ma in quella altoborghese e negli strascichi borbonici di Chiaia, dove si è consumato il mostruoso dell’unione di Graziella la Spaiata, ex-chiagnazzara appunto di Forcella con l’amebotico notaio Pasquale Riccio: un accoppiamento in qualche modo contro natura che ha destinato entrambi a deriva e solitudine (riempite dalla prima con le sigarette di contrabbando e tanta frustrazione, dal secondo con sesso sciagurato e pasticci economici al Circolo Nautico di Posillipo) producendo due figli fragili. La seconda, Filomena detta Minuccia, frustratissima da un aspetto fisico non trascinante e dominata da crisi di rabbia feroci fino al sadismo, vede la propria instabilità caratteriale ipostatizzata dall’oggetto che porta sempre con sé, la trottola di legno nota popolarmente come strummolo; mentre il primogenito omosessuale, mite e faticosamente remissivo, Carmine detto Uvaspina per la “voglia a forma di chicco d’uva ma pallida come una luna, sotto l’occhio sinistro”, è segnato da un aspetto efebico che lo fa presto etichettare all’interno della categoria svilita ma miticamente aureolata dei femminielli. Straordinario il legame tormentoso, di amore/odio, tra Minuccia e Uvaspina, violento come solo tra fratelli può sbocciare. Possiamo stupirci se la svolta drammatica arriverà all’incontro fatale con il fascinoso, colto e profondo pescatore e tuttofare Antonio, dagli occhi di colore diverso come i due fratelli che prende a frequentare?
Su tale esordio tanto felice sono apparse in questi mesi, dall’uscita in febbraio, una quantità di belle recensioni, che l’hanno esplorato sotto vari aspetti: in questa sede, rinviando a esse per l’esame puntuale di altre componenti, mi pare interessante affrontarne la dimensione – si passi il termine – fantastica.
Partendo idealmente proprio dal contributo, Amaràvia, che era valso a Monica Acito il premio dei lettori al call “Oltre il velo del reale” 2021, bandito come detto dal Premio Calvino. Un racconto che già prefigurava idealmente il mondo immaginale di Uvaspina: là era in scena Amaràvia, una sorta di fata-uccello (alla Basile, ma memore di un retaggio da leggenda tardoantica, apuleiana o di altri visionari tardi come Filostrato o Flegonte) dal curioso ministero sessuale fino a sviluppi incestuosi molto serenamente evocati; qui personaggi altrettanto febbricitanti, a loro modo fatati – come appunto il femminiello della tradizione popolare, chiamato miticamente a partorire in riti che rimandano a un Mediterraneo ancestrale – e che nella reciproca scoperta contemplano fremiti di tutte le commistioni sessuali possibili, comprese quelle proibite, incestuose. Dove il sesso è linguaggio, esperienza del corpo nel relazionarsi con la realtà, furia e rabbia e definizione identitaria: nulla insomma di compiaciuto o pruriginoso, mai volgare, al massimo crudo quanto il resto del mondo.
Raccontava l’autrice in un’intervista la sua immersione da sempre nel bacino mitico-magico di Napoli, qualcosa che va ben oltre l’educato Ernesto de Martino: fino alla paradossale presa d’atto di non stupirsi più di una serie di istanze in apparenza sorprendenti. Dal romanzo non sappiamo se la magia funzioni in quanto tale – sembrerebbe di sì, in sede critica lasciamo sussistere un’incertezza alla Todorov – o se gli effetti attesi siano frutto di mera casualità: ma il lettore, come l’autrice, tende ad accettare senza traumi il nesso causale del sortilegio o del rito divinatorio. La stessa apertura al leggendario della città offerta dalla voce dell’affabulatore Antonio popola il romanzo d’ombre di regine e gran dame dal corteggio d’amanti spettrali che rende labile il concetto tra Storia e fiaba, impregnando in ultimo la stessa trama.
Un altro stigma del fantastico, alla luce di quanto detto, è il peso offerto a una religiosità dove il pagano ha un ruolo preponderante e trasfigura tutto; e un terzo elemento è quello – esso pure prefigurato in Amaràvia – della labilità delle barriere di specie o addirittura di regno (animale, vegetale, minerale). Se, come osservava Sara Passannanti in un’intervista all’autrice, la presenza degli animali (specie definite o meno) è richiamata in simboli e metafore in forma costante e quasi ossessiva, spesso si tratta di creature ibride, colte nella loro incertezza di statuto: sia per convulsioni metamorfiche (la chiagnazzara di Forcella che diventa un monstrum per Chiaia), sia per ibridazioni (come quella che ha prodotto i due “mostruosi” fratelli). Impossibile non pensare all’ibrida sirena Partenope associata alla città o a certe liturgie arcaiche con danzatori dal viso truccato in due diverse metà, da uomo e da donna – il femminiello mantiene nel suo status le connotazioni rituali di simili Misteri – ma l’ambiguità non può esaurirsi nella specie umana. Se Napoli rimanda a un animale, un gigantesco polpo, e i suoi palazzi a bestie, Uvaspina evoca il mondo vegetale attraverso il richiamo a un frutto introvabile in quanto tale a Napoli, ma da spremere per contenere il dolore altrui.
Però più ancora che nella trama o nei personaggi il fantastico erompe nella lingua ferina e visionaria usata dall’autrice: un registro di febbri allucinatorie, di metafore immansuete, di figure grottesche o oniriche che lei stessa ammette di aver dovuto in parte arginare, con immagini che emergono come bolle d’acqua sulla superficie di uno stagno torbido – segno di qualcosa che borboglia al di sotto. Un sobbollire cui il lettore assiste dalla riva, interrogandosi sulla fermentazione di un dolore sommerso: una provocazione che rende il romanzo molto più sapiente e meditabondo di quanto la lettura di un esordio di successo possa spesso suggerire.
(2. continua)



