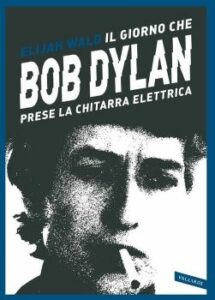di Diego Gabutti
In passato non ero mai stato troppo appassionato di libri e scrittori, ma mi piacevano le storie. Storie come quelle di Edgar Rice Burroughs, che aveva scritto di un’Africa mitica. Luke Short e i suoi mitici racconti western, Jules Verne e H.G. Wells erano stati i miei preferiti, ma era accaduto prima che scoprissi i cantanti folk. Che in una canzone racchiudevano un libro intero, tutto in poche strofe. (Bob Dylan, Chronicles. Volume 1)
Elijah Wald, Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica, Antonio Vallardi Editore, Milano 2022, pp. 370, 18,90 euro, eBook 11,99 euro.
Dylan a Newport con un nuovo look e una chitarra elettrica: incoronato re del folk, Dylan mette in chiaro che il suo sogno è diventare re del rock’n’roll. Nasce un tumulto.
È un evento originario, tramandato attraverso i decenni dai «boomers» che furono adolescenti negli anni sessanta, l’età dei diritti civili e del flower power. E come tutti gli eventi originari è falso, o parecchio esagerato, come illustra e racconta Elijah Wald nel suo Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica, una splendida e appassionante visita guidata all’ouverture dei sixties.
È il 25 luglio del 1965. Newport, Rhode Island. È qui che dal 1959, ogni estate, si tiene il Newport Folk Festival, dedicato a canti etnici, antiche ballate importate dall’Europa in tempi remoti, blues tradizionale, gospel, canzoni socialiste e proletarie, qualche timido excursus nel «folk pop», come lo chiamano, cioè nel folk commerciale, che ha cominciato a scalare l’hit parade: Tom Dooley del Kingston Trio, If I Had a Hammer e Where Have All the Flowers Gone di Peter, Paul and Mary.
Sono canzoni impegnate, legate al movimento antisegregazionista e alla sinistra americana. Pete Seeger, il creatore del festival, ha scritto gli hit di Peter, Paul and Mary e nei primi cinquanta ha importato dall’Africa The Lion Sleeps Tonight, o Wimoweh, una canzone che lo ha reso ricco (mentre Solomon Linda, l’autore della canzone, un musicista zulu, muore nel 1962 in miseria, e ci vuole una sentenza di tribunale per risarcire gli eredi). Seeger è stato anche membro del partito comunista ed è finito in lista nera. Veste dimesso, e se la tira da santa canaglia, ma ha «studiato a Harvard» e, come gli ricorda sua moglie: «Non sei un operaio, fai solo finta, e lo vedono tutti». Lui non se ne dà per inteso: pugno chiuso, camicia a scacchi e canzonette engagé. Due anni prima, nel 1963, a nome del Newport Folk Festival ha incoronato fenomeno del folk il giovanissimo Bob Dylan. Questi è salito sul palco in look (anche lui) da classe operaia imbracciando una chitarra acustica, l’armonica fissata al collo da un supporto subito entrato nella leggenda, e ha intonato canzoni che non saranno più dimenticate: Blowin’ in the Wind, A Hard Rain’s a-Gonna Fall, Don’t Think Twice, It’s All Right, Masters of War.
Ma ecco che due anni dopo Dylan si presenta a Newport in costume rockettaro stretto: «giacca di pelle lucida sotto i fari del palco, una camicia color salmone abbottonata fino al collo, jeans neri e stretti che gli fasciano le gambe sopra gli stivali a punta da cowboy, neri anch’essi». Imbraccia una chitarra «Stratocaster sunburst a due colori». Una chitarra elettrica. Sul palco, con lui, una band improvvisata di bluesmen di Chicago: chitarristi sparsi, qualche amico, Paul Butterfield e alcuni musicisti della sua Blues Band (che ha esordito, qualche mese prima, con Born in Chicago, una canzone che comincia così: «Sono nato a Chicago nel 1941 / Mio padre mi ha detto: “Figliolo, ti conviene prendere una pistola”»). Intorno, amplificatori, cavi elettrici, riflettori. Diranno poi che, venuto per ascoltare Bob Dylan cantare che «una dura, dura pioggia cadrà», e quel giorno è effettivamente piovuto per ore, il pubblico del Newport Folk Festival, bagnato fradicio, i piedi nel fango, s’è ritrovato davanti uno sconosciuto. Sguardo cattivo, modi strafottenti, chiaramente «stoned» di chissà che, una mise da damerino di Carnaby Street.
E via con l’evento originario: «Le luci sono puntate su di lui, solo al centro del palco, mentre i musicisti alle sue spalle iniziano a suonare avvolti dal buio. Ascolta per un momento, sente la forza della band, quindi s’avvicina al microfono e canta un singolo verso: “Alla fattoria di Maggie non ci lavoro più!” Fa un passo indietro, lascia che il grande chitarrista Mike Bloomfield risponda con un fraseggio di chitarra, si lascia trasportare dal ritmo ancora per un momento, poi torna al microfono e ripete la frase. Bloomfield risponde di nuovo, e ancora una volta lui ascolta per un istante prima d’irrompere con la prima strofa: «Mi sveglio la mattina, giungo le mani e prego perché piova / Le idee che mi frullano per la testa mi fanno impazzire». Yarrow sta accovacciato dietro ai musicisti, sistema i cavi apportando piccole regolazioni agli amplificatori. Bloomfield è alla destra di Dylan, avvolto dal buio e illuminato solo momentaneamente dal flash dei fotografi. La voce di Dylan si alterna ai fill secchi e ruvidi del chitarrista. Tra una strofa e l’altra, Bloomfield suona liberamente, senza attenersi a parti scritte in precedenza. Dalla sua chitarra escono urla stridenti, bassi tonanti e grappoli di note dissonanti, che si chetano ogni volta nel riff ripetitivo che annuncia il successivo ingresso di Dylan. Il suo non è un semplice accompagnamento: duella con Dylan, sfidandolo e incoraggiandolo a proseguire. Il cantante ulula l’ultimo verso: “Faccio del mio meglio per essere me stesso / ma tutti vogliono che sia come loro”».
È una metamorfosi, pensano i dylaniani della prima ora: il profeta beatnik di The Times They Are A-Changin’ ha saltato il fosso. Si è venduto, è passato al pop. Esultano invece i nuovi dylaniani: basta con le lagne sdolcinate del folk, basta con le canzoni sociali, finalmente l’introspezione, evviva Rimbaud, sex revolution, marijuana!
Non è vero, come racconta Elijah Wald nel suo libro, ma si racconta (e si racconterà ancora a lungo) che Pete Seeger, urlando «basta con questo rumore», si sia avventato sui cavi degli amplificatori mulinando un’ascia, come uno di quei boscaioli del Vermont che invita al festival insieme ai suonatori di banjo, di ukulele, di kazoo e a tutti quegli artisti che suonano «la vera musica del proletariato». Anche lui, nelle sue memorie, lascerà credere d’aver trasceso: nessuno rinuncia al suo cammeo, per quanto sgradevole, nella storia del mondo. Ma anche se non ci sono state scene madri, e Seeger si è limitato a soffrire in silenzio, qualcosa è successo davvero. Aveva ragione il vecchio Dylan: i tempi stanno davvero cambiando.
Dai diritti civili si sta passando ai diritti umani; dalle cause sociali a quelle del singolo, dell’individuo. È il grande ritorno del rock’n’roll, la cui stella era tramontata con l’eclisse di Elvis Presley, trasformato in star hollywoodiana e crooner di Las Vegas (ma anche nel saltafosso da Be-Bop-A- Lula e Mistery Train a Love Me Tender e Viva Las Vegas Presley rimane Presley, un principe). John Lennon e Paul McCartney stanno cambiando la vita della gioventù europea e americana con le loro melodie perfette e l’eleganza dada del loro look. Altrettanto innovativi, ma decisamente meno iconici, sono i CCR, per esteso Creedence Clearwater Revival, una band californiana che fonde il country con il blues e il rock’n’roll. Comincia l’età del rock duro e adrenalinico, poi psichedelico, presto anche del punk, dei Velvet Underground, del rock en travesti di David Bowie. Dylan è uno di loro, e il più bravo di tutti. Come canta in un altro dei suoi nuovi hit, Subterranean Homesick Blues, lui non «ha bisogno d’un meteorologo per sapere da che parte tira il vento».
Perché è di questo, ribadiamolo, che si tratta: dei tempi che cambiano. Non sono i Beatles o gli Stones né Dylan a cambiare il mondo, come qualcuno dirà in seguito, ma le loro canzoni sono l’inconfondibile colonna sonora del cambiamento, un’apocalisse dei costumi che coglie tutti di sorpresa, Dylan compreso. Ma il ragazzo è sveglio e si lascia portare dall’onda. A Newport, nel 1965, si volta pagina, nel bene e nel male. Non solo Dylan, ma almeno metà dei musicisti presenti sono passati, da un pezzo, alle chitarre elettriche.
«Non fu piacevole», racconta Wald, «ma fu di gran lunga meglio delle scontate declamazioni dei progressisti da manuale». A Newport, tutti erano abituati a essere accolti e coccolati, a sentirsi circondati da menti affini. «L’unico a mettere in dubbio la nostra posizione è stato Dylan. Forse non l’ha fatto nel migliore dei modi. Forse è stato maleducato. Ma ci ha dato una scossa. Questo è il ruolo dei poeti e degli artisti».