di Franco Pezzini
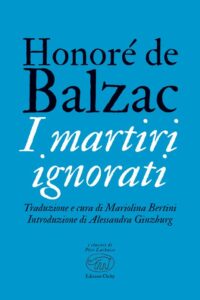 Honoré de Balzac, I martiri ignorati, trad. e cura di Mariolina Bertini, introd. di Alessandra Ginzburg, pp. 126, € 14, Clichy, Firenze 2022.
Honoré de Balzac, I martiri ignorati, trad. e cura di Mariolina Bertini, introd. di Alessandra Ginzburg, pp. 126, € 14, Clichy, Firenze 2022.
Le mie riflessioni mi mostravano un immenso difetto delle leggi umane, una lacuna spaventosa, quella riguardante i delitti puramente morali [in termini odierni potremmo dire psicologici] contro i quali non esiste alcuna repressione, delitti che non lasciano traccia, inafferrabili come il pensiero. Scorsi un’infinità di vittime invendicate, scoprii gli orribili supplizi inflitti alle anime miti dalle anime dure all’interno delle famiglie, nel più profondo segreto, supplizi ai quali soccombono tante creature innocenti. Pensai che agli occhi del filosofo l’assassino di strada, che viene condotto così pomposamente al patibolo, era meno colpevole, nei suoi traviamenti, di tanti uomini che torturano con parole crudeli; che, dopo aver scoperto, in certe anime, i punti che la nobiltà, la grandezza, la religione rendono vulnerabili, vi affondano ad ogni istante le loro frecce…
Proprio questa chiave, nell’allucinata visione finale, offre al breve scritto di Balzac in esame il senso del titolo, a partire da vicende che l’autore conosce fin dalla carne della propria famiglia – si torni a quanto detto su Wann-Chlore (edito dallo stesso editore, pure tradotto con la solita eleganza da Mariolina Bertini e riccamente introdotto da Alessandra Ginzburg): vicende che in fondo conosciamo benissimo anche noi. Crimini ai danni di chi è più sensibile corrono del resto nel tessuto di un po’ tutta la Commedia umana e nei testi precedenti dell’autore: qui si offre una sorta di riflessione teorica o nota in calce a tutto il resto. Il che già rappresenta un motivo d’importanza-cardine dell’opera; ma, si vedrà, ce ne sono altri.
I martiri ignorati – che sboccia nel 1837 da una bozza definita “una selva druidica di cancellature” – non è una narrazione in prosa distesa come Wann-Chlore, ma un vivacissimo dialogo similteatrale nell’ultima sala del Café Voltaire su Place de l’Odéon, ambientato nel dicembre 1827 (nella prima versione, due anni prima). Il Café è un luogo privilegiato d’incontro di uomini di scienza, e infatti il discorso sulla natura del pensiero, a inanellare godibilissimi racconti neri (la formula può ancora ricondursi, in fondo, a provocazioni gotiche con tanto di paranaturale), è condotto in termini scientifici – in un’accezione d’epoca. A discutere al tavolo dei filosofi, come viene definito, sono due medici (l’anziano, pittoresco mesmerista Phantasma con il suo “cappello di seta da undici franchi in costante stato di orripilazione”, e un giovane, Physidor, affascinato da frenologia e follia), il matematico, chimico e inventore lituano Grodninsky, il sarcastico poeta tedesco Tschoërn che crede nelle apparizioni, il dandy irlandese Ormond tisico e infetto da una malattia venerea, un libraio-editore emblema di una categoria da cui Balzac si sente sfruttato e quel giovane scrittore Raphaël della Pelle di zigrino – qui ventitreenne – che idealizza modicamente l’autore. Aggiungiamo alcuni studenti che ronzano in giro e un assonnato cameriere.
Il testo presenta dunque, ovviamente, grande interesse per i lettori di Balzac, che qui vedono emergere il tessuto delle sue frequentazioni filosofiche e scientifiche: dalla matematica alla chimica, agli studi su follia, frenologia e fisiognomica. Ma anche al di là dello specifico di formazione dell’autore, il testo è di enorme fascino per il panorama di un’epoca in cui scienza e magismo vanno ancora a braccetto nel tentativo di laicizzare una serie di concetti sul linguaggio dell’interiorità: basti dire che l’opera doveva incardinarsi nell’ambito di un nuovo Fedone sul tema dell’immortalità dell’anima (il tema è rimasto nel sottotitolo originale, Frammento del Fedone d’oggigiorno, ecco il senso della forma a dialogo). Lo sviluppo tratta un tema specifico, il pensiero, la sua materialità e le sue potenzialità distruttive: e nel teatro del dibattito troviamo evocati in modo diretto o indiretto Cuvier – l’uomo che saprebbe ricostruire uno scheletro animale partendo da un frammento – e il suo avversario Geoffrey Saint-Hilaire, ma anche Mesmer, Swedenborg con le sue corrispondenze (qui “concordanze”), “il filosofo sconosciuto” Saint-Martin, Thomas Moore (tanto importante in Wann-Chlore), Pierre-Simon Ballanche, il matematico polacco Hoëné Wronski, lo stesso Hoffmann (“Il ricordo di quel genio mi emoziona”, se ne esce Tschoërn) i cui racconti stanno al tempo conquistando la Francia. Il monismo di Balzac ondeggia di continuo tra materialismo e spiritualismo (con echi ironici dell’accanito dibattito al tempo), ma il clima è lo stesso in cui la Physiologie du système nerveux del Georget (1821) cita tra gli effetti della paura apoplessia, paralisi, morte subitanea: e desolazione & paura costituiscono la prima chiave offerta nella casistica della conversazione, attraverso l’episodio crudele e grottesco, vagamente sadiano, della povera moglie del signor Bouju – che qui non si racconta per non spoilerare.
Si passa poi al tema della follia scatenata da una serie di scherzi sul tema dei capelli in un soggetto tragicamente calvo e monomaniaco, un portinaio ex-giacobino, con manie di grandezza e frustrazioni di pari intensità; e quindi di nuovo agli effetti della paura, con la beffarda punizione – dai risvolti tragici – inferta da un gruppo di studenti del Trinity College di Dublino a un cattivissimo inserviente.
Quindi Tschoërn presenta la storia di un chimico eccentrico che fa esperimenti col pensiero, una sostanza “analoga all’elettricità, ma più sottile”: e Physidor sottolinea la pericolosità della medesima, prima di trattare l’episodio culminante dell’opera, sul suo incontro con un vecchio medico in dialogo coi morti. E che, esaltando il magismo (“da non confondere con la magia”), riassume il potere del pensiero.
Il pensiero è più potente del corpo, lo mangia, lo assorbe e lo distrugge; il pensiero è il più violento di tutti gli agenti di distruzione, è il vero angelo sterminatore dell’umanità; la uccide e la vivifica, perché il pensiero vivifica e uccide […] Pensare, ragazzo mio, è aggiungere fiamma al fuoco […] Le passioni, i vizi, le occupazioni estreme, i dolori, i piaceri sono torrenti di pensieri.
Si tratta di ciò che lo psicanalista cileno Matte Blanco definirà pensieri dell’emozione, frutto di intensità emotiva non contenuta: e i pittoreschi casi presentati dal vecchio medico riguardano persone con convinzioni inalienabili (a volte emozioni umanissime, altrove fisime) uccise alla scoperta della frustrazione definitiva di queste.
Ma ancora: al di là del grande spaccato culturale, quel che colpisce è il gustosissimo sapore letterario della narrazione, un ping-pong di affabulazioni scintillanti tra il sinistro e il grottesco (il riferimento al gotico non sembra inopportuno). I personaggi descritti fanno pensare alle maschere alla Hoffmann, alla Il clan del terrore e per certi versi (Balzac ci perdoni) alla squadra di Amici miei con le loro atroci zingarate: l’episodio della moglie di Bouju è per esempio un gioiello, e così quello sulla beffa al portinaio; magnifico, fin dalla cornice descrittiva, è l’incontro con il vecchio medico in caduta libera.
E in ultimo, ma siamo partiti di qui per chiarire il senso del titolo, ne resta la provocazione fondamentale: non occorre attribuire al pensiero una fantomatica natura di fluido, per considerare come un certo tipo di violenze psicologiche abbia a che vedere con lo stupro e magari con l’assassinio. Qui il termine mobbing è ovviamente sconosciuto, ma il concetto può ben starci: gestito che sia da piccoli burocrati d’azienda o dirigenti orrendi, oppure – pari grado – da colleghi-kapò di libido aziendalista e insospettate insensibilità. Mentre in primo piano tornano i crimini psicologici consumati in famiglia: e Balzac sa cosa scrive, pensando alla sorella Laurence, morta a solo ventitré anni, consumata dalla disperazione per un matrimonio voluto dai genitori, e che si era rivelato spaventoso.
Poco importa che, per fortuna, non si tratti della nostra famiglia: ma quante volte incontriamo figlie (più che figli, benché nell’Italia ancora patriarcale non manchi neppure quella variabile) vittime – ancor oggi – di vecchi tiranni fascistoidi pronti a decidere sulla loro vita profonda, di madri algide prone a sacrificarle ai diktat paterni o invece pervicacemente decise a farne in proprio schiave prive di esistenza. In questione non sono gli affetti e neppure l’esigenza sacrosanta di un rapporto solidale tra generazioni, ma il suo abuso consolidato in troppi casi nell’Italietta familista: padri-padroni, madri che usano strumentalmente limiti fisici anche oggettivi (secondo modelli ben studiati da Bram Dijkstra per l’arte tra Otto e Novecento, sull’immagine socialmente garantita della grande degente), gli uni e le altre pronti a brandire la carta patriarcale del senso di colpa nel coretto da strapaese di approvazione comunitaria: “tanto una brava famiglia”… Con il risultato che la vittima, se non riesce a recuperare in termini armonici – coi relativi paletti, perché i tiranni non li convinci con la ragione e solo le giuste distanze permettono di scamparla – lentamente muore dentro, e a volte anche nel corpo.
Chi pensi che tutto ciò oggi sia socialmente superato pecca di grossolana, criminale distrazione e non sa quali casi arrivino di continuo ai terapeuti; non sa quali casi giungano a chi semplicemente riservi alle persone attorno, sia pure in una desolata impotenza, un minimo sindacale di attenzione e di ascolto. Una resistenza al mondo orrido che abbiamo attorno parte di lì: e al netto di qualunque stereotipo sulla damsel in distress, recuperare un certo linguaggio gotico come provocazione sociale non sembra affatto inutile.



