di Gioacchino Toni
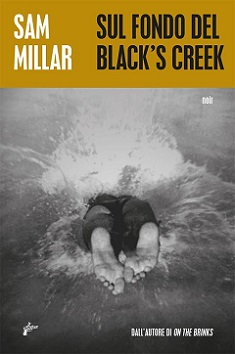 Sam Millar, Sul fondo del Black’s Creek, traduzione di Seba Pezzani, Milieu edizioni, Milano, 2022, pp. 268, € 17,90
Sam Millar, Sul fondo del Black’s Creek, traduzione di Seba Pezzani, Milieu edizioni, Milano, 2022, pp. 268, € 17,90
“La scienza, caro ragazzo, è fatta di errori, errori che però è utile fare perché, poco alla volta, portano alla verità”. Con questa citazione tratta da Viaggio al centro della Terra di Jules Verne si apre il romanzo di Sam Millar, Sul fondo del Black’s Creek (Milieu, 2022). Oltre alle vicende narrate dal romanzo, con tali parole l’autore sembra alludere alla sua vita turbolenta in cui di errori ne avrà sicuramente commessi parecchi, come del resto capita a tutti coloro che non si accontentano di sopravvivere, magari voltandosi dall’altra parte mandando giù qualsiasi cosa.
Sam Millar è uno scrittore e sceneggiatore di Belfast proveniente da una famiglia working class, con un passato nell’Ira e otto interminabili anni di carcere duro alle spalle. Le sue prime opere letterarie sono ambientate in una Belfast impregnata di ingiustizie sedimentatesi nel tempo come il lerciume tra i mattoni con cui è costruita la città e il lezzo di sudore e birra che impregna i malandati arredi e la moquette dei pub, un lezzo che non riesce a coprire quell’odore di sangue, sofferenza, paura e solitudine che Millar fiuta e descrive come pochi altri.
A far conoscere lo scrittore in Italia è stato On the Brinks. Memorie di un irriducibile irlandese (Milieu, 2016) [su Carmilla], memoir in cui ricostruisce una parte importante della sua vita trascorsa prima tra le strade di Belfast e il carcere di Long Kesh, poi negli Stati Uniti, ove la militanza per la causa nord irlandese lascia il posto a una mirabolante rapina restata nella storia nonostante le cose non siano andate come aveva auspicato.
Pochi anni dopo arriva in Italia I cani di Belfast (Milieu, 2019) [su Il Pickwick], opera che sin dalle primissime pagine sbatte violentemente chi legge in una cava di Belfast, sul finire degli anni Settanta, di fronte a una donna brutalmente seviziata che sta per essere assalita da un branco di cani randagi. La Belfast di Millar è descritta in maniera cruda e disturbante, un po’ come la Londra di Derek Raymond nel grandioso ciclo della Factory e la Berlino di Miron Zownir [su Carmilla]. Con I cani di Belfast – che Millar dice di aver scritto traendo ispirazione dall’irlandese Walter Macken e dallo statunitense Cormac McCarthy – i lettori italiani fanno conoscenza dell’investigatore Karl Kane, protagonista di storie destinate ad essere presto tradotte.
Venendo a Sul fondo del Black’s Creek, il racconto si apre con i titoli di un quotidiano che, nell’annunciare la riapertura di una vecchia storia che ha sconvolto la comunità di una piccola cittadina dello stato di New York, fanno sobbalzare, durante la colazione, un uomo che nel leggere di ciò si sente travolto dalle tenebre di un passato che lo vede in qualche modo coinvolto in un omicidio che sembra improvvisamente rifare capolino nella sua vita e in quella dell’intera comunità, anche se, in realtà, questo passato non se ne era mai del tutto andato.
L’improvviso riemergere del passato, dopo due decenni di ricorso all’oblio, non solo svela a chi ebbe un ruolo di primo piano in quei tragici eventi – e ai lettori – il peggio di un’epoca lontana, coincidente con l’adolescenza dei protagonisti, ma palesa anche quanto il periodo intercorso tra quelle vecchie storie e l’attualità sia stato disgustoso e ipocrita.
La vicenda che torna a galla ruota attorno a un gruppetto di ragazzini desiderosi di trovare un colpevole a tutti i costi per la morte di un amico derubricata, nonostante i dubbi, come “semplice” suicidio: il dodicenne si sarebbe insomma inspiegabilmente lasciato annegare nelle acque del lago locale senza un apparente motivo.
Nonostante il generoso tentativo di salvarlo di uno degli amici, il piccolo Joey si è congedato dalla sua breve vita nell’incapacità degli adulti di individuare qualcuno a cui imputare la colpa di averlo direttamente o indirettamente indotto al gesto estremo. Questi ragazzini, che hanno imparato presto a non fidarsi degli adulti, decidono di vendicare la morte dell’amico castigando chi si dicono convinti – come del resto molti in città – abbia spinto l’amico dodicenne al darsi la morte.
Sono tanti i narratori – si pensi anche solo ad autori del calibro di Joe Lansdale e Stephen King – che hanno raccontato come sotto le placide apparenze delle cittadine statunitensi di provincia spesso si nasconda un inferno di soprusi e violenze. Anche l’apparentemente tranquilla cittadina dello stato di New York di cui narra Millar evidentemente tanto tranquilla pare non essere mai stata.
Miscelando abilmente noir e romanzo di formazione, anche lo scrittore irlandese restituisce ciò che si cela sotto la placida apparenza di una piccola comunità tra le cui pieghe si sono accumulati abusi sessuali e omicidi. Se gli occhi ingenui dei ragazzini spesso sanno cogliere meglio degli adulti il marcio del mondo, a volte, al pari di questi, sanno però farsi feroci fino all’estremo. Tutto al loro sguardo si fa iperbolico, nel bene e nel male, nel cogliere quello che gli adulti non sanno o non vogliono vedere, o nel muoversi spietatamente, proprio come i grandi.
È forse proprio a partire da questi occhi vivaci votati agli eccessi, che non hanno paura di guardare e giudicare, occhi liberi da ipocrisie e convenienze che forse si possono guardare le cose e le persone per quello che sono.
La riapertura del caso, a un paio di decenni di distanza dai fatti, fornirà nuovi indizi utili a indagare anche su altri delitti restati irrisolti. Conviene non aggiungere ulteriori dettagli per non rovinare la lettura che pagina dopo pagina ricompone un mosaico capace di mostrere immagini inattese. Quando si smuovono le acque più torbide il marcio torna a farsi vedere e persino gli errori, di cui si diceva in apertura, possono servire per avvicinarsi un po’ di più alla verità per quanto dolorosa essa sia.



