di Sandro Moiso
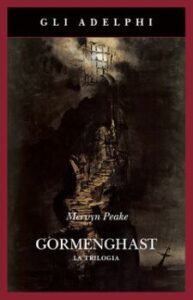 Mervyn Peake, Gormenghast. La trilogia, Adelphi Edizioni, Milano 2022, pp. 1170, euro 28,00
Mervyn Peake, Gormenghast. La trilogia, Adelphi Edizioni, Milano 2022, pp. 1170, euro 28,00
«Senza Tito, il castello non avrà un futuro, quando io non ci sarò più. Devo ricordarvi che spetta a voi, come sua balia, instillare in lui fin da ora l’amore per il castello dove è nato e di cui è l’erede e il rispetto per tutte le leggi, scritte e non scritte, che regolano il mondo dei suoi avi […].»
«Ma non ha che due mesi, povero cosino!» interruppe la balia con voce di pianto.
[…] «E ora fammi vedere mio figlio» disse il Conte, lentamente.
«Mio figlio Tito. È vero che è brutto?» (Tito di Gormenghast – Mervyn Peake)
E’ un paesaggio a dir poco desolato quello che circonda il castello dei Conti de’ Lamenti, dominato dall’aspro e altissimo monte Gormenghast e costituito da lande in cui dominano la polvere e la pietra oppure terreni paludosi sconfinati e in cui la vegetazione è costituita da cactus, foreste di rovi impenetrabili e boschi di alberi ritorti e minacciosi. Lo stesso castello millenario che prende il nome dal monte soprastante sembra costituire, con la sua struttura labirintica e tentacolare definita da secoli di bizzarrie architettoniche volute da settantasei generazioni della stessa famiglia nobiliare, una diretta emanazione e continuazione delle rocce e delle cavità che caratterizzano la montagna.
Gli abitanti del gigantesco maniero sono tutti grotteschi nelle movenze e nell’aspetto, sia che si tratti dei rappresentanti della aristocratica famiglia che dei servitori. Storpi, magrissimi, gobbi, grassi oltre ogni dire, deformi oppure dotati di nasi lunghissimi e volti equini. Portatori, tutti, delle stimmate del proprio egoismo incise nelle posture assunte e nel fisico. Il conte Sepulcrio e la gigantesca contessa Gertrude, la figlia pre-adolescente Fucsia e le zie gemelle, sorelle del conte, Clarice e Cora; la piagnucolosa balia settuagenaria Mamma Stoppa, il segaligno e torto (nel corpo e nell’animo) maggiordomo Lisca, il grasso sadico e perverso capo-cuoco Sugna, il dottor Floristrazio e la sorella Irma, insieme all’autentica anima nera rappresentata dal giovane Ferraguzzo, ragazzo di cucina che grazie alla sua mente perspicace e freddamente calcolatrice scala le più infide e infime trame delle gerarchie di un mondo che non vuole conoscere e riconoscere altro da sé. Tutti intenti a danzare un mostruoso e sgraziato minuetto ritmato da regole e leggi, riti e doveri improbabili che soltanto il vecchissimo Agrimonio, maestro di cerimonie, e successivamente il figlio Barbacane, zoppo e perennemente in guerra con tutti coloro che lo circondano, conoscono e dettano quotidianamente. Al Conte e a tutta la servitù.
Ma anche gli abitanti del piccolo e malsano borgo che si è sviluppato vicino alle pareti e alle rocce del castello non sono da meno. L’unica loro attività sembra essere quella di intagliatori di sculture di legno, attività artigianale riservata esclusivamente agli individui di sesso maschile che viene valutata annualmente dal Conte stesso e premiata con l’esposizione delle opere migliori in una galleria dimenticata del castello, e mai visitata da nessuno, custodita dal sonnolento e indolente Stoccafisso. Uomini e donne del borgo conservano però una certa grazia e bellezza fino al compimento del diciannovesimo anno di età, momento in cui la pelle incartapecorisce e la bruttezza della vecchiaia prende il posto dell’aura della giovinezza.
Tra gli stessi non vi è nessuna forma di comunitarismo, se non quello rappresentato dalla dipendenza dal castello e dai suoi nobili proprietari. Anzi la rivalità, sul piano artistico e personale può raggiungere livelli di odio e violenza abissali. Come dimostra la vicenda di Keda la, momentaneamente, bella e giovane vedova del più famoso, e vecchio, scultore del borgo senza nome, divisa tra l’amore per due giovani e abili intagliatori rivali, Rantel e Braigon. Un triangolo amoroso destinato ad una drammatica e sanguinosa conclusione. Anche se una bimba, partorita in seguito da Keda, ne rappresenterà il frutto dopo la tragica scomparsa dell’ormai invecchiata madre.
Nella Presentazione anteposta all’attuale edizione italiana della trilogia, Anthony Burgess1 avverte i lettori che «sarebbe pericoloso scandagliare troppo a fondo in Titus Groan (Tito di Gormenghast nella traduzione italiana – NdR) alla ricerca dell’allegoria. Esso rimane sostanzialmente il frutto di una fantasia chiusa in se stessa dove l’evocazione di un mondo parallelo al nostro è condotta con uno spessore di dettagli quasi paranoico»2.
Eppure, eppure…
 Forte rimane la tentazione di interpretare il gotico sogno di uno scrittore, Mervyn Peake (1911- 1968)3, tormentato per gran parte della vita da depressioni e crisi che lo avrebbero progressivamente portato all’irreversibile malattia mentale e alla morte, in chiave simbolica e allegorica, anche perché la monumentale trilogia del “mondo” di Gormeghast e il suo giovane principe Tito, può davvero essere considerata come uno degli enigmi della letteratura fantastica del Novecento. Il cui motivo del contendere non è offerto soltanto dalle numerose e svariate interpretazioni che è possibile dare di un testo che considerare labirintico è ancora troppo poco e la cui scrittura dipinge sotto gli occhi del lettore strati su strati di situazioni rinviabili ad infiniti tòpoi, personaggi e situazioni della letteratura gotica, grottesca o orrorifica.
Forte rimane la tentazione di interpretare il gotico sogno di uno scrittore, Mervyn Peake (1911- 1968)3, tormentato per gran parte della vita da depressioni e crisi che lo avrebbero progressivamente portato all’irreversibile malattia mentale e alla morte, in chiave simbolica e allegorica, anche perché la monumentale trilogia del “mondo” di Gormeghast e il suo giovane principe Tito, può davvero essere considerata come uno degli enigmi della letteratura fantastica del Novecento. Il cui motivo del contendere non è offerto soltanto dalle numerose e svariate interpretazioni che è possibile dare di un testo che considerare labirintico è ancora troppo poco e la cui scrittura dipinge sotto gli occhi del lettore strati su strati di situazioni rinviabili ad infiniti tòpoi, personaggi e situazioni della letteratura gotica, grottesca o orrorifica.
L’impressione che se ne ricava a prima vista è di una scrittura ‘gotica’, ma il termine è inadeguato. Leggendo Titus Groan abbiamo l’impressione di imbatterci, a ogni piè sospinto, in indizi che potrebbero portarci a intravvedere la luce di un genere letterario, ma ogni volta finiamo col dover riconoscere che la pista è falsa. Prendiamo i nomi dei personaggi: tutti starebbero benissimo in un romanzo di Dickens o in un racconto umoristico per bambini. Nomi comici, dunque, ma di una comicità che rifiuta sia la facile risata sia la levità del fantastico: la massiccia corposità architettonica tiene tutto ben ancorato a terra e, a dispetto dei nomi, il lettore dovrà prendere i personaggi molto sul serio4.
E la stessa difficile collocazione dell’opera (Fantasy? Gotica? Diario indiretto di una “lucida” e progressiva follia? Espressione del malessere di un secolo, il Novecento, che già Kafka aveva anticipato?) a costituire una parte dell’enigma. Difficoltà data sia dalla sua struttura che dal progressivo peggioramento delle condizioni della salute mentale del suo autore sia, ancora, dal suo inserimento in un catalogo, quello di Adelphi, voluta da Roberto Calasso, un intellettuale magmatico e controverso, che nel corso di un cinquantennio ha fatto conoscere ai lettori italiani titoli e autori, spesso osteggiati da altri editori oppure dalle consorterie politico-culturali cattoliche e tardo zdanoviste o, ancora, fasciste.
Autori che spesso praticavano una letteratura di carattere fantastico, passando per il noir, la fantascienza di Theodor Sturgeon, la letteratura americana del Sud immaginato e descritto da William Faulkner, le opere di Antonin Artaud e Nietzche, la Mitteleuropa di Joseph Roth e Karl Kraus, le grandi mitologie e religioni, il nichilismo e i testi iniziatici (o supposti tali). Un direttore e un indirizzo editoriale che è stato sempre poco amato, se non apertamente osteggiato, sia dalle correnti estreme della Destra politica e cattolica che dalla Sinistra osservante dell’ortodossia più dogmatica e d’antan.
Lasciamo, però, ancora una volta che a parlare sia Anthony Burgess:
Titus Groan, primo volume di una trilogia, apparve nel 19465. L’autore aveva trentacinque anni. Le reazioni dei critici furono assai favorevoli, in alcuni casi addirittura entusiastiche. Le avventura del protagonista e l’elaborazione del suo mondo proseguirono in Gormenghast (1950)6 e in Titus Alone (1959)7 i quali però, benché ammirevoli, non erano destinati ad avere la stessa risonanza del primo romanzo: il 1946, anno dell’austerità, era quanto mai ben disposto verso i banchetti a base di fantastico. Ma il successo di critica non significò un vasto successo di pubblico. Titus Groan fu idolatrato, ma solo da pochi fedeli. Il nome di Peake viene citato di rado nelle storie del romanzo contemporaneo.
[…] Peake si è attirato lodi, ma anche sospetti. Le sue opere in prosa non sono di facile classificazione, possiedono la stessa individualità degli scritti di, poniamo, un Peacock o un Lovecraft8.
Sospesi tra le atmosfere delle opere di Franz Kafka (dalla Metamorfosi a Il processo oppure Il castello) e, a tratti del teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e Ionesco, dando vita ad un universo in cui non esistono il Bene e il Male e nemmeno un Dio, ma in cui a valere sono soltanto i riti, le tradizioni e le regole che si tramandano di generazione in generazione, divenendo sempre più assurde e incomprensibili ma pur sempre irrinunciabili per i detentori del Potere e il suo mantenimento, i tre romanzi di Mervyn Peake potrebbero costituire per chi, come il sottoscritto, non ha mai particolarmente amato l’opera di Tolkien, una valida alternativa al Signore degli Anelli, altra monumentale trilogia della letteratura fantasy e fantastica.
A far da contraltare all’opera di J. R. R. Tolkien può contribuire il fatto che in quella di Peake l’eroe è quasi del tutto assente o, perlomeno, al termine del primo romanzo non ha ancora compiuto il secondo anno di età, costituendo per le quattrocentosessanta pagine che lo compongono più un oggetto della storia narrata che il soggetto. Ancor di più, però, a fare del Gormenghast un’alternativa al Lord of the Rings contribuisce il fatto che mentre nel secondo gli eroi devono riportare o ricostruire l’ordine sconvolto dal ritorno di Sauron e del Male che rappresenta, nel primo è proprio l’invadenza e il predominio dell’ordine dato a costituire la causa del disagio e dello scontro tra i diversi interpreti del dramma.
Il mondo di Gormenghast, a differenza della Terra di mezzo, non è un luogo pacifico dove gli appartenenti alle varie razze umane o diversamente umane (elfi, nani, hobbit, uomini) potrebbero, soltanto con un po’di buona volontà, collaborare pacificamente e condurre tranquillamente le loro bonarie (hobbit), scorbutiche (nani) e illuminate (elfi) esistenze a fianco degli uomini se non fosse per il ritorno di un Male antico e odioso, destinato a riportare il buio là dove dovrebbe risplendere soltanto la luce.
No, quello disegnato da Peake è un mondo di conflitti, più o meno malcelati, dove solo la tradizione, le leggi e i riti più antichi possono impedire la “naturale” dissoluzione di un ordine che costituisce non soltanto “una certa qual massiccia corposità architettonica”, ma anche l’intero orizzonte in cui tutti i personaggi si muovono, senza alcun riguardo o curiosità per ciò che potrebbe estendersi oltre i suoi confini.
Non vi è divisione tra Bene e Male nel Titus Groan, non vi è religione o magia se non quella della celebrazione dei riti fini a se stessi. Non c’è sacralità né, tanto meno, un’autorità morale o spirituale superiore, cui far riferimento. Non ci sono neppure una vera scienza o un vero raziocinio, esiste soltanto la Legge, che non è possibile interpretare, ma soltanto seguire. Tanto che la vecchia biblioteca, dove il conte Sepulcrio passa la maggior parte del suo tempo, prima del suo incendio e della sua distruzione, è composta per la maggior parte da testi scritti dagli antenati dello stesso.
Un tempo fermo, apparentemente immobile, che solo Tito potrà forse, un giorno, scuotere o abbandonare. Ma questo al termine del primo romanzo del ciclo non è ancor dato sapere. L’ordine e la pace, in tale contesto, non costituiscono una conquista, ma un”obbligo” noioso e mortifero. Siamo ad anni luce di distanza dall’epica tolkeniana. In un mondo in cui il sole sorge ad est e tramonta a ovest, esiste il petrolio e insieme ad esso molti altri oggetti del viver quotidiano inglese tra XIX e XX secolo.
 Il dubbio che sorge, nel lettore, è costituito dal fatto che, al di là di quanto affermato da Burgess nella Presentazione, quella dipinta da Peake sia un’allegoria della società inglese successiva al secondo conflitto mondiale: un ordine che ha perso pezzi importanti del proprio impero, ma che vuole mantenersi immutabile con suoi riti e le sue tradizioni. Come anche i recenti funerali della regina Elisabetta II e la saga infinita della famiglia reale (Carlo ora Carlo III, Diana, Camilla, Harry, Meghan, William e consorte) sembrano ancora confermare (grazie anche alle serie televisive prodotte da Netflix).
Il dubbio che sorge, nel lettore, è costituito dal fatto che, al di là di quanto affermato da Burgess nella Presentazione, quella dipinta da Peake sia un’allegoria della società inglese successiva al secondo conflitto mondiale: un ordine che ha perso pezzi importanti del proprio impero, ma che vuole mantenersi immutabile con suoi riti e le sue tradizioni. Come anche i recenti funerali della regina Elisabetta II e la saga infinita della famiglia reale (Carlo ora Carlo III, Diana, Camilla, Harry, Meghan, William e consorte) sembrano ancora confermare (grazie anche alle serie televisive prodotte da Netflix).
Se sia davvero così non è dato sapere con certezza, ma certo la carica nichilista ed eversiva contenuta non soltanto nelle pieghe del romanzo fa sì che lo stesso finisca coll’acquisire un significato devastante nei confronti dei sistemi di potere, anche per l’attuale vigente in un Occidente che non vuole riconoscere ordine altro dal proprio, che lo pone in uno spazio ben diverso e provocatorio rispetto a quello che, anche a sinistra, si è voluto definire per l’opera di Tolkien nel suo insieme. Tanto che anche lo stesso Burgess è costretto ad ammettere che nelle pagine del romanzo:
Dappertutto, anche nei voli più romanticamente fantastici, si sente questa fredda padronanza dell’intelligenza che tiene in vita, come un generatore, il mondo immaginario e ne esclude quello reale. Ma è poi vero che il mondo reale ne sia escluso?
Prima di dare una risposta, occorre ritornare all’anno della pubblicazione di Titus Groan, il primo dopo una guerra lunga e orribile. Il connubio tra lo scheletro di Agrimonio e il teschio di vitello, la zampa del gatto che strappa dalla guancia di Ferraguzzo, sotto l’occhio destro, un «brandello scarlatto», il duello tra Lisca e Sugna nella Sala dei Ragni, non sono i particolari gratuiti di un romanzo gotico quanto piuttosto i riverberi di un’epoca di orrori. Il rogo che distrugge secoli di tradizione e la follia di un conte privato per sempre del sostegno di un rituale sembrano simboleggiare la fine di un ordine di secoli, ma questa volta autentico, storico9.
Allora, soltanto per giungere a una prima conclusione, il vero enigma del Gormenghast sta forse proprio nel chiedersi perché tanta cultura pretesa alternativa o di sinistra abbia speso tanto tempo nel contendere alla destra un ciclo sostanzialmente tradizionale come quello del Signore degli Anelli e abbia tralasciato di prestare attenzione a un ben più feroce e sovversivo esempio di critica dell’ordine esistente come quello rappresentato dal ciclo comunque epico di Peake. Forse perché la tradizione manichea che accomuna certa destra e certa sinistra, con la rigida divisone tra Bene e Male, è destinata ad essere l’ultima a morire? Speriamo, sinceramente, di no.
Anthony Burgess, pseudonimo di John Burgess Wilson (Manchester, 1917 – Londra, 1993), è stato scrittore, critico letterario, poeta, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista, saggista e traduttore. E’ considerato uno dei più importanti autori inglesi del secondo dopoguerra e tra le sue opere più significative vanno annoverate: Arancia Meccanica (A Clockwork Orange, 1962), Notizie dalla fine del mondo o La fine della storia (The End of the World News: An Entertainment, 1982) e la Trilogia malese (Malaysian trilogy, 1958-1960). Nei suoi romanzi uno dei temi centrali è costituito dall’uomo schiacciato dalla violenza, vittima di condizionamenti ideologici e oppresso dagli apparati dello Stato. Nella Trilogia malese ha descritto il crepuscolo nel quale si è chiusa la dominazione inglese nelle colonie dell’Estremo Oriente. ↩
A. Burgess, Presentazione in M. Peake, Gormenghast. La Trilogia, Adelphi Edizioni, Milano 2022, p. 13 ↩
Mervyn Peake fu, oltre che scrittore, poeta, pittore e affermato illustratore di libri per l’infanzia e non soltanto, come dimostra la tavola qui accanto in cui sono raffigurati alcuni personaggi del suo romanzo: Ferraguzzo, Fucsia, Signa e Lisca ↩
A, Burgess, op. cit., pp. 10-11 ↩
In Italia per la prima volta nel 1981 per Adelphi e con il titolo già precedentemente citato: Tito di Gormenghast ↩
In Italia: Gormenghast, Adelphi 2005 ↩
In Italia: Via da Gormenghast, Adelphi 2009 ↩
A. Burgess, op. cit., p. 10 ↩
Ibidem, p. 13 ↩



