di Diego Gabutti
 Oggi Frank Kane è stato dimenticato, o almeno a me non è mai capitato, negli ultimi cinquant’anni, d’imbattermi in qualcuno (d’età non veneranda) che ricordi d’aver letto le sue storie. Giornalista, sceneggiatore e produttore televisivo, lobbista per i produttori di bevande alcoliche, Kane scriveva signori pulp, protagonista Johnny Liddell, detective privato a New York, con ufficio sulla 42ma, le finestre affacciate su Bryant Park, dietro la Public Library, un paio d’isolati da Times Square, quasi all’angolo con Fifth Avenue.
Oggi Frank Kane è stato dimenticato, o almeno a me non è mai capitato, negli ultimi cinquant’anni, d’imbattermi in qualcuno (d’età non veneranda) che ricordi d’aver letto le sue storie. Giornalista, sceneggiatore e produttore televisivo, lobbista per i produttori di bevande alcoliche, Kane scriveva signori pulp, protagonista Johnny Liddell, detective privato a New York, con ufficio sulla 42ma, le finestre affacciate su Bryant Park, dietro la Public Library, un paio d’isolati da Times Square, quasi all’angolo con Fifth Avenue.
Nel parco, con al centro un vasto prato, intorno viali alberati paralleli, oggi ci sono tavolini e sedie di metallo, scaffali mobili dove tutti possono pescare libri e riviste; ci sono giostre con cavallini, un chiosco dove servono ottimi cappuccini e una scultura bronzea di Gertrude Stein (più un monumento al ritratto che le dedicò Picasso nel remoto 1905 o 1906 che un omaggio all’autrice di “C’era una volta gli americani”). Ai tempi di Johnny Liddell, almeno secondo Frank Kane, quello era invece un territorio sotto il dominio dei Brutti Ceffi: prostitute, rapinatori, tossici, papponi. Anche in Junkie di William Burroughs, uscito nei primi cinquanta, e in Shaft contro la mafia d’Ernest Tidyman, roba di fine settanta, Times Square era pura giungla urbana. C’era poi il West Side di Leonard Bernstein e Robert Wise: lame, pistole e mambo. Questa era l’idea che mi facevo di New York prima di conoscerla.
Lessi il mio primo Kane a otto o nove anni. Non ricordo quale avventura di Johnny Liddell lessi per prima, probabilmente Bambole per l’obitorio. Di sicuro, come Brandon a New York di Vernon Warren (Brandon era un detective di Chicago in trasferta) e Si parte alle sei di William Irish, i primi due romanzi gialli che mi capitarono tra le mani, anche questo Frank Kane era un Giallo Mondadori con la copertina squillante. Non la ricordo, naturalmente, come non ricordo il titolo del romanzo, ma le copertine dei Gialli Mondadori, disegnate per più di trent’anni da Carlo Jacono, illustratore all’epoca insigne, si somigliavano tutte, ed erano tutte squillanti: bionde burrose, sbirri e cadaveri, automobili sfasciate, scale antincendio, strade battute dalla pioggia, camere d’albergo, letti spiegazzati, banconi di bar, ma soprattutto tizi in giacca, cravatta e cappello di feltro. Sulla copertina di Bambole per l’obitorio, che recupero da Google, ci sono ben due tizi incravattati, ciascuno dei quali porta un cappello di feltro: uno dei due tizi impugna la pistola guardandosi nervosamente intorno (cerca di capire da dove arrivano gli spari) mentre uno dei cappelli vola via e il suo proprietario sta cadendo colpito a morte. Se non era Bambole per l’obitorio, forse era I giganti del male, con una copertina ancor più memorabile e strabiliante per un bambino di otto anni: una mano gigante in primo piano, la sagoma buttata lì d’un sassofono e una venditrice di sigari da night club con gonnellino rosso ad altezza chiappa, la cassettina degli avana (all’epoca non ancora sotto embargo) appesa al collo, l’aria sorpresa e tacchi alti venti centimetri.
Non avevo l’età per ammirare le imprese amorose di Johnny Liddell (prendendo esempio da mio nonno, un fine esteta che accoglieva sbuffando gl’intermezzi sentimentali nei film gialli e western, nella giusta convinzione che interrompessero l’azione, col tempo ho sviluppato anch’io la stessa insofferenza, ma all’epoca più per ragioni relative all’età che per ragioni estetiche). Non di meno capivo benissimo, anche in tempi prepuberali, che non c’era pupa in grado di resistere al fascino maliardo di Johnny Liddell, un personaggio da song Chiosso-Buscaglione se mai ce n’è stato uno. Non che lui seducesse le pupe: erano loro a sedurre lui dopo averlo «squadrato ben bene da capo a piedi», senza trascurare di «leccarsi le labbra». Chiamandole invariabilmente «bambola», «dolcezza» o «bambina», spesso lui le respingeva. Gli capitava, infatti, d’avere anche altro da fare: scoprire un cadavere, prendersi una botta in testa, schivare una pallottola, accendersi l’ennesima sigaretta e schiacciarne il mozzicone sotto il tacco, questionare con l’ispettore Herlehy della squadra omicidi, farsi bello con Muggsy Kiely (giornalista e talvolta sceneggiatrice a Hollywood, sua eterna fidanzata). Era anche di gusti difficili: le pupe che contavano più di «trenta primavera» non erano più «un bocconcino troppo tenero». Per quanto concupito dalle bambole, Liddell era in primis un eroe action in anticipo sui tempi, con un piede nei vecchi pulp (le pupe erano spesso le assassine, come nei noir classici, dal Falco maltese in avanti) e l’altro nei primi serial televisivi (Perry Mason, 77 Sunset Strip, The Thin Man).
 Su piazza dal 1947 – quando uscì L’età del piombo, una storia tradotta in italiano solo dieci anni più tardi, in copertina un’auto che va a fuoco e un mitragliatore – Liddell era essenzialmente uno «spaccaculi» (come Stephen King definisce Clint Eastwood nel serial della Torre Nera). Ed era questo, nel tempo dei tempi, il solo Liddell che apprezzavo (e che ancora apprezzo, non sembra vero, come ho scoperto rileggendolo). A Johnny Liddell non si contavano balle. C’era lì un teppista, o uno sbirro sul libro paga dei «malamente», un gangster o un killer «venuto da fuori»? Liddell ci metteva un attimo a dar loro una lezione di buone maniere con un paio di cazzotti ben mirati; e quando non bastavano i pugni, c’erano le pallottole. Chi cercava di fargli la pelle poteva dire addio al proposito, per citare Frank Kane, di «cominciare a leggere un romanzo a puntate». Così – in Margine di terrore, un romanzo del 1967, a fine carriera – Liddell presentava la sua 45 a un brutto figuro: «Questa bambola ha due estremità. Da una parte sputa piombo e dall’altra spacca crani».
Su piazza dal 1947 – quando uscì L’età del piombo, una storia tradotta in italiano solo dieci anni più tardi, in copertina un’auto che va a fuoco e un mitragliatore – Liddell era essenzialmente uno «spaccaculi» (come Stephen King definisce Clint Eastwood nel serial della Torre Nera). Ed era questo, nel tempo dei tempi, il solo Liddell che apprezzavo (e che ancora apprezzo, non sembra vero, come ho scoperto rileggendolo). A Johnny Liddell non si contavano balle. C’era lì un teppista, o uno sbirro sul libro paga dei «malamente», un gangster o un killer «venuto da fuori»? Liddell ci metteva un attimo a dar loro una lezione di buone maniere con un paio di cazzotti ben mirati; e quando non bastavano i pugni, c’erano le pallottole. Chi cercava di fargli la pelle poteva dire addio al proposito, per citare Frank Kane, di «cominciare a leggere un romanzo a puntate». Così – in Margine di terrore, un romanzo del 1967, a fine carriera – Liddell presentava la sua 45 a un brutto figuro: «Questa bambola ha due estremità. Da una parte sputa piombo e dall’altra spacca crani».
Non giravano molti Gialli Mondadori per casa. Mia madre ne leggeva uno ogni tanto, ma poca roba, e raramente titoli edificanti come Bambole per l’obitorio o L’età del piombo (penso che proprio i titoli la scoraggiassero, e posso capirla). Mio nonno ne leggeva di più, e più erano diseducativi più li apprezzava, benché la sua passione non fossero i gialli ma i western, in particolare le storie del «Coyote», il pistolero mascherato di José Mallorquí y Figuerola. Mechicano, «el vengador de California», el Coyote era uno pseudo-Zorro di cui riconoscevo naturalmente le virtù, ma che anche a otto o nove anni, con tutto il rispetto per mio nonno, non mi entusiasmava troppo (tutti quei «caramba!» e quei «¿cómo vas?»). È certamente a casa dei nonni, in ogni modo, che mi sono imbattuto nel mio primo Frank Kane, qualunque ne fosse il titolo. Preso il vizio, cominciai a procurarmi le storie di Johnny Liddell sulle bancarelle. All’epoca, intorno a casa mia o poco lontano, ce n’erano parecchie – Piazza Carlo Alberto, Corso Siccardi, Via Po – e non ero il solo bambino a frequentarle, vuoi cercando gialli, vuoi facendo incetta di fumetti o di storie di fantascienza: la cultura nerd, da cui presto sarebbero derivate intere tribù, ciascuna occupata a danzare intorno a un solo e particolare totem, stava prendendo forma.
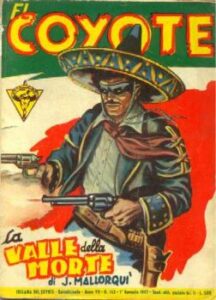 Quelle del detective di Bryant Park, con le sue «bambine» adoranti e le sue 45 tonanti, erano trame piuttosto oscure. Non era mai ben chiaro come si fosse arrivati da A a Z. C’erano imboscate, appostamenti, testimoni reticenti da interrogare a sganassoni, guardie del corpo dalla mascella di vetro, numeri di spogliarello, poliziotti smanaccioni. Liddell flirtava con Pinky (la sua segretaria, una «rossa») oppure entrava in qualche drugstore per telefonare. Guidava nella notte, posteggiava nei vicoli, accendeva e spegneva zampironi, entrava e usciva dai locali notturni, su il cappello, giù il cappello, mostrava i denti a chiunque rigasse meno che diritto, si faceva ricucire le ferite da manganellata tra capo e collo. In almeno due occasioni penetrò di notte in un cimitero per disseppellire cadaveri molto stagionati. Erano carcasse da pizzicarsi il naso tra due dita, roba à la Edgar Allan Poe, ma lui niente, non gli facevano né caldo né freddo.
Quelle del detective di Bryant Park, con le sue «bambine» adoranti e le sue 45 tonanti, erano trame piuttosto oscure. Non era mai ben chiaro come si fosse arrivati da A a Z. C’erano imboscate, appostamenti, testimoni reticenti da interrogare a sganassoni, guardie del corpo dalla mascella di vetro, numeri di spogliarello, poliziotti smanaccioni. Liddell flirtava con Pinky (la sua segretaria, una «rossa») oppure entrava in qualche drugstore per telefonare. Guidava nella notte, posteggiava nei vicoli, accendeva e spegneva zampironi, entrava e usciva dai locali notturni, su il cappello, giù il cappello, mostrava i denti a chiunque rigasse meno che diritto, si faceva ricucire le ferite da manganellata tra capo e collo. In almeno due occasioni penetrò di notte in un cimitero per disseppellire cadaveri molto stagionati. Erano carcasse da pizzicarsi il naso tra due dita, roba à la Edgar Allan Poe, ma lui niente, non gli facevano né caldo né freddo.
A che cosa servissero tutte queste mosse e come combinasse insieme gl’indizi (quali indizi, poi) era un mistero. Non di meno, fai e disfa, alla fine beccava sempre l’assassina (talvolta, più raramente, l’assassino) e la (o lo) consegnava alla giustizia. A quel punto la squadra omicidi chiedeva scusa, Muggsy Kiely aveva un’esclusiva, lui incassava un assegno oppure no (i dollari gli piacevano, ma gli piaceva di più un lavoro ben fatto) e io tornavo a battere le bancarelle cercando un altro giallo firmato Frank Kane. Purtroppo le storie di Johnny Liddell erano in numero limitato. Scoprii, è vero, che in edicola non c’erano soltanto i Gialli Mondadori, ma anche molte altre collane poliziesche: i Gialli Proibiti Longanesi, i Gialli Garzanti, i Gialli Giumar (copertina di cartoncino grigio, dorso di tela gialla). E tutte avevano pubblicato una storia o due di Johnny Liddell, bambole e tutto. Ma anche così il numero di queste storie rimaneva limitato. Io continuavo comunque a girare per bancarelle, dove m’imbattevo quasi ogni giorno in nuovi eroi pulp (a cominciare dal grande Nero Wolfe, il re dei re degli eroi pulp). Un’altra cosa che facevo era giocare al detective privato. Avevo una 38 di plastica molto ben imitata e una fondina ascellare. Non mi riusciva, però, di convincere gli altri bambini, giù ai giardinetti di Piazza Cavour, a giocare a gangster, pupe e detective privati. Tradizionalisti, gli altri bambini preferivano giocare ai cowboy. Cowboy d’acquadolce, oltretutto. Niente «el Coyote»; all’epoca persino Zorro era uno sconosciuto.
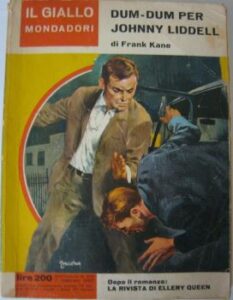 Con tutti i suoi meriti, lo stile action, la beltà, Liddell non era tuttavia un Nostradamus. In un romanzo del 1953 (Johnny Liddell a New Orleans nei Gialli Mondadori, Veleni ignoti in edizione Gialli Garzanti) c’è un tentativo, da parte della mafia, d’organizzare una rivoluzione (anzi, meglio: una violencia) in un’isola caraibica non specificata per impiantarci, così pareva, una super Las Vegas fuori confine. Liddell in trasferta californiana, e in un ruolo un po’ da vengador, sventa come ridere il golpe e riflette: «C’è anche da considerare che qualcuna di queste repubbliche dei Caraibi potrebbe offrire a un nostro potenziale nemico una magnifica base operativa a un tiro di sasso da tutte le nostre principali città e dalla zona del Canale di Panama». Ma subito scaccia i cattivi pensieri: «Forse la CIA fa un sacco di sbagli, però non lascerà mai che qualche nemico dell’America s’installi così vicino a noi». Be’, a giudicare da come sono poi andate le cose, più che un Nostradamus il detective di Bryant Park era un Menagramus.
Con tutti i suoi meriti, lo stile action, la beltà, Liddell non era tuttavia un Nostradamus. In un romanzo del 1953 (Johnny Liddell a New Orleans nei Gialli Mondadori, Veleni ignoti in edizione Gialli Garzanti) c’è un tentativo, da parte della mafia, d’organizzare una rivoluzione (anzi, meglio: una violencia) in un’isola caraibica non specificata per impiantarci, così pareva, una super Las Vegas fuori confine. Liddell in trasferta californiana, e in un ruolo un po’ da vengador, sventa come ridere il golpe e riflette: «C’è anche da considerare che qualcuna di queste repubbliche dei Caraibi potrebbe offrire a un nostro potenziale nemico una magnifica base operativa a un tiro di sasso da tutte le nostre principali città e dalla zona del Canale di Panama». Ma subito scaccia i cattivi pensieri: «Forse la CIA fa un sacco di sbagli, però non lascerà mai che qualche nemico dell’America s’installi così vicino a noi». Be’, a giudicare da come sono poi andate le cose, più che un Nostradamus il detective di Bryant Park era un Menagramus.
Dopo i compiti, e dopo la Tv dei Ragazzi, leggevo gialli hard boiled come un forsennato. Frank Kane era il top (il top successivo in fatto di cacciatori d’uomini non sarebbe stato il Continental Op di Dashiell Hammett, al quale mi dedicai più avanti, ma sarebbero stati il Mike Hammer di Cacciatori di donne, “chef-d’œuvre” di Mickey Spillane, e Porfirij Petrovič, il giudice istruttore di Delitto e castigo). Non ricordo d’essermi mai chiesto in che modo Johnny Liddell giungesse a scoprire l’assassino. Non m’importava sapere chi aveva fatto cosa a chi e nemmeno perché. Al pari di Eduard Bernstein, padre del revisionismo marxista, ma prima di tutto al pari di Frank Kane, ero e rimango anch’io dell’idea che il movimento sia «tutto» e il fine «nulla». Come «i miracoli per i santi» secondo il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, anche per Johnny Liddell mandare l’assassino «alla sedia» era soltanto «un di più». A fare di lui un gran figo non era la sua infallibilità di segugio ma tutto quel ciondolare intorno senza costrutto. Liddel non indagava; i casi che gli venivano affidati si risolvevano da sé, una scazzozzata e un beverone dopo l’altro. Pochi reggevano l’alcool come lui.
Liddell, nel corso delle sue indagini, passava molto tempo al bancone dei bar, in particolare «il Bar Deadline di Mike», dove ordinava per lo più «bourbon con acqua». Invece d’andare in giro a cercare indizi e testimoni da torchiare ordinava da bere. Si capiva che Frank Kane, prima d’abbracciare la carriera d’autore pulp e diventare il mio primo autore di culto, aveva lavorato come lobbista per le mayor degli alcolici dal fatto che il suo detective privato non consumava mai un solo bourbon con acqua ma almeno due e anche tre. Ogni tanto cacciava di tasca una fiaschetta e la divideva con un amico. Per esempio con Pop Totter, archivista del “Dispatch”, il giornale in cui lavorava Muggsy Kiely, sua morosa e figlia di Jim Kiely, direttore del quotidiano. Silenzio, ritagli di giornale e polvere. Pop e Liddell si passavano la fiaschetta in questo «angolino tranquillo, adatto all’eterno riposo di notizie morte, discorsi morti e persone morte». È lo stesso cantuccio in cui Bartleby lo scrivano, un altro newyorchese, con ufficio a Wall Street, un primo piano, meditava sulla vita offesa.



