di Domenico Gallo
 Ombre del futuro è un’enciclopedia della distopia che va al di là della fantascienza e delle mode più recenti, dimostrando quanto fosse radicata nella letteratura la capacità di descrivere le forme del pensiero autoritario e poi totalitario. Mondi di regole, paure, obbedienze, poteri capaci di insinuarsi nella testa, dove si formano i pensieri. 82 romanzi, di cui molti poco conosciuti, che sono in attesa di essere letti e riletti per insinuare dubbi e indebolire le distopie che viviamo qui e ora.
Ombre del futuro è un’enciclopedia della distopia che va al di là della fantascienza e delle mode più recenti, dimostrando quanto fosse radicata nella letteratura la capacità di descrivere le forme del pensiero autoritario e poi totalitario. Mondi di regole, paure, obbedienze, poteri capaci di insinuarsi nella testa, dove si formano i pensieri. 82 romanzi, di cui molti poco conosciuti, che sono in attesa di essere letti e riletti per insinuare dubbi e indebolire le distopie che viviamo qui e ora.
Marco Sommariva, Ombre del futuro. Viaggio nella letteratura distopica. Edizioni Malamente, pp. 702, euro 24,00
Lo scrittore uruguayano Eduardo Galeano, interrogato su cosa fosse l’utopia, pronunciò queste parole destinate a diventare famose. “Lei è all’orizzonte. Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a questo: a camminare”[1]. Un concetto simile, questo di intendere l’utopia come qualcosa che si allontana da noi man mano che raggiungiamo l’obiettivo che ci siamo dati, lo ritroviamo anche ne Le città invisibili di 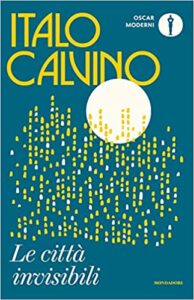 Italo Calvino. “Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta affiorando sparsa entro i confini del tuo impero; puoi rintracciarla, ma a quel modo che t’ho detto.”[2] Di questa mobilità, di questo sfuggire che ricorda la nota che conclude il romanzo di Antonio Tabucchi Il filo dell’orizzonte, che, “di fatto, è un luogo geometrico, perché si sposta mentre noi ci spostiamo”[3], Darko Suvin, il più importante studioso mondiale della fantascienza, ha dato una lettura dell’utopia come genere letterario che non si può evitare di affrontare quando si pensa a questo tipo di immaginazione politica e si discute su di lei. Il punto di partenza è la reinterpretazione proposta da Ernst Bloch del termine utopia, negandone l’impossibilità e individuandola come un percorso verso un obiettivo certo non immediato ma teoricamente raggiungibile, ovvero un “qualsiasi superamento dei confini presentatisi all’uomo” [4], e, nell’accezione di Karl Manheim, ancora nel testo di Suvin, “ogni orientamento che trascenda la realtà e spezzi i limiti dell’ordine esistente”. Pur tenendo conto della limitatezza delle citazioni, l’elemento dinamico e l’incessante lavoro di ridefinizione dei contenuti sono al centro della tensione verso l’utopia, sia come superamento delle condizioni socio-politiche esistenti, sia come metodologia del sapere ed essere politico. Lo studio di Suvin è rivolto all’utopia come genere letterario, tuttavia la fitta dialettica tra la lotta politica e la letteratura, e la potente battaglia che oggi si combatte contro il capitalismo proprio sul terreno dell’immaginario, giustifica anche l’appropriazione di strumenti e metodi sviluppati all’interno della critica letteraria per calarli tra gli strumenti di lotta di chi vuole una vita migliore. In Italia dobbiamo ad Antonio Caronia e Valerio Evangelisti, un filosofo e un narratore di fantascienza, la lezione che l’immaginario è diventato il più importante “luogo produttivo” del capitalismo contemporaneo, dove si crea profitto e, nello stesso momento, controllo e consenso al sistema economico mondiale e al suo modello di sfruttamento delle persone e del pianeta. In questo modello, alla tradizionale produzione e
Italo Calvino. “Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla. Forse mentre noi parliamo sta affiorando sparsa entro i confini del tuo impero; puoi rintracciarla, ma a quel modo che t’ho detto.”[2] Di questa mobilità, di questo sfuggire che ricorda la nota che conclude il romanzo di Antonio Tabucchi Il filo dell’orizzonte, che, “di fatto, è un luogo geometrico, perché si sposta mentre noi ci spostiamo”[3], Darko Suvin, il più importante studioso mondiale della fantascienza, ha dato una lettura dell’utopia come genere letterario che non si può evitare di affrontare quando si pensa a questo tipo di immaginazione politica e si discute su di lei. Il punto di partenza è la reinterpretazione proposta da Ernst Bloch del termine utopia, negandone l’impossibilità e individuandola come un percorso verso un obiettivo certo non immediato ma teoricamente raggiungibile, ovvero un “qualsiasi superamento dei confini presentatisi all’uomo” [4], e, nell’accezione di Karl Manheim, ancora nel testo di Suvin, “ogni orientamento che trascenda la realtà e spezzi i limiti dell’ordine esistente”. Pur tenendo conto della limitatezza delle citazioni, l’elemento dinamico e l’incessante lavoro di ridefinizione dei contenuti sono al centro della tensione verso l’utopia, sia come superamento delle condizioni socio-politiche esistenti, sia come metodologia del sapere ed essere politico. Lo studio di Suvin è rivolto all’utopia come genere letterario, tuttavia la fitta dialettica tra la lotta politica e la letteratura, e la potente battaglia che oggi si combatte contro il capitalismo proprio sul terreno dell’immaginario, giustifica anche l’appropriazione di strumenti e metodi sviluppati all’interno della critica letteraria per calarli tra gli strumenti di lotta di chi vuole una vita migliore. In Italia dobbiamo ad Antonio Caronia e Valerio Evangelisti, un filosofo e un narratore di fantascienza, la lezione che l’immaginario è diventato il più importante “luogo produttivo” del capitalismo contemporaneo, dove si crea profitto e, nello stesso momento, controllo e consenso al sistema economico mondiale e al suo modello di sfruttamento delle persone e del pianeta. In questo modello, alla tradizionale produzione e  consumo dei mezzi materiali, così magistralmente descritti in maniera epica da Émile Zola in Germinal (1885), si è affiancato un enorme meccanismo di assoggettamento che, attraverso le tecnologie della comunicazione, ha connesso ogni individuo della Terra a un complesso sistema narrativo a cui ognuno collabora condividendo il proprio immaginario con gli altri utenti delle piattaforme. Se oggi al profitto ingiustamente accumulato da chi domina le filiere mondiali dei beni materiali, si affianca chi accumula i profitti generati dallo sfruttamento dei beni immateriali, costituendo in realtà un unico sistema di sfruttamento interdipendente, allora le nuove forme di liberazione, oltre allo scontro sui salari, sulla sicurezza e sulla nocività del lavoro, si devono alleare in una guerra civile di lunga durata per la conquista dell’immaginario e delle sue forme espressive. Questo perché, e le classi dirigenti lo hanno compreso molto bene, se si vuole distruggere questa società bisogna pensarne un’altra, e il pensiero è progressivamente diventato l’oggetto più importante da conquistare per difendere i privilegi dei pochi.
consumo dei mezzi materiali, così magistralmente descritti in maniera epica da Émile Zola in Germinal (1885), si è affiancato un enorme meccanismo di assoggettamento che, attraverso le tecnologie della comunicazione, ha connesso ogni individuo della Terra a un complesso sistema narrativo a cui ognuno collabora condividendo il proprio immaginario con gli altri utenti delle piattaforme. Se oggi al profitto ingiustamente accumulato da chi domina le filiere mondiali dei beni materiali, si affianca chi accumula i profitti generati dallo sfruttamento dei beni immateriali, costituendo in realtà un unico sistema di sfruttamento interdipendente, allora le nuove forme di liberazione, oltre allo scontro sui salari, sulla sicurezza e sulla nocività del lavoro, si devono alleare in una guerra civile di lunga durata per la conquista dell’immaginario e delle sue forme espressive. Questo perché, e le classi dirigenti lo hanno compreso molto bene, se si vuole distruggere questa società bisogna pensarne un’altra, e il pensiero è progressivamente diventato l’oggetto più importante da conquistare per difendere i privilegi dei pochi.
Le critiche rivolte alle utopie si distinguono in due filoni, quelle che ritengono le impossibili da realizzarsi (e quindi è inutile qualsiasi sforzo dedicato al cambiamento delle società in cui abbiamo vissuto), che è una narrazione costante e divenuta dominante durante il riflusso degli anni Ottanta, oppure che mascherano in sé o si evolvono inevitabilmente in una negazione della libertà (e quindi sono utopie negative, distopie), che è il tema classico della critica liberale e individualistica. Le prime utopie a carattere religioso erano isole o città lontane, comunque costruzioni terrestri e quindi realizzabili, che ritengono di raggiungere il massimo livello di giustizia attraverso un sistema di regole molto rigido e condiviso. Adeguarsi a questo sistema, fino al punto di modificare le proprie pulsioni e aspettative individuali, è stato visto dal pensiero liberale come una forma di tirannia talmente grave da ribaltare l’utopia nel suo contrario, almeno nella tradizione europea. Ma è la macchina (prima a vapore, poi elettrica) a creare una profonda separazione tra la tradizione hobbesiana e la visione positivista che si sviluppa negli Stati Uniti. L’Inghilterra è la nazione in cui per prima esplode l’odio popolare contro le macchine. A partire dal 1811 la furia luddista esplode a Nottingham, quando vengono distrutti decine di telai da parte di lavoratori tessili. Il capo della rivolta è considerato Ned Ludd, forse un personaggio inesistente che veniva affiancato a Robin Hood, e la rabbia dei lavoratori si diffonde violenta per sparire e riapparire con azioni armate, sabotaggi e incendi per almeno vent’anni. La visione di quella classe operaia individuava nella meccanizzazione un modello antagonista a quello umano e destinato a ridurre assunzioni e sottrarre salario, e non la prospettiva di alleviare i lavoratori dai lavori faticosi, e aumentare la produzione con il conseguente aumento i salari. La contrapposizione lavoratore-macchina rimane centrale nell’elaborazione politica europea. La critica espressa da Marx ed Engels verso le rivolte luddiste è limitata allo spontaneismo del movimento e alla mancanza di una critica radicale verso il sistema di classe, all’accettazione del ruolo subalterno dei lavoratori, intrinsecamente dipendenti dai padroni, ma condividono la visione estremamente negativa della macchina come strumento di sfruttamento unilaterale del padrone. In “Macchine. Impiego delle forze naturali e della scienza”, il testo tratto dal Quaderno V della collezione di manoscritti agosto 1861 – giugno 1863, riscoperto in Italia alla fine degli anni Settanta, e che costituisce la base del capitolo sulle macchine del primo libro de Il Capitale, afferma che “l’introduzione delle macchine nel quadro della produzione capitalista non ha affatto lo scopo di alleviare e ridurre la fatica quotidiana dell’operaio”, né di ridurre il suo orario di lavoro, ma di innescare un processo di indebolimento della classe operaia attraverso la despecializzazione dei lavoratori, il lavoro minorile e quello delle donne consentito dall’introduzione delle macchine e dalla conseguente  semplificazione delle fasi del lavoro. Ancora nel “Frammento sulle macchine” proveniente dai Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Marx descrive come “il mezzo di lavoro percorre diverse metamorfosi, di cui l’ultima è la macchina, o, piuttosto, un sistema automatico di macchine”[5]. In questo processo, che si è evoluto fino all’odierna invasività del cyborg, dove lavoratore e macchina sono fusi in un unico oggetto produttivo, la macchina non è lo strumento di lavoro dell’operaio, ma progressivamente diventa potere estraneo e ambiguo che sottomette la volontà operaia, limitandone lo spazio di azione e autonomia e frustrandone la creatività. La macchina del tempo di Herbert George Welles, romanzo che introduce il viaggio nel tempo, ma che, contemporaneamente, apre uno squarcio sull’evoluzione del capitalismo e della classe operaia, rappresenta l’entrata diretta della fantascienza all’interno del dibattito politico più radicale. La profonda ambiguità dell’estrapolazione wellsiana si colloca proprio nella dialettica utopia-distopia. Prima la descrizione del mondo degli Eloi, gli eredi della classe dirigente, con la riproposizione della città-giardino, l’apparente mancanza di proprietà privata e il prevalere della vita sociale, l’abbondanza e la bellezza degli abitanti (per quanto instupiditi), poi la scoperta dei Morlock, le ripugnanti creature notturne che si cibano degli Eloi, evoluzione darwiniana estrema della classe operaia, ridotti a mostri costretti a vivere nelle fabbriche sotterranee. Sebbene nel romanzo gli Eloi si rivelano
semplificazione delle fasi del lavoro. Ancora nel “Frammento sulle macchine” proveniente dai Lineamenti fondamentali di critica dell’economia politica, Marx descrive come “il mezzo di lavoro percorre diverse metamorfosi, di cui l’ultima è la macchina, o, piuttosto, un sistema automatico di macchine”[5]. In questo processo, che si è evoluto fino all’odierna invasività del cyborg, dove lavoratore e macchina sono fusi in un unico oggetto produttivo, la macchina non è lo strumento di lavoro dell’operaio, ma progressivamente diventa potere estraneo e ambiguo che sottomette la volontà operaia, limitandone lo spazio di azione e autonomia e frustrandone la creatività. La macchina del tempo di Herbert George Welles, romanzo che introduce il viaggio nel tempo, ma che, contemporaneamente, apre uno squarcio sull’evoluzione del capitalismo e della classe operaia, rappresenta l’entrata diretta della fantascienza all’interno del dibattito politico più radicale. La profonda ambiguità dell’estrapolazione wellsiana si colloca proprio nella dialettica utopia-distopia. Prima la descrizione del mondo degli Eloi, gli eredi della classe dirigente, con la riproposizione della città-giardino, l’apparente mancanza di proprietà privata e il prevalere della vita sociale, l’abbondanza e la bellezza degli abitanti (per quanto instupiditi), poi la scoperta dei Morlock, le ripugnanti creature notturne che si cibano degli Eloi, evoluzione darwiniana estrema della classe operaia, ridotti a mostri costretti a vivere nelle fabbriche sotterranee. Sebbene nel romanzo gli Eloi si rivelano  anche essere una sorta di bestiame a disposizione dei Morlock, in una sorta di ribaltamento rivoluzionario, è evidente che il monito di Wells è centrato sulla critica a quella società che ha indotto nei Morlock la mutazione fino a sfigurarli a causa delle condizioni di lavoro e dell’imbarbarimento della vita di fabbrica e nella povertà endemica dei quartieri operai. Sebbene collocato dall’altra parte della Manica, è ancora quella di Germinal l’immagine consapevole dei lavoratori dell’epoca, quella che costituisce un immenso immaginario capace di rinforzare le lotte di un intero continente.
anche essere una sorta di bestiame a disposizione dei Morlock, in una sorta di ribaltamento rivoluzionario, è evidente che il monito di Wells è centrato sulla critica a quella società che ha indotto nei Morlock la mutazione fino a sfigurarli a causa delle condizioni di lavoro e dell’imbarbarimento della vita di fabbrica e nella povertà endemica dei quartieri operai. Sebbene collocato dall’altra parte della Manica, è ancora quella di Germinal l’immagine consapevole dei lavoratori dell’epoca, quella che costituisce un immenso immaginario capace di rinforzare le lotte di un intero continente.
La società statunitense, invece, mostra un approccio molto differente riguardo alle conseguenze sociali e politiche dell’introduzione nel mondo del lavoro di macchine molto complesse. Come nella cultura europea, è chiaro che il progressivo perfezionamento delle tecnologie richiede l’adattamento della classe operaia al sistema di regole e orari necessario ai nuovi mondi macchinici, ma questo sistema di dominio è destinato a estendersi sistematicamente fuori dalle fabbriche e a riconfigurare il mondo intero e il tempo di vita offrendo al potere la possibilità di estendere il disciplinamento scientifico del lavoro all’intera esistenza umana. Le distopie che leggiamo, spesso concentrate sulla sofferenza dell’uomo liberale privato della propria libertà, in prima misura personale e solo secondariamente collettiva, sono la rappresentazione letteraria di una società configurata con le regole della fabbrica che nuove tecnologie rendono possibili e sempre più efficaci. Anzi le nuove tecnologie sembrano offrire un ulteriore livello di 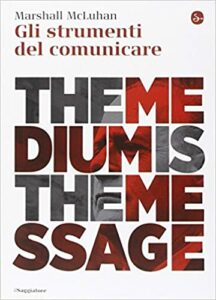 disciplinamento. Marshall McLuhan nel saggio Gli strumenti del comunicare aveva scritto: “Dopo oltre un secolo di impiego tecnologico dell’elettricità, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in un abbraccio globale che, almeno per quanto concerne il nostro pianeta, abolisce tanto il tempo quanto lo spazio. Ci stiamo avvicinando rapidamente alla fase finale dell’estensione dell’uomo: quella in cui attraverso la simulazione tecnologica, il processo creativo di conoscenza verrà collettivamente esteso all’intera società umana, proprio come tramite i vari media abbiamo esteso i nostri sensi e i nostri nervi.”[6] La visione rigorosamente antropologica e funzionale di McLuhan neppure sfiora la dimensione politica e le logiche di potere che la diffusione novecentesca delle tecnologie è in grado di attuare, semplicemente ne osserva l’evoluzione evitando di riflettere sulla riconfigurazione che dei corpi e delle loro menti che un tale “ambiente” richiede. Un esempio per tutti ce lo offre il capolavoro di Alan Parker, il film distopico The Wall (1982), che riprende il filo narrativo dell’omonimo album dei Pink Floyd. Una misteriosa macchina didattica collegata a una catena di montaggio trasforma i giovani inglesi prima in studenti senza volto e poi in carne tritata. Sono, insomma, i nuovi Morlock.
disciplinamento. Marshall McLuhan nel saggio Gli strumenti del comunicare aveva scritto: “Dopo oltre un secolo di impiego tecnologico dell’elettricità, abbiamo esteso il nostro sistema nervoso centrale in un abbraccio globale che, almeno per quanto concerne il nostro pianeta, abolisce tanto il tempo quanto lo spazio. Ci stiamo avvicinando rapidamente alla fase finale dell’estensione dell’uomo: quella in cui attraverso la simulazione tecnologica, il processo creativo di conoscenza verrà collettivamente esteso all’intera società umana, proprio come tramite i vari media abbiamo esteso i nostri sensi e i nostri nervi.”[6] La visione rigorosamente antropologica e funzionale di McLuhan neppure sfiora la dimensione politica e le logiche di potere che la diffusione novecentesca delle tecnologie è in grado di attuare, semplicemente ne osserva l’evoluzione evitando di riflettere sulla riconfigurazione che dei corpi e delle loro menti che un tale “ambiente” richiede. Un esempio per tutti ce lo offre il capolavoro di Alan Parker, il film distopico The Wall (1982), che riprende il filo narrativo dell’omonimo album dei Pink Floyd. Una misteriosa macchina didattica collegata a una catena di montaggio trasforma i giovani inglesi prima in studenti senza volto e poi in carne tritata. Sono, insomma, i nuovi Morlock.
Autori statunitensi come David F. Noble, Howard P. Segal e Jeremy Rifkin leggono con attenzione il rapporto tra sogno americano, tecnologia e utopia. Senza negare l’esistenza di visioni antitecnologiche di natura religiosa e conservatrice, legate alla tradizione quacchera e caratterizzante gli immensi territori extraurbani, la migrazione del pensiero utopista europeo negli Stati Uniti incontra spazi quasi infiniti e una forte realtà di autogoverno del mondo contadino. Rifkin scrive nel suo classico La fine del lavoro: “In questi spazi fantasmagorici l’America, e soprattutto gli Stati Uniti, occupano un posto d’onore: dal vangelo del profitto alla conquista di nuove frontiere, dalle corse all’oro (…) alla scalata degli spazi (il continente, la terra, il cosmo), il sogno è il sacro nutrimento del popolo americano, la transustanziazione della sua pratica storica, mentre per gli europei è l’allegoria”[7]. Inoltre, con il concludersi della colonizzazione della Terra e il restringersi, fino a sparire, delle zone inesplorate, comporta che le città utopiche sorte in luoghi ancora sconosciuti si debbano trasformare in città future. È questo il passaggio chiave che porta queste teorizzazioni dal trattato etico e morale della tradizione utopistica alla fantascienza, genere che è nato proprio con il progetto di raccontare l’impatto tra nuove tecnologie e umanità. Non dimentichiamo che il socialismo, a partire dalla laicizzazione dell’escatologia cristiana, pone la possibilità di determinare la forma sociale del futuro come una forma di organizzazione più equa trasferendo le proprietà dai capitalisti alla classe operaia, mentre l’utopismo statunitense sostiene che il lavoro delle macchine avrebbe sostituito quello operaio, descrivendo “un futuro nel quale le macchine avrebbero sostituito la manodopera, creando una società senza lavoro, di abbondanza e divertimento” (J. 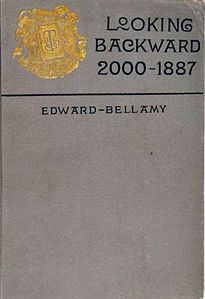 Rifkin). Il testo più importante di questa tradizione è Guardando indietro di Edward Bellamy, pubblicato nel 1888. Julian West, il protagonista del romanzo, a seguito di una seduta di ipnosi, si ritrova nella Boston dell’anno 2000. Il sistema economico del futuro è il capitalismo di stato controllato da un esecutivo tecnico-politico che governa i mezzi di produzione e divide equamente il profitto tra tutti i cittadini. Un’organizzazione chiamata Esercito Industriale ha il compito operativo di attribuire le mansioni ai cittadini e distribuire le merci che sono in visione in enormi magazzini e consegnate direttamente nelle abitazioni attraverso un sistema capillare di posta pneumatica. Ogni cittadino ha ricevuto una formazione universitaria e deve lavorare fino a quarantacinque anni. Musica e libri sono disponibili gratuitamente.
Rifkin). Il testo più importante di questa tradizione è Guardando indietro di Edward Bellamy, pubblicato nel 1888. Julian West, il protagonista del romanzo, a seguito di una seduta di ipnosi, si ritrova nella Boston dell’anno 2000. Il sistema economico del futuro è il capitalismo di stato controllato da un esecutivo tecnico-politico che governa i mezzi di produzione e divide equamente il profitto tra tutti i cittadini. Un’organizzazione chiamata Esercito Industriale ha il compito operativo di attribuire le mansioni ai cittadini e distribuire le merci che sono in visione in enormi magazzini e consegnate direttamente nelle abitazioni attraverso un sistema capillare di posta pneumatica. Ogni cittadino ha ricevuto una formazione universitaria e deve lavorare fino a quarantacinque anni. Musica e libri sono disponibili gratuitamente.
A partire dall’enorme successo del libro di Bellamy, negli Stati Uniti si sviluppa una cultura utopistica che vede nella tecnologia pubblica la chiave per eliminare la fatica, la ripetitività e il rischio dal lavoro, per elevare socialmente la classe dei lavoratori ed eliminare il parassitismo delle classi dirigenti, arricchitesi generazione dopo generazione all’interno di un sistema di privilegi. E sarà proprio la prima fantascienza, quella delle riviste popolari chiamate pulp, a teorizzare la scomparsa delle nazioni e lo svilupparsi di uno stato mondiale gestito da un’unica classe tecnica, stabilire la parità tra i sessi e disegnare nuove forme delle città. Tuttavia, in Europa, a partire dalla Prima Guerra Mondiale, diventa evidente che al progredire delle tecnologie corrisponde una maggiore capacità distruttiva e un rafforzamento dei poteri elitari. Non è solo il rischio paventato da Marx di un’applicazione della legge del profitto che condanni i lavoratori a produrre di più, lavorando sempre più ore e senza un aumento della paga, ma una trasformazione antropologica del potere. La moda frivola che negli ultimi tempi ha colpito il termine distopico, diventato di uso comune e utilizzato con un senso improprio, sta tentando di alterarne l’ambito squisitamente politico, ma il suo significato rimane, ovvero il fallimento dell’utopia e l’instaurarsi dello stato totalitario.
I motivi per cui le utopie si trasformano in distopie sono sostanzialmente due: l’utopia parziale e l’utopia statica. Le utopie parziali sono quelle che costruiscono società egualitarie e felici, ma delimitate, coinvolgono solo specifici territori o tipologie di abitanti. Anzi spesso occultano sfruttamenti esterni crudeli e violenti. Un esempio lo possiamo trovare nel mondo descritto dalla serie portoghese 3% (2016), ideata da Pedro Aguilera, dove un’idilliaca isola tropicale è la sede di una microsocietà ecologica chiamata Offshore, in cui regnano l’abbondanza, la raffinatezza e l’eguaglianza tra gli abitanti. Tuttavia quel benessere è garantito dall’assoluta povertà di una terra desolata e povera, senz’acqua e cibo, abbandonata alla violenza, l’Entroterra. La scelta dei fondatori di questa colonia utopica è di rendere sterili gli abitanti e di garantirsi il ricambio generazionale attraverso una selezione a cui sono posti annualmente i giovani dell’Entroterra. I migliori abbandoneranno i quartieri degradati dell’Entroterra, per entrare a fare parte dell’élite, i perdenti trascorreranno la loro esistenza nella miseria accuratamente pianificata. In qualche modo 3% ripropone il tema dell’utopia dei pochi che era alla base del film Zardoz (1974), diretto da John Boorman, dove in un mondo regredito e selvaggio garantisce il cibo agli abitanti del Vortex, una città tecnologica e chiusa da una cupola in cui i privilegiati abitanti sono indifferenti alle sofferenze che patiscono coloro che sono tenuti fuori. In generale, sul modello de La macchina del tempo di Wells, gli abitanti di queste utopie parziali e privilegiate sono gli eredi delle classi dirigenti che, grazie alle risorse che hanno espropriato e sottratto alle comunità, sono in grado di allontanarsi e fuggire da un mondo diventato, a causa loro, inospitale, sovrappopolato e violento. Non è un caso che storicamente lo stesso fascismo tedesco, il nazismo, abbia a più riprese evocato componenti utopiche da riservarsi ai soli ariani, sia nella progettazione delle città affidata all’architetto Albert Speer sia ai frequenti richiami della propaganda che ostentava la ricerca della felicità per i tedeschi. Non serve specificare quanto questo utopismo fosse patologico e progettato su una piramide razziale che riservava la possibilità di accedervi solo a chi poteva vantare il necessario livello di purezza. Agli altri toccava subire discriminazione, terrore e schiavitù. Infatti, liquidate le prime esperienze utopiche tipiche di un mondo ancora inesplorato, l’utopia, se vuole evitare la caduta distopica, non può che richiedere l’universalità dei suoi principi su tutto il pianeta.
La discussione dell’utopia statica ci riporta invece alle considerazioni dell’inizio, alla necessità di porre in discussione costantemente il sistema di regole su cui una società si basa. A capire che sistemi di regole resisi necessari nelle emergenze devono essere abbandonati e ridiscussi appena possibile. Sicuramente il modello storico di riferimento è quello dell’involuzione della Rivoluzione Bolscevica, un fattore che non si limita necessariamente ai soli anni di Stalin, ma che affonda le sue origini nel periodo della guerra civile, nella gestione delle emergenze, nell’instaurarsi di nuove discipline, nella militarizzazione della classe operaia. Oggi possiamo scorgere, alla distanza di un secolo, quanto l’esperienza bolscevica sia stata influenzata dai fattori di aggressività esterna che hanno consentito il prevalere delle componenti più autoritarie, intrinsecamente più adatte a gestire la guerra, sacrificando gli aspetti di partecipazione dal basso, di diffusione della libertà e di autogestione. Senza dimenticare la miseria, la condizione di schiavitù, la precarietà e la mancanza di ogni diritto in cui versavano da secoli le popolazioni della Russia, della Cina, della Cambogia, del Vietnam e di ogni nazione in cui siano avvenute rivoluzioni che hanno sovvertito le strutture di classe per imporre regimi autoritari, è evidente che il trauma europeo è quello della rivoluzione tradita, la delusione di un evento da cui, soprattutto gli intellettuali, si aspettavano molto di più della proletarizzazione dell’intera società. Nella raccolta di Marco Sommariva sono molti i  romanzi che rileggono l’involuzione rivoluzionaria, da Noi di Evgenij Zamjatin a R.U.R. di Karel Čapek, per approdare a 1984 di George Orwell, il romanzo che più di tutti crea il canone della distopia, definendone le funzioni e il suo registro etico. Non è un caso che la società di 1984 sia caratterizzata da una guerra continua in cui i tre grandi stati alternano le loro alleanze, ma il conflitto che conta è quello interno, quello del Socing, il socialismo inglese, contro la sua stessa società. E per vincere la guerra interna, c’è bisogno di una guerra esterna che giustifichi sacrifici, riduzione della libertà, stato di emergenza e coprifuoco. In questo modo Orwell riporta la sua Gran Bretagna alla situazione dell’Unione Sovietica staliniana, accerchiata dalle potenze mondiali, ma concentrata sull’istituzione di un forte biopotere. Giulia, la protagonista femminile di 1984, infatti dubita che la guerra esterna esista veramente: “Julia lo lasciò di stucco affermando con noncuranza che secondo lei questa guerra non esisteva. Le bombe-razzo che cadevano tutti i giorni su Londra erano probabilmente sganciate dallo stesso governo di Oceania, «per mantenere la gente nella paura»”. È dunque una società oppressiva per consentire alle strutture di oppressione il mantenimento del loro potere, un potere che dipende da quelle particolari condizioni di instabilità e che finirebbe se si realizzasse il socialismo libertario che Orwell non ha mai mancato di seguire. Non è un caso che in 1984, in più punti, ci si riferisca ai prolet come l’unica possibilità per uscire dall’oppressione del Partito, e non a una classe intellettuale o borghese per ristabilire quelle libertà assolutamente individuali a cui si richiama costantemente uno scrittore come Anthony Burgess, pessimista e incapace di concepire società con un’aspirazione collettiva. Per Orwell, invece, si doveva riprendere faticosamente la strada della libertà globale, della lotta alla superstizione e al dogmatismo politico, del coinvolgimento degli strati più bassi della popolazione nella gestione del potere, come era stato in Spagna per un breve periodo. Dunque l’utopia deve essere dinamica o muore, non devono esserci obiettivi raggiunti da difendere in eterno, affidando a nuove élite poliziesche il compito di reprimere ogni critica di quel sistema. Ma Eduardo Galeano lo ha detto, utopia è camminare e la distopia è fermarsi.
romanzi che rileggono l’involuzione rivoluzionaria, da Noi di Evgenij Zamjatin a R.U.R. di Karel Čapek, per approdare a 1984 di George Orwell, il romanzo che più di tutti crea il canone della distopia, definendone le funzioni e il suo registro etico. Non è un caso che la società di 1984 sia caratterizzata da una guerra continua in cui i tre grandi stati alternano le loro alleanze, ma il conflitto che conta è quello interno, quello del Socing, il socialismo inglese, contro la sua stessa società. E per vincere la guerra interna, c’è bisogno di una guerra esterna che giustifichi sacrifici, riduzione della libertà, stato di emergenza e coprifuoco. In questo modo Orwell riporta la sua Gran Bretagna alla situazione dell’Unione Sovietica staliniana, accerchiata dalle potenze mondiali, ma concentrata sull’istituzione di un forte biopotere. Giulia, la protagonista femminile di 1984, infatti dubita che la guerra esterna esista veramente: “Julia lo lasciò di stucco affermando con noncuranza che secondo lei questa guerra non esisteva. Le bombe-razzo che cadevano tutti i giorni su Londra erano probabilmente sganciate dallo stesso governo di Oceania, «per mantenere la gente nella paura»”. È dunque una società oppressiva per consentire alle strutture di oppressione il mantenimento del loro potere, un potere che dipende da quelle particolari condizioni di instabilità e che finirebbe se si realizzasse il socialismo libertario che Orwell non ha mai mancato di seguire. Non è un caso che in 1984, in più punti, ci si riferisca ai prolet come l’unica possibilità per uscire dall’oppressione del Partito, e non a una classe intellettuale o borghese per ristabilire quelle libertà assolutamente individuali a cui si richiama costantemente uno scrittore come Anthony Burgess, pessimista e incapace di concepire società con un’aspirazione collettiva. Per Orwell, invece, si doveva riprendere faticosamente la strada della libertà globale, della lotta alla superstizione e al dogmatismo politico, del coinvolgimento degli strati più bassi della popolazione nella gestione del potere, come era stato in Spagna per un breve periodo. Dunque l’utopia deve essere dinamica o muore, non devono esserci obiettivi raggiunti da difendere in eterno, affidando a nuove élite poliziesche il compito di reprimere ogni critica di quel sistema. Ma Eduardo Galeano lo ha detto, utopia è camminare e la distopia è fermarsi.
[1] Eduardo Galeano, Parole in cammino, Milano, Sperling & Kupfer, 2006.
[2] Italo Calvino, Le città invisibili, 1972, Milano, Mondadori, 2016.
[3] Antonio Tabucchi, Il filo dell’orizzonte, 1986, Milano, Feltrinelli, 2014.
[4] Darko Suvin, Le metamorfosi della fantascienza, 1979, Bologna, Il Mulino, 1985
[5] Karl Marx, “Frammento sulle macchine”, in «Quaderni Rossi» n. 4, Roma, Nuove Edizioni Operaie, 1964
[6] Marshall McLuhan, Gli strumenti del comunicare, 1964, Milano, Saggiatore, 2015.
[7] Jeremy Rifkin, La fine del lavoro, 1995, Milano, Mondadori, 2002.
Dalla prefazione del volume Ombre dal futuro.
Prefazione. A morte il Grande Fratello di Domenico Gallo
1. La Terra Australe di Gabriel de Foigny (1676)
2. I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1726)
3. L’ultimo uomo di Mary Shelley (1826)
4. Tempi difficili di Charles Dickens (1854)
5. Erewhon di Samuel Butler (1872)
6. I cinquecento milioni della Bégum di Jules Verne (1879)
7. La terra delle tenebre di Margaret Oliphant (1888)
8. Un racconto del XX secolo di Ignatius Donnelly (1890)
9. La macchina del tempo di Herbert George Wells (1895)
10. Il risveglio del dormiente di Herbert George Wells (1899)
11. Le meraviglie del Duemila di Emilio Salgari (1907)
12. Il tallone di ferro di Jack London (1907)
13. Il padrone del mondo di Robert Hugh Benson (1907)
14. L’altra parte di Alfred Kubin (1908)
15. Guerra alla Cina. L’inaudita invasione di Jack London (1910)
16. La principessa delle rose di Luigi Motta (1911)
17. La peste scarlatta di Jack London (1912)
18. L’osteria volante di Gilbert K. Chesterton (1914)
19. R.U.R. Rossum’s Universal Robots di Karel Čapek (1921)
20. Noi di Evgenij Zamjatin (1924)
21. Metropolis di Thea von Harbou (1925)
22. Blocchi di Ferdinand Bordewijk (1931)
23. Il mondo nuovo di Aldous Huxley (1932)
24. Da noi non può succedere di Sinclair Lewis (1935)
25. La notte della svastica di Katharine Burdekin (1937)
26. Il mal bianco di Karel Čapek (1937)
27. L’uomo è forte di Corrado Alvaro (1938)
28. Antifona di Ayn Rand (1938)
29. Schiavi degli invisibili di Eric Frank Russell (1939)
30. L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares (1940)
31. Kallocaina di Karin Boye (1940)
32. Buio a mezzogiorno di Arthur Koestler (1940)
33. La fattoria degli animali di George Orwell (1945)
34. Un mondo sinistro di Vladimir Nabokov (1947)
35. La peste di Albert Camus (1947)
36. 1984 di George Orwell (1949)
37. Piano meccanico di Kurt Vonnegut (1952)
38. Il richiamo del corno di Sarban (1952)
39. I mercanti dello Spazio di Frederik Pohl e Cyril M. Kornbluth (1953)
40. Abissi d’acciaio di Isaac Asimov (1953)
41. Fahrenheit 451 di Ray Bradbury (1953)
42. Il signore delle mosche di William Golding (1954)
43. Io sono leggenda di Richard Matheson (1954)
44. Belmoro di Corrado Alvaro (1957)
45. Giustizia facciale di Leslie Poles Hartley (1960)
46. Ritorno dall’universo di Stanislaw Lem (1961)
47. Arancia meccanica di Anthony Burgess (1962)
48. L’isola di Aldous Huxley (1962)
49. Il seme inquieto di Anthony Burgess (1962)
50. Storie naturali di Primo Levi (1966)
51. L’epidemia di Per Wahlöö (1968)
52. Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick (1968)
53. Diario della Guerra al Maiale di Adolfo Bioy Casares (1969)
54. Epepe di Ferenc Karinthy (1970)
55. Vizio di forma di Primo Levi (1971)
56. Il gregge alza la testa di John Brunner (1972)
57. L’uomo che voleva essere colpevole di Henrik Stangerup (1973)
58. Lo smeraldo di Mario Soldati (1974)
59. I viaggiatori della sera di Umberto Simonetta (1976)
60. Dissipatio H.G. di Guido Morselli (1977)
61. 1984 e 1985 di Anthony Burgess (1978)
62. L’ombra dello scorpione di Stephen King (1978)
63. Il pianeta irritabile di Paolo Volponi (1978)
64. Futuro in trance di Walter Tevis (1980)
65. Neuromante di William Gibson (1984)
66. Gli Antimercanti dello Spazio di Frederik Pohl (1984)
67. Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood (1985)
68. L’incarico di Friedrich Dürrenmatt (1986)
69. La parabola del seminatore di Octavia E. Butler (1993)
70. Cecità di José Saramago (1995)
71. Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro (2005)
72. La scuola dei disoccupati di Joachim Zelter (2006)
73. La strada di Cormac McCarthy (2006)
74. Utopia di Ahmed Khaled Tawfiq (2011)
75. Il Cerchio di Dave Eggers (2013)
76. Il condominio di Via della Notte di Maria Attanasio (2013)
77. Sottomissione di Michel Houellebecq (2015)
78. Qualcosa, là fuori di Bruno Arpaia (2016)
79. Orologi rossi di Leni Zumas (2018)
80. Il muro di John Lanchester (2019)
81. Avrai i miei occhi di Nicoletta Vallorani (2020)
82. Melma rosa di Fernanda Trías (2022)
Postfazione. La distopia oggi di Marco Piracci



