di Franco Pezzini
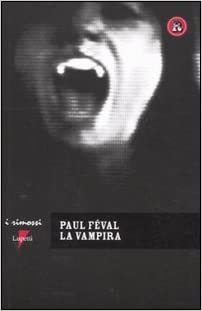 Nella lunga storia della letteratura vampiresca, un titolo immeritatamente poco noto è La vampira di Paul Féval. Immeritatamente per almeno due motivi. Anzitutto si tratta di un romanzo di enorme suggestione: non un capolavoro della letteratura, ma un testo ottocentesco che mette a frutto il meglio dell’evoluzione coeva del feuilleton nel precipitare il lettore in una storia onirica, tragica e grottesca. E poi il racconto trattiene echi genuinamente provocatori: lo scorcio sull’amministrazione napoleonica coi suoi maneggioni, i funzionari arrampicatori, presuntuosi e vanesî, e il rapporto con altri tipi di vampirismo (sociale, politico) permettono alcuni sberleffi critici che adattiamo volentieri ai nostri giorni.
Nella lunga storia della letteratura vampiresca, un titolo immeritatamente poco noto è La vampira di Paul Féval. Immeritatamente per almeno due motivi. Anzitutto si tratta di un romanzo di enorme suggestione: non un capolavoro della letteratura, ma un testo ottocentesco che mette a frutto il meglio dell’evoluzione coeva del feuilleton nel precipitare il lettore in una storia onirica, tragica e grottesca. E poi il racconto trattiene echi genuinamente provocatori: lo scorcio sull’amministrazione napoleonica coi suoi maneggioni, i funzionari arrampicatori, presuntuosi e vanesî, e il rapporto con altri tipi di vampirismo (sociale, politico) permettono alcuni sberleffi critici che adattiamo volentieri ai nostri giorni.
Diciamola tutta, l’autore è un personaggio un po’ particolare. Paul Henri Corentin Féval, cioè Féval padre (1816-1887) e suo figlio Paul Féval, cioè Féval figlio (1860-1933) con le loro opere mappano idealmente tutta l’epoca del feuilleton (alla grossa dagli anni trenta dell’Ottocento agli anni trenta del secolo successivo) e un po’ tutti i temi del medesimo, dal cappa-e-spada al poliziesco, dal gotico alla fantascienza, nelle declinazioni peculiari e folli che la produzione popolare francese contrappone a quella più canonicamente strutturata inglese. Ma se Féval figlio, apprezzabile e divertente, sta al padre come Dumas figlio al titanico genitore, è vero che in Italia conosciamo comunque assai meglio i due padri: il lettore comune non ha modo di apprezzare le specificità ad ampio raggio delle rispettive produzioni, e per esempio di Dumas figlio ricorda solo La signora delle camelie (e quasi soltanto per l’ispirazione a La traviata di Giuseppe Verdi). Scusandoci dunque con Féval figlio, lo mettiamo da parte e passiamo a suo padre, autore de La vampira e di un’altra settantina di romanzi.
Certamente non è un progressista: monarchico di famiglia, conservatore per convinzioni, celebratore continuo della Chouannerie, autore di Monsieur de Charette, nota anche come Prends ton fusil Grégoire (1853), destinata a divenire una delle più famose canzoni monarchiche francesi, Féval resta interessante per la sua scrittura, con uno stile obliquo particolarissimo speziato d’ironia, spesso ellittico, a tratti fortemente onirico. Non è male ricordare ai lettori nostrani, spesso plagiati da meccanismi di lottizzazione ideologica di piccolo cabotaggio, che uno scrittore è degno di attenzione anzitutto per le sue qualità letterarie – se ci sono – e che “Questo è nostro” è un atteggiamento imbecille, che squalifica chi lo proclama; che una critica sana cerca di capire cosa l’autore intenda e non si basa su cosa noi vogliamo fargli dire, magari a fini di arruolamento di utili idioti in conventicole altrimenti un po’ disertate per impresentabilità. E si può giustamente biasimare un certo politicamente corretto che banalizza le qualità letterarie di un autore ricordandone ambiguità sgradevolezze cadute personali (anche se è chiaro che la geremiade viene a volte elevata in modo peloso da piccoli fautori di ciò che resta il politicamente infame, o da chi sta giocando di sponda per trovare attenzione in quei giri). Certo, si ha a tratti la sensazione anche qui che gli eroi di Féval mantengano robuste ambiguità, ma La Vampire (serializzato 1855, pubblicato 1865) non è fastidiosamente ideologico e in qualche misura su quegli aspetti gioca con intelligenza.
Nella Parigi 1804 della scalata al potere di Napoleone, che si avvia alla corona, si verificano strane sparizioni di stranieri o gente della provincia, compaiono nella Senna cadaveri (a volte veri, a volte farlocchi) e si vocifera della presenza di una vampira responsabile delle nefandezze: questo strano romanzo è tutto giocato sul filo tra effettive realtà oscure e – potremmo dire – mito metropolitano nel grembo torbido di una città-labirinto, di fascino straniante. Una Parigi che l’autore conosce bene e dove ci muoviamo su pavimentazioni lucide d’acqua, tra sordide bettole e passaggi segreti, chiese per nulla tranquillizzanti e palazzotti dai mille misteri in un tessuto urbano sfuggente che sembra dilatarsi sotto i nostri piedi: uno sfondo dove prolifera socialmente una città più antica sopravvissuta alla rivoluzione e ai successivi cambi di potere. Di grande fascino, anche, l’affilata comparazione tra questa Parigi e una Londra terribile, losca e viziosa cui l’autore ha dedicato sotto lo pseudonimo di Francis Trolopp (a giocare sul nome della famosa scrittrice inglese Frances Milton Trollope, madre di Anthony Trollope) uno dei suoi primi romanzi, Les Mystères de Londres (1843-44): nonostante l’amicizia con Dickens (dal 1863), Féval non si crea certo problemi a parlar male dei vicini di Albione. Tanto più che un suo omologo inglese, George W. M. Reynolds, prolifico autore di quei penny-dreadful che del feuilleton francese costituiscono una sorta di controparte britannica, ha avuto l’ardire di varare a sua volta un’opera The Mysteries of London (1844-48). Féval lamenta un plagio, ed è possibile che Reynolds sappia del suo volume visto che spesso è in Francia ed è cittadino francese naturalizzato: ma in fondo sia Reynolds che Féval si rifanno al modello Les Mystères de Paris di Eugène Sue (1842-43), dunque anche Féval che protesta contro la pirateria inglese farebbe bene a ricordare che lui stesso riprende schemi altrui (e che a proposito di Londra pretenda di parlarne un inglese non è strano).
Che Stoker e soprattutto Le Fanu, amico di Dickens, possano aver letto o almeno conoscere i titoli e le storie vampiresche di Féval non è certo, ma sembra almeno ipotizzabile; e mi pare possibile che in Italia l’abbia letto Franco Mistrali, autore del pionieristico Il Vampiro. Storia Vera, 1869 (che – qui ammetto il mio amichevole disaccordo con il recensore Matteo Mancini in occasione della riproposta del testo per Arcoiris, 2020 – francamente fatico a immaginare letto da Stoker: mentre alcune scelte di Mistrali, legate a topoi di largo uso all’epoca, potrebbero spiegarsi in riferimento a questo romanzo di Féval).
Va detto che in parte il carattere sfuggente della vicenda è legato alle allusioni non sempre trasparenti a una puntata precedente, un altro romanzo di Féval dove già sono presenti alcuni dei personaggi, La Chambre des amours (1849), e insieme i due romanzi verranno presentati nel volume Les Drames de la mort (1866). Ma è chiaro che, con una certa obliquità, il Nostro va a nozze; e proprio l’inafferrabilità della vampira, fatta di voci incontrollabili, oniriche nella sghemba assurdità dei fatti a cui si appigliano, è uno degli aspetti più suggestivi e stranianti del romanzo. Dove troviamo le solite cospirazioni da feuilleton, in parte storiche – l’attentato a Napoleone della cosiddetta “macchina infernale”, esplosa la notte di Natale 1800, il ruolo del congiurato filoborbonico Georges Cadoudal… – e in parte fantastiche; bozzetti pittoreschi ed eccessivi, volutamente sopra le righe, dei membri della società segreta Fratelli della Virtù (l’italiano Andrea Ceracchi gemello del cospiratore Giuseppe, l’haitiano Taïeh detto le nègre devoto al defunto Toussaint Louverture, il gallese antibritannico Kaërnarvon, il mamelucco Osman che mira a vendicare la sconfitta delle Piramidi…), modellata sulla storica Tugendbund attiva in Prussia tra il 1808 e il 1810; nonché saltuarie occhiate di sguincio verso i Balcani e quell’Ungheria da dove giunge una certa contessa Marcian Gregoryi molto misteriosa e pericolosamente bella.
Già, l’Ungheria. Tra le fonti di Féval si possono in effetti ipotizzare la seminale Dissertazione di Dom Calmet che tanto spazio dedica alle remote Ungherie e un’opera che a Dom Calmet pure attinge, La Vampire, ou La Vierge de Hongrie di Etienne-Léon Lamothe-Langon (1825, a sua volta debitrice di Dom Calmet), la cui trama ambientata nel 1815 coinvolge anche Napoleone. Vi compare, undici anni prima della morta innamorata di Gautier, la prima vera vampira della letteratura francese: Alinska, una ragazza ungherese a cui durante le campagne napoleoniche il giovane ufficiale Edouard Delmont aveva promesso il matrimonio e che ora riappare nella vita del fedifrago sposato con un’altra, secondo un plot di solito declinato come storia di fantasmi. D’altra parte a ispirare La vampire di Féval potrebbe essere stata l’uscita di un dramma teatrale in cinque atti Le vampire di Dumas e Auguste Maquet (1851), sull’onda del successo del Ruthven polidoriano assurto a maschera archetipica del vampiro maschio come poi lo sarà Dracula: il succhiasangue Lord Ruthwen (sic, con la w, come in genere nei testi francesi) vi incontra una gula (ghoul-femmina) dai poteri magici che morirà da eroina romantica. Insomma, in Francia il tema del morto vivente sembra strettamente legato a quello di passioni divoranti o – appunto – vampiresche.
 Protagonista della vicenda di Féval è l’anziano prevosto d’armi Jean-Pierre Sévérin detto Gâteloup, capo dei muratori del cantiere del Marchè-Neuf, nonché guardia giurata della Morgue, dall’aria del bravo borghese e in realtà abile come un agente segreto. Troviamo poi la coppietta destinata a una tragica divisione, la sua figliastra Angèle e il giovane René de Kervoz, nipote di quel Cadoudal che si fa conoscere come Morinière; c’è un improvvisato cacciavampiri piccoletto, lo studente di medicina Germain Patou devoto all’omeopatia di Samuel Hahnemann (sprofondato nella depressione, Féval stesso era stato curato omeopaticamente dal dottor Pénoyée, di cui aveva poi sposato la figlia); c’è il burocrate Berthellemot, segretario generale alla prefettura… e naturalmente c’è lei, la contessa Gregoryi, una e multipla nelle sue identità (Marcian, Lila, Addhéma…) e nei suoi doppi e tripli giochi, quasi a rifrangere in forma di Legione la pluralità di nomi, titoli e ruoli di altri personaggi, primi tra i quali Gâteloup, Cadoudal e lo stesso Napoleone. Corpi in possesso di molte identità o identità singole in possesso di molti corpi, che tendono a sperdere il lettore e rendono la lettura piuttosto complicata: ma il fantasismo è voluto, e, nel caso della contessa, questa molteplicità identitaria svela qualcosa di fantasiosamente disturbante, moltiplicando le ombre già disseminate da mille punti luce lividi, a denunciare come sfuggente la realtà stessa di un’epoca. In fondo proprio la società segreta, ha notato qualche lettore, è un’altra identità di Parigi, una controsocietà rispetto a quella borghese in corso di assestamento. Per chi sia interessato, oggi su Féval online non mancano testi di critica o persino tesi di laurea: anni fa avvicinare l’autore era molto più complicato, anche se talora restano nell’aria giudizi critici poco generosi. La vampire non è certamente letteratura “alta”, ma costituisce un romanzo gotico godibile, di buon mestiere e dalle atmosfere affascinanti. A pubblicare La vampira in Italia è Lupetti, Milano 2011, trad. dal francese di Clara Lovisetti, nella collana “i rimossi” (faccio riferimento a tale edizione).
Protagonista della vicenda di Féval è l’anziano prevosto d’armi Jean-Pierre Sévérin detto Gâteloup, capo dei muratori del cantiere del Marchè-Neuf, nonché guardia giurata della Morgue, dall’aria del bravo borghese e in realtà abile come un agente segreto. Troviamo poi la coppietta destinata a una tragica divisione, la sua figliastra Angèle e il giovane René de Kervoz, nipote di quel Cadoudal che si fa conoscere come Morinière; c’è un improvvisato cacciavampiri piccoletto, lo studente di medicina Germain Patou devoto all’omeopatia di Samuel Hahnemann (sprofondato nella depressione, Féval stesso era stato curato omeopaticamente dal dottor Pénoyée, di cui aveva poi sposato la figlia); c’è il burocrate Berthellemot, segretario generale alla prefettura… e naturalmente c’è lei, la contessa Gregoryi, una e multipla nelle sue identità (Marcian, Lila, Addhéma…) e nei suoi doppi e tripli giochi, quasi a rifrangere in forma di Legione la pluralità di nomi, titoli e ruoli di altri personaggi, primi tra i quali Gâteloup, Cadoudal e lo stesso Napoleone. Corpi in possesso di molte identità o identità singole in possesso di molti corpi, che tendono a sperdere il lettore e rendono la lettura piuttosto complicata: ma il fantasismo è voluto, e, nel caso della contessa, questa molteplicità identitaria svela qualcosa di fantasiosamente disturbante, moltiplicando le ombre già disseminate da mille punti luce lividi, a denunciare come sfuggente la realtà stessa di un’epoca. In fondo proprio la società segreta, ha notato qualche lettore, è un’altra identità di Parigi, una controsocietà rispetto a quella borghese in corso di assestamento. Per chi sia interessato, oggi su Féval online non mancano testi di critica o persino tesi di laurea: anni fa avvicinare l’autore era molto più complicato, anche se talora restano nell’aria giudizi critici poco generosi. La vampire non è certamente letteratura “alta”, ma costituisce un romanzo gotico godibile, di buon mestiere e dalle atmosfere affascinanti. A pubblicare La vampira in Italia è Lupetti, Milano 2011, trad. dal francese di Clara Lovisetti, nella collana “i rimossi” (faccio riferimento a tale edizione).
L’ambiguità è poi rafforzata dal fatto che i vampiri di Féval – presenti qui e in altri due romanzi, Le Chevalier Tènèbre (1860) e La Ville-Vampire (scritto intorno al 1867, edito 1875, riproposto di recente da Iperwriters, 2021), cui si può aggiungere Une histoire de revenants (1881) – non corrispondono tout court al canone che si sta modellando oltremanica, e che riceverà il suo sigillo con Stoker: sia perché le non poche opere sul tema edite in Francia finivano con l’accostare il vampiro ad altre figure spettrali, sia perché Féval si diverte a immaginare creature dai connotati peculiarmente equivoci (qui si cita anche un Faust vampiro), onirici, orridi e a tratti grotteschi. A un primo livello la vampira è la stessa ligue de la vertu, la società segreta; ma c’è un secondo livello molto più strano e fiabesco il cui esito si apprezzerà solo nel finale. Poi va anche detto che l’autore sviluppa il romanzo poco per volta e potrebbe lui stesso non immaginare dove si andrà a parare alla fine.
Il primo vampiro del romanzo, sembra del resto dire Féval, pur non esplicitando mai la suggestione, è quel Napoleone che ha seminato morti a grandi numeri sulle strade del Vecchio Mondo: e il secondo vampiro è la stessa Parigi, vera e propria Ville-Vampire, con i suoi laidi bassifondi, i cadaveri che appaiono o spariscono come navigati fantasisti, la corruzione e i delitti.
I vampiri di Feval non succhiano sangue: al contrario sono (per vari motivi) molto interessati alla ricchezza, sangue di una società; e per spacciarli non basta il solito paletto. Hanno un motto, che la dice lunga anche se zoppica un po’ nel latino, In vita mors, in mors vita. In più Addhéma – la “vampira di Uszel, che la popolazione rivierasca della Save chiamava ‘la bella da capelli cangianti’, perché a volte appariva bruna, a volte bionda, alla gente ammaliata dal suo fascino”, e la cui “tomba, grande quanto una chiesa, fu trovata piena di crani di fanciulle e giovani donne”, in vita nobile bulgara complice in crimini e dissolutezze con il principe di Szandor, ha un altro e particolarissimo tipo di vincolo, “una legge rigorosa la cui infrazione costa al mostro abominevoli torture”. Infatti è in sua facoltà
rinascere bella come l’Amore ogni volta che riusciva a porre sull’odiosa nudità del suo cranio uno scalpo vivo, intendo strappato dalla testa di una persona viva. Ecco perché la sua tomba era piena di crani di giovani donne e bambine. Simile ai selvaggi del Nord America che scorticano i nemici vinti e portano i loro capelli come trofeo, Addhéma sceglieva nei dintorni della sua sepoltura le fronti più belle e più felici per strappare quella preda che le rendeva qualche ora di giovinezza.
Perché la sua bellezza durava solo pochi giorni. Tanti quanti gli anni della vita della sua vittima. Finito quel periodo, bisognava fare un nuovo patto e trovare un’altra vittima.
[…] Ogni volta che Addhéma, la vampira di Uszel, riusciva a scaldare le fredde ossa del suo cranio con l’aiuto di una capigliatura strappata a una persona viva, otteneva qualche giorno, persino settimane, ma a volte solo poche ore, di una nuova vita: una settimana per sette anni, un mese per dieci lustri. Era come un gioco terribile la cui vincita poteva essere grande o piccola; Addhéma non lo sapeva mai in anticipo; ma che cosa importava, dopo tutto? Le ore conquistate, tante o poche che fossero, erano almeno tre di giovinezza, di bellezza e di piacere perché Addhéma ritornava ogni volta la splendida cortigiana di un tempo, con la sua passione di fuoco e un fascino irresistibile.
Ma c’è una seconda condizione fatale,
che non poteva infrangere pena la sofferenza di mille morti. Addhéma non poteva darsi a un amante prima di avergli raccontato la sua storia. Nel bel mezzo di un incontro amoroso doveva raccontare quello che ora vi sto dicendo, parlando delle giovani fanciulle morte, delle capigliature strappate e riportare con esattezza la bizzarra situazione della sua morte che era una vita e della sua vita che era una morte…
Premesso che questo tipo di condizioni ricorda la schiavitù dell’anagramma cui è assoggettata la Mircalla di Le Fanu (che diventa Carmilla, Millarca eccetera) e ci si può chiedere se l’irlandese avesse letto il romanzo in oggetto, varie potenti suggestioni fantastiche sono consegnate al lettore. Chiariamo subito che il nesso coi “selvaggi del Nord America” non porta nessun riferimento agli Apaches di Parigi, le bande criminali della Belle Époque: il termine verrà adottato solo nel 1902. Il richiamo pesca piuttosto in una simbolica dei capelli che al tempo sta conducendo a curiosi sviluppi.
Anzitutto attraverso figure mitiche: quei capelli offrono energie, come le chiome sottratte da un’altra vamp leggendaria, la Dalila del libro biblico di Sansone, oltretutto figura archetipica della donna cospiratrice; di più, quei capelli sono vivi, come quelli di un altro mostro-Femmina che nella Parigi rivoluzionaria ha conosciuto un nuovo statuto simbolico, la Gorgone Medusa, attraverso le teste mozzate e tremende (quella sacre del re e della regina, con quanto di tabù violato quel tipo di regicidio evocasse). In generale le seduttive vamp mitiche della letteratura romantica e decadente vantano lunghe chiome nella loro strategia predatrice. D’altra parte, tornando a Napoleone, si è suggerito un richiamo al dipinto di Jacques-Louis David L’incoronazione di Napoleone (Sacre de l’empereur Napoléon Ier et couronnement de l’impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804): la corona sul capo, scalpo ideale dei Borboni decollati, rinnova simbolicamente proprio nel 1804 del romanzo la forza e la gloria della Francia, a prezzo di infinite vite sul campo: e questa dimensione virtualmente vampiresca si rifrange ai tempi dello scrittore, attraverso l’epigono del grande vampiro, il più modesto Napoleone III.
 Ma c’è dell’altro, che può emergere da questo tipo di fantasie e dilaga nella società come una sorta d’infezione. Féval ricorda certamente il successo di massa – fin sulle stoviglie e nelle forme dei gioielli – dell’immagine della ghigliottina: ma, vuoi per paradosso, vuoi come forma di reazione a uno shock sociale, l’impatto toccava anche altre dimensioni della quotidianità. La cosiddetta gioventù dorata non teme di indossare abiti che richiamino le esecuzioni, come quello “à la romaine” delle giovani donne che ricorda evidentemente la camicia delle suppliziate; oppure, sotto il consolato, tagli di capelli corti o – se lunghi – con riporto avanti a liberare il collo, “à la victime”, proprio in memoria del taglio di capelli dei condannati. Medusa stessa è un’immagine di decapitata: se gli scalpi che Addhéma preda sono vivi, lo sono fino a un certo punto perché appartengono a vittime fatte morire; e qualcosa del genere vale per il capo di Medusa, ancora in grado di pietrificare ma appartenente a un mostro morto. C’è un portarsi addosso la vita che è insomma anche un indossare la morte, secondo suggestioni di moda in Francia a ridosso della rivoluzione. Se la Francia dell’Ottocento è la patria di una varietà di acconciature – con connotazioni sessuali più o meno accentuate, come in quelle che vedono capelli lunghi – tali da conoscere nel tempo adattamenti e trasformazioni, questa di Addhéma ne costituisce la lettura macabra e necrofila.
Ma c’è dell’altro, che può emergere da questo tipo di fantasie e dilaga nella società come una sorta d’infezione. Féval ricorda certamente il successo di massa – fin sulle stoviglie e nelle forme dei gioielli – dell’immagine della ghigliottina: ma, vuoi per paradosso, vuoi come forma di reazione a uno shock sociale, l’impatto toccava anche altre dimensioni della quotidianità. La cosiddetta gioventù dorata non teme di indossare abiti che richiamino le esecuzioni, come quello “à la romaine” delle giovani donne che ricorda evidentemente la camicia delle suppliziate; oppure, sotto il consolato, tagli di capelli corti o – se lunghi – con riporto avanti a liberare il collo, “à la victime”, proprio in memoria del taglio di capelli dei condannati. Medusa stessa è un’immagine di decapitata: se gli scalpi che Addhéma preda sono vivi, lo sono fino a un certo punto perché appartengono a vittime fatte morire; e qualcosa del genere vale per il capo di Medusa, ancora in grado di pietrificare ma appartenente a un mostro morto. C’è un portarsi addosso la vita che è insomma anche un indossare la morte, secondo suggestioni di moda in Francia a ridosso della rivoluzione. Se la Francia dell’Ottocento è la patria di una varietà di acconciature – con connotazioni sessuali più o meno accentuate, come in quelle che vedono capelli lunghi – tali da conoscere nel tempo adattamenti e trasformazioni, questa di Addhéma ne costituisce la lettura macabra e necrofila.
Tanto più che i capelli umani sono oggetto di un ampio mercato: ancor oggi, emerge dal web, ma certo con abbondanza in passato. Nel primo Ottocento, in Francia, le parrucche vanno in desuetudine, essendo legate soprattutto – ma non solo – alla classe aristocratica falcidiata dalla rivoluzione, e Addhéma si presenta come aristocratica. Ma i capelli possono essere anche predati: e alla fine dell’Ottocento il feticismo dei capelli fa il suoi ingresso trionfale nei trattati psichiatrici. A volte attraverso grottesche aggressioni da strada per tagliar alle passanti ciuffi di capelli: anche se l’aggressione non è necessaria, come mostra questo caso dalla Psychopathia Sexualis di Richard von Krafft-Ebing.
Caso 147. – Una certa signora X. mi raccontò che la prima e la seconda notte di matrimonio suo marito si era accontentato di baciarla, di affondare le mani nella capigliatura di lei, veramente non abbondante, dopo di che si metteva a dormire. La terza notte, il marito portò a casa una parrucca fittissima di capelli lunghi, e pregò la moglie di mettersela in testa. Tosto ch’essa lo fece, il marito compensò largamente la propria mancanza ai doveri coniugali.
La mattina dopo ricominciò ad essere tenero con la moglie, accarezzando, per incominciare, la parrucca. Appena la signora X. si toglieva la parrucca, che le dava fastidio, perdeva immediatamente ogni attrattiva pel marito. La signora, persuasa che si trattasse di un capriccio, si prestò ai desideri del marito, al quale voleva bene, e la cui concupiscenza e potenza sessuale dipendevano dalla parrucca. Ciascuna parrucca rimaneva efficace solo per 15 o 20 giorni. Doveva essere abbondante; il colore non aveva importanza. L’attivo, del bilancio coniugale era dato, dopo cinque anni, da due bambini e da una collezione di settantadue parrucche.
Dove sembra di estremo interesse il tema della durata di efficacia della parrucca, che fa pensare alla durata diversa di vitalità di quelle usate da Addhéma.
La serialità di morti servili – in funzione banalmente dello scalpo – e l’uso di un sangue che ringiovanisca ha fatto pensare a qualche commentatore che Féval conoscesse la figura di Erzsébet Báthory: in realtà pare implausibile, perché la prima citazione di una certa notorietà del profilo della contessa sanguinaria è quella, come “Elizabeth …”, in The Book of Were-Wolves del sacerdote e mitografo Sabine Baring-Gould, del 1865, dunque troppo tardiva. Féval avrebbe al massimo potuto conoscerla da qualche fonte derivata dall’opera dell’erudito gesuita László Turóczi Tragica historia, 1729 (ma sembra francamente difficile).
 Si è posta comunque in risalto l’estrema, inusuale sensualità del tema qui evocato: Addhéma cerca oro per comprare un bacio – il termine, si è detto, potrebbe in realtà evocare qualcosa di sessualmente molto più vivace – dal suo amante vampiro maschio, Szandor: a presentare l’eros vampirico come sostanzialmente mercenario (ricordiamo che anche la Clarimonde di Gautier viene presentata come una cortigiana). Con tutti gli altri amanti vale però un altro “pagamento”, il tabù di dover narrare la sua storia: e Addhéma lo aggira fingendosi un’altra. Anche se ciò non esclude che a smascherarla possa essere una rivelazione onirica, come qui accade a un certo punto.
Si è posta comunque in risalto l’estrema, inusuale sensualità del tema qui evocato: Addhéma cerca oro per comprare un bacio – il termine, si è detto, potrebbe in realtà evocare qualcosa di sessualmente molto più vivace – dal suo amante vampiro maschio, Szandor: a presentare l’eros vampirico come sostanzialmente mercenario (ricordiamo che anche la Clarimonde di Gautier viene presentata come una cortigiana). Con tutti gli altri amanti vale però un altro “pagamento”, il tabù di dover narrare la sua storia: e Addhéma lo aggira fingendosi un’altra. Anche se ciò non esclude che a smascherarla possa essere una rivelazione onirica, come qui accade a un certo punto.
Ma, come si è detto, vampiro è qui anzitutto Napoleone. Féval non lo sbeffeggia direttamente e nonostante tutto sembra averne un relativo rispetto; ma ne critica il carrozzone di seguaci, la politica come grande meretricio che porta morti a legioni (oggi non più in campagne militari su territorio europeo) e comunque uccide dentro, il potere suppurante in una città labirintica vampira essa stessa. E se, a una lettura odierna del romanzo, di Napoleoni in giro proprio non ne vediamo, il carrozzone è comunque ben saldo e i cortigiani (solo di altro genere) restano al governo. In vita mors, in mors [sic] vita.



