di Francesco Festa
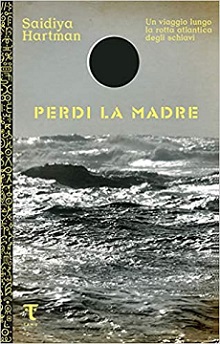 Saidiya Hartman, Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi, trad. Valeria Gennari, Tamu Edizioni, Napoli, 2021, pp. 332, € 18,00
Saidiya Hartman, Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi, trad. Valeria Gennari, Tamu Edizioni, Napoli, 2021, pp. 332, € 18,00
Le parole sono pietre. E come pietre acquisiscono forza quando sono lanciate contro il velo che cela verità evidenti, oppure diventano ancor più potenti se scagliate contro le menzogne spacciate per narrazioni, o peggio, agiscono lapidariamente contro le verità da interdire e da seppellire nelle pieghe della storia. Anche se le parole, diverse eppure uguali, sono le stesse usate per sussurrare le cristalline e coraggiose verità, per lasciare intendere nelle frasi sospese o per gridare a gran voce la verità che va sputata in faccia all’autorità, al potere e all’ordine del discorso borghese.
Il libro di Saidiya Hartman, Perdi la madre. Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi, traduzione di Valeria Gennari, edito in Italia da Tamu Edizioni – cui va immensa gratitudine per l’impegno profuso – è un esercizio di parresìa, un libro dai tratti straordinariamente potenti. Una messa a fuoco del diritto-dovere di parlare con franchezza, del bisogno di sputare in faccia la verità al potere, scarnificando le parole, e quelle d’amore e quelle di odio. È un andirivieni fra passato e presente nella vita di Saidiya Hartman, un movimento a ritroso lungo la tratta atlantica, sulla rotta delle “navi negriere”, dal Nord America verso il continente africano, tentando di dar voce alla diaspora dei dimenticati.
La struttura narrativa infatti si muove su registri di scrittura differenti. Autobiografia che emblematicamente s’inscrive nella cornice storica dell’Africa pre e post-coloniale. Le parole alternano toni aspri, spietati, alla tenerezza che riappare quando l’autrice ricorda il suo passato. Sono parole che ti entrano sotto pelle; trascinano il lettore in un passato sempiterno, nella memoria e nella identità dell’autrice, e che travolgono anche la nostra, di identità, quale cifra storica del continente africano e, all’oggi, dell’Occidente capitalistico.
La tratta degli schiavi incombeva su di me più di qualsiasi ricordo di un glorioso passato africano o di un senso di appartenenza al presente […] Non stavo cercando di scansare i fantasmi della schiavitù, ma di affrontarli. A quale scopo? Questa era l’unica domanda […] Ero nera, ed era stata una storia di terrore ad aver prodotto quell’identità. Il terrore era ‘una prigionia senza possibilità di fuga, violenza senza scampo, vita precaria (pp. 60-61).
Il viaggio di Saidiya Hartman incomincia con questo terrore: quello di un’identità e di una storia poste nel vicolo cieco della storia e di una posizione nella società inamovibile, sebbene l’inquilino della Casa Bianca fosse un figlio della diaspora. Ciò nonostante, da studentessa presso la biblioteca di Yale, va alla ricerca del proprio passato. Una curiosità vitale che la porta ad aprire l’archivio del “Black Atlantic”, da dove vien fuori quella che è la “doppia coscienza”, prendendo in prestito un concetto di Paul Gilroy, quella presente e quella da scacciare, obnubilare della diaspora nera. Il rompicapo che la assale è il riconsiderare la propria appartenenza, l’identità e la memoria, immergendosi sempre più nei documenti e nelle testimonianze degli schiavi dell’Alabama. Attenzione, però, s’incorrerebbe in errore se s’intendesse l’archivio come luogo neutro o addirittura immobile. L’archivio che interroga l’autrice è una raccolta antropologica che parla al presente: un assemblaggio di storie che non potrebbe mai chiudere le porte al passato, perché il presente continua a farle domande che eccedono la sua coscienza.
Le storie di mio padre sul razzismo erano poche. Ricordava di essere stato chiamato negro per la prima volta quando era arruolato nell’aeronautica militare […] ma non l’ho mai sentito pronunciare le parole ‘schiavo’ o ‘schiavitù’ […] Mi imbattei nella mia trisnonna materna durante la mia ricerca di tesi, all’interno di un volume di testimonianze sulla schiavitù in Alabama. Mi sentii entusiasta di averla scovata tra gli scaffali impolverati della biblioteca di Yale […] Quando le era stato chiesto cosa ricordasse della schiavitù, aveva risposto: ‘Proprio nulla’. Mi cadde il mondo addosso. Sapevo che non era vero. Riconoscevo l’esistenza di un mucchio di ragioni che spiegavano la riluttanza della mia trisavola a parlare di schiavitù […] il suo silenzio risvegliò i miei interrogativi sulla memoria e sulla schiavitù: cos’è che decidiamo di ricordare del passato e cos’è che siamo disposti a dimenticare? […] Ero determinata a riempire gli spazi vuoti delle fonti storiche e a rappresentare le vite di quelli ritenuti non degni di essere ricordat” (pp. 30-33)
La sua famiglia e i tanti africani non ricordano, le indicano di andare oltre, obliterando verità che nuocciono. L’assenza di memoria agisce come la sindrome descritta da Frantz Fanon per cui il colonizzato o il “negro” continua ossessivamente a porsi la domanda, e schizofrenicamente ad allontanarla, “Chi sono io in realtà?” È qui che si situa il “grande rimosso”, il non ricordo dei figli della diaspora. Che è, per dirla con Miguel Mellino, anche il grande rimosso della cultura e della filosofia storicista, dove Hegel rimuove dalla narrazione tutto ciò che potrebbe essere un processo di soggettivazione nera (ad esempio, l’insurrezione antischiavista dei neri in Haiti guidata da Toussaint Louverture), definendo “il presupposto politico del tutto in sintonia con l’immaginazione culturale europea sulla missione-condizione storica della borghesia dopo la Rivoluzione francese”, e a sostegno della colonizzazione e dell’inferiorizzazione degli schiavi. Il non ricordare, d’altronde, è la forma mentis del colonizzato, una sorta di “orientalismo” interno, che tiene a debita distanza, vuoi per paura vuoi per assoggettamento, l’invito di Dipesh Chakrabarty, a Provincializzare l’Europa, a liberarsi proprio del pensiero dell’imperialismo e della colonizzazione.
Con il fardello del disincanto, Hartman procede contro i suoi famigliari, ma senza condannarne la scelta, poiché ammette di essere “la reliquia di un’esperienza che i più hanno preferito non ricordare […] un promemoria del fatto che dodici milioni di persone attraversarono l’oceano Atlantico […] schiavizzati.” (p. 34).
Il viaggio a ritroso verso il Ghana (ex Costa d’Oro) ha come prima tappa Accra, dove l’autrice deve fare i conti con il senso di estraniamento, di diffidenza del popolo che la definisce una obruni (straniera) perché nera, ma pur sempre americana (“non importa quanto grandi siano gli occhi di uno straniero, essi non possono vedere”). Così, incomincia a sentire lontane le sue radici, non così facili da riconoscere, sente il peso di una storia africana senza passato, senza gloria, né identità.
Il viaggio va oltre: a centocinquanta chilometri, a Elmina, lungo le nove rotte che conducevano i prigionieri dall’entroterra al mare aperto. Come un segugio, Saidiya Hartman segue le tracce degli oppressi, stipati in magazzini o in città-fortezze e comunità costruite esclusivamente per produrre soggettività schiavizzate. Dal Cinquecento al Seicento, portoghesi, olandesi, inglesi, francesi, danesi, svedesi e brandeburghesi, eressero circa cinquanta avamposti e città permanentemente destinate al commercio di esseri umani. Ancora oggi, il Ghana è la regione con più prigioni e galere di schiavi di tutta l’Africa Occidentale.
Tutti quei terribili dettagli sulla tratta mi tuonavano in testa, e passai la giornata a combattere la nausea […] non riuscivo a liberarmi dalle atrocità commesse durante le guerre di cattura e le razzie di schiavi: anziani e infermi massacrati dall’esercito conquistatore, neonati le cui teste venivano sbattute contro gli alberi fino a ucciderli, donne incinte sventrate con una lancia, ragazze stuprate, giovani uomini sepolti in giganteschi formicai, gettati dentro pire e bruciati vivi. Né riuscivo a togliermi dalla testa ciò che gli storici avevano descritto come la scia di ossa scolorite che dalle zone dell’interno portavano al mare. E neppure a dimenticare le mogli disobbedienti vendute con il pretesto della stregoneria, i giovani attaccabrighe condannati alla schiavitù per essere dei piantagrane e la lista, sempre più lunga, di futili infrazioni punibili con la schiavitù che costarono la vita a molta gente comune (p. 48)
Eppure gli émigrés degli anni Sessanta, ritornati in Ghana per ricollegarsi ad un passato ricco e glorioso, ma che metteva ancora più in oblio la realtà storica della schiavitù, avevano creduto nel sogno di un’Africa unita, un sogno che l’autrice chiama Afrotopia.
Il mio arrivo in Ghana non era promettente. La mia non era l’epoca dei sogni ma del disincanto. Ero cresciuta nel periodo successivo all’indipendenza africana, ai diritti civili, alle lotte del Black Power e, come molti della mia generazione, ero pessimista rispetto al mio futuro, sia in patria che all’estero […] Il sogno apparteneva agli émigrés, il cui ‘orizzonte di speranza’ erano i detriti storici del mio presente. (p. 58).
Dopotutto, anche il sogno degli émigrés sfuma, come se non vi fosse via di fuga dal cortocircuito del passato presente dove la “pelle nera” funge da “maschera bianca.” Hartman afferma che con l’avvento del postcolonialismo, il panafricanismo va trasformandosi in nuove forme neocoloniali, perdendo vigore ideale, mentre il “socialismo africano” è andato appiattendosi sul business dei ricchi africani asserviti all’Occidente.
Il viaggio, però, non era perduto del tutto. Lungo la rotta atlantica, Hartman attraversa la città di Gwolu, dove si erano rifugiati quegli schiavi fuggitivi che erano riusciti a sottrarsi ai mercanti e agli agguati dei predoni
Erano fuggiti dai cacciatori di schiavi, dagli stati predatori, da siccità e terre stremate, e avevano desiderato di non volerne sapere più niente, in questa nicchia isolata della savana. Ognuno aveva un sogno diverso riguardo alle possibilità che si aprivano nel momento in cui non si doveva più pensare a guardarsi le spalle, rispondere al nome di ‘barbaro’, consegnare la propria figlia o nipote come tributo, dimenticare i propri antenati o abbandonare le proprie divinità. (276)
A Gwolu s’interrompe la colonizzazione e la “normalizzazione” del non ricordo o dell’essere subalterni e assoggettati. È come se qui il sistema di significazione viene interrotto da linee di fuga, laddove le linee segmentali che riducono il significato all’uno, al “negro” e allo schiavo, esplodono, mentre, come gazzelle, le donne e gli uomini liberi fuggono dalle fortezze coloniali:
finalmente al sicuro, ci siamo messi insieme, qui dove nessuno può più raggiungerci, il villaggio degli uomini liberi, qui parliamo di pace, un luogo di abbondanza, un rifugio […] i fuggitivi e gli esclusi di altri luoghi, la loro identità era definita tanto da ciò che si lasciavano alle spalle quanto da ciò verso cui correvano […] rifugiati, fuggitivi e vagabondi inondavano la savana. Sotto la spinta della fuga e della ribellione vennero creati nuovi popoli e nuove società furono costruite. (pp. 276-277)
In questi villaggi non è dispersa la memoria, non è persa la “madre Africa”. Anzi, tramite la fuga le donne e gli uomini liberi hanno cercato di ricostruire l’identità e riacciuffare la memoria, consci che obliterarne i tasselli della propria storia, non può che indebolire, provocando il riacutizzarsi di nuove forme di colonizzazione e nuove pratiche schiavistiche, non più in Africa, ma nel cuore dell’Occidente capitalistico. Occorre parlarne e squarciare il velo, sarà un modo, fra i tanti, per tessere una tela e generare organi di collegamento fra i nuovi dannati della terra, a patto che si nomini, ad alta voce, quello che sono le radici ed è l’attualità dell’accumulazione capitalistica, ossia la schiavitù.



