di Alberto Molinari
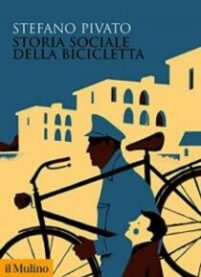 Stefano Pivato, Storia sociale della bicicletta, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 251, € 22,00.
Stefano Pivato, Storia sociale della bicicletta, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 251, € 22,00.
Studioso dei comportamenti collettivi e dell’immaginario politico nel Novecento, Stefano Pivato è stato uno dei primi storici italiani che ha messo in luce i risvolti politici e sociali dello sport. Tra i temi di carattere sportivo affrontati da Pivato, la Storia sociale della bicicletta può essere considerata l’ultima tappa di un itinerario di ricerca iniziato con Sia lodato Bartali (1986), proseguito nel 1992 con La bicicletta e il sol dell’avvenire e poi con Il Touring Club Italiano nel 2007.
Ricorrendo ad una molteplicità di fonti archivistiche e a stampa, a documenti prodotti dalla cultura popolare, immagini, poesie, racconti e canzoni, l’autore assume come chiave di lettura principale della storia sociale della bicicletta la dialettica tra “modernisti” e “antimodernisti” e indaga gli svariati intrecci tra il mezzo a due ruote e il contesto sociale italiano.
La ricostruzione di Pivato consente di cogliere da un’angolatura particolare alcune importanti dinamiche e trasformazioni dell’Italia contemporanea, dell’immaginario collettivo come della cultura materiale, del costume come della questione di genere, dei soggetti politici come delle figure sociali per le quali il mezzo ciclistico diventa parte integrante della vita quotidiana.
Nel racconto della lunga e affascinante storia delle due ruote, l’autore dà voce anche suoi cantori mostrando «la convivenza e la contaminazione fra cultura alta e cultura bassa» che «costituiscono una delle caratteristiche della bicicletta e della sua declinazione in varie forme»: dagli scritti dei letterati innamorati della bicicletta ai tempi dei “pionieri” agli articoli degli scrittori che seguivano il Giro d’Italia, dai fogli volanti dei cantastorie che narravano le gesta dei campioni alle canzoni di cantautori come De Gregori, Paoli e Conte che hanno rievocato le atmosfere dei tempi di Girardengo, di Coppi e di Bartali.
Tra fine Ottocento e primo Novecento, quando l’ingombrante velocipede viene sostituito dalla più economica e maneggevole bicicletta, le due ruote si diffondono progressivamente trasformandosi da stravagante passatempo per aristocratici a strumento per le passeggiate della borghesia, da esercizio per pochi a bene di consumo popolare, utilizzato da impiegati e operai per recarsi al lavoro.
La pratica ciclistica si carica di significati connessi alla modernità: rappresenta l’ebbrezza della velocità (in bicicletta si possono percorrere 20 km all’ora, contro i 4 a piedi), consente di ampliare l’esplorazione del paesaggio e la conoscenza della penisola, apre nuovi orizzonti fisici e mentali, trasmette un senso di libertà.
Ai ciclofili entusiasti si contrappongono i ciclofobi che condannano il nuovo mezzo. «E l’antimodernità – scrive Pivato – è una categoria dentro la quale stanno gran parte delle motivazioni che si oppongono alla bicicletta. Vi è la paura delle genti di campagna quando vedono per la prima volta il mostro meccanico; così come vi è il timore della chiesa per il ridicolo e la mancanza di decoro cui si espongono i preti che montano le due ruote. Dentro l’antimodernità ci sta anche la tutela della pudicizia che è alla base delle limitazioni e dei divieti posti alle donne. E così pure l’iniziale rifiuto del movimento operaio per la bicicletta considerata “un prodotto del capitalismo borghese”».
Pivato dedica pagine ricche di informazioni, aneddoti e riflessioni agli atteggiamenti contraddittori assunti dagli ambienti ecclesiastici nei confronti della bicicletta, alle istanze emancipatrici che il nascente movimento delle donne attribuisce alle due ruote come alle riserve della scienza e ai pregiudizi dell’opinione pubblica conservatrice nei confronti delle donne in bicicletta, al dibattito interno al movimento socialista tra gli intransigenti “antisportisti” e i fautori di un uso politico del mezzo ciclistico inteso come strumento per diffondere la propaganda e come veicolo di socialità.
In prossimità della prima guerra mondiale, la bicicletta irrompe nella vita militare e nel discorso patriottico. Anche in questo caso, Pivato evidenzia i contrasti che accompagnano l’utilizzo del mezzo. Da un lato, come per i sacerdoti e per le donne, permane un pregiudizio di natura estetica che vede nell’uso della bicicletta il rischio di «mettere a repentaglio la credibilità e il decoro delle forze armate»; dall’altro, si pensa di poter sfruttare a fini militari la velocità e la mobilità delle due ruote.
Ad alimentare l’immagine di rapidità e di efficienza della bicicletta contribuiscono i futuristi che allo scoppio della guerra si arruolano nel Corpo dei ciclisti volontari. Il mezzo non si rivela però adatto ad un conflitto che si configura di posizione, mentre riesce utile in un frangente drammatico come la ritirata di Caporetto perché le due ruote «consentono una libertà di movimento maggiore rispetto a chi si affida a mezzi pesanti come i carri, spesso bloccati dagli intasamenti che la precipitosa ritirata provoca».
Nel ventennio fascista, «la bicicletta diventa uno degli indici più caratteristici della nazionalizzazione del tempo libero del regime». La “Carta dello Sport”, varata nel 1928, affida il compito di dare impulso al ciclismo amatoriale alla Federazione Italiana dell’Escursionismo che organizza convegni, concorsi, gite di massa nell’ambito del Dopolavoro. Le escursioni in bicicletta rappresentano «uno degli strumenti più efficaci della mobilitazione degli iscritti per educare l’italiano “nuovo” attraverso itinerari e mete che devono familiarizzare i partecipanti alla conoscenza della nazione e delle opere del regime. Nelle parate del Dopolavoro, della Milizia e delle Giovani italiane il veicolo a due ruote è una presenza costante».
Alla vigilia del secondo conflitto mondiale, la popolarizzazione del mezzo ciclistico è favorita dall’abolizione della tassa di circolazione che entra in vigore nel 1939 nel pieno della campagna autarchica quando la limitazione dei carburanti rilancia l’utilizzo delle due ruote. Ricorrere all’«”autarchico cavallo d’acciaio” diventa, per la possibilità di economizzare il carburante, una delle più significative manifestazioni di adesione agli interessi e ai sentimenti nazionali con l’entrata in guerra dell’Italia».
Come osserva Pivato, «se la bicicletta diviene uno dei simboli dell’”andata verso il popolo” del regime fascista, si trasforma però in uno dei mezzi che più attivamente contribuisce alla sua caduta».
Poiché garantisce rapidità di esecuzione e aumenta le possibilità di fuga, durante la Resistenza la bicicletta è uno strumento determinante per le operazioni militari dei Gruppi di Azione Patriottica che agiscono nelle città. Anche per le staffette partigiane, come si evince dalle storie e dalle testimonianze delle donne impegnate in varie missioni (portare ordini ai compagni, distribuire giornali clandestini, trasportare viveri, indumenti o armi), è fondamentale l’uso della bicicletta. Ricordava una di loro: «Quando optai per combattere in città […] non sapevo sparare […] ma sapevo perfettamente andare in bicicletta». E dal punto di vista simbolico il protagonismo delle staffette rappresenta «una sorta di rivincita postuma delle donne nei confronti della bicicletta il cui uso, qualche anno addietro, era loro precluso o fortemente condizionato».
Lungo il Novecento la fortuna della bicicletta dipende anche dalle grandi corse, a partire dal Giro d’Italia e dal Tour de France.
Agli albori del ciclismo, l’epopea delle due ruote è legata alla fatica e al coraggio, alla volontà di portare a compimento un impegno attingendo fino all’estremo della forze, al mito delle origini oscure e povere, allo sport come forma di riscatto e come strumento di mobilità sociale.
Nella loro evoluzione, le competizioni fanno poi emergere la figura del campione. «Nell’immaginario del Ventesimo secolo – scrive Pivato – il campione sportivo viene a sostituire una delle figure più caratteristiche della cultura classica: quella dell’eroe che non sta più nelle pagine di un romanzo ma sulle strade del Tour e del Giro».
Nel secondo dopoguerra sono anzitutto Gino Bartali e Fausto Coppi i campioni che suscitano le passioni degli italiani. La rivalità che si instaura tra i due ne accresce la popolarità e definisce i meccanismi di identificazione degli italiani in personaggi dalle caratteristiche opposte, tanto tecnicamente e caratterialmente quanto, almeno nella rappresentazione popolare alimentata dai mezzi di comunicazione, ideologicamente (il “pio” Bartali e il laico Coppi). Nel clima della guerra fredda il mondo ciclistico si divide in due fazioni contrapposte e il dualismo sportivo assume una connotazione politica: come si sta o con De Gasperi o con Togliatti, così si fa il tifo o per Bartali o per Coppi: «In un periodo in cui il partito democristiano si avvia a divenire egemonico e a emarginare le sinistre dalla vita politica e sociale del paese, le sconfitte che Coppi infligge al “De Gasperi del ciclismo” acquistano, per quanti hanno creato la leggenda di un Coppi comunista, il valore di una sconfitta dell’Italia democristiana».
Anni dopo, sarà Marco Pantani a riproporre l’immagine del ciclista antico come eroe della fatica, refrattario alle tattiche, imprevedibile, capace di illuminare improvvisamente una gara con i suoi scatti improvvisi sulle montagne del Giro o del Tour.
L’ultimo capitolo del libro – intitolato “Dalla modernità all’antimodernità” – si chiude con uno sguardo sul rovesciamento di paradigma che ha caratterizzato la bicicletta nell’epoca della motorizzazione di massa e delle crisi ambientali.
«A partire dagli anni Sessanta – nota Pivato – in coincidenza con il boom economico e l’avvio della motorizzazione di massa, la bicicletta viene progressivamente dismessa e dal decennio successivo, nel periodo della prima crisi energetica globale, quella che all’origine era nata come il simbolo della modernità per eccellenza si trasforma nell’emblema dell’antimodernità. Anzi, diventa la rappresentazione di quello che uno dei massimi antropologi contemporanei, Marc Augé, ha definito “un nuovo umanesimo” diretto alla salvaguardia ambientale di fronte al disastro ecologico globale».
Ancora una volta, il ruolo della bicicletta e i significati che le vengono attribuiti rimandano a rilevanti passaggi storici, confermando ciò che sosteneva quarant’anni fa Gianni Brera: «Traverso le viti di una bicicletta si può anche scrivere la storia d’Italia».



