di Sandro Moiso
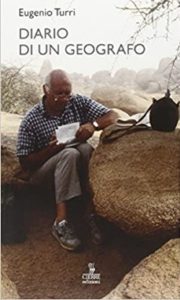 Eugenio Turri, Diario di un geografo, CIERRE Edizioni, Verona 2015, pp. 370, 20 euro
Eugenio Turri, Diario di un geografo, CIERRE Edizioni, Verona 2015, pp. 370, 20 euro
In questi tempi oscuri ci aggiriamo come cavalieri usciti dalle pagine di un romanzo di Cormac McCarthy, interrogandoci sul senso di una vita senza scopo apparente e di una morte che sembra costituire l’unico orizzonte possibile. Per i giusti e per i colpevoli, per i ricchi e per i poveri, per chi sta in alto e per chi sta in basso, per i rabboniti e per i ribelli.
E’ in momenti come questo che occorre tenere alto lo sguardo, ritta la schiena e lucida la mente per poter intravedere lontano quel barbaglio di luce che può ancora indicarci il cammino.
Occorre avere una buona bussola, poiché la fede, qualsiasi fede, serve a poco e spesso confonde.
Il venir meno della fede può convincerci dell’impossibilità di trovare la giusta direzione, mentre al contrario la sua passiva esaltazione può confonderci sui passi da seguire.
Fede e superficiale ottimismo rifiutano il pessimismo della ragione, ma quest’ultimo potrebbe essere l’unico strumento in grado di aiutarci per guadare il fiume turbolento e insidioso della vita e della Storia, mentre la fragile canoa costituita dagli altri due può facilmente rovesciarsi e trascinare a fondo con sé coloro che gli si sono affidati con troppa fiducia.
Tra i grandi italiani ce lo ha insegnato Giacomo Leopardi, grande materialista troppo spesso rifiutato nella sua essenza da professori che hanno saputo soltanto promettere ai loro allievi un mondo che non è mai esistito. Disarmandoli completamente. Nei confronti dell’ordine niente affatto naturale della società, di una cultura soporifera e addomesticata e di una vita che ha in serbo, per chi sa coglierlo, ben altro che la promessa di un radioso e sempre lontano, se non ultraterreno, premio alla fedeltà.
Eugenio Turri (1927-2005), esploratore e geografo, reporter di viaggio e direttore di significative iniziative editoriali, docente del Politecnico e geologo, ha avuto invece la capacità di guardare al mondo in profondità. Con uno sguardo poetico e scientifico allo stesso tempo che in qualche modo, e più di quanto si possa immaginare, lo avvicina al solitario di Recanati.
Ha saputo distillare l’essenza della vita e della conoscenza dalle rocce, dai deserti che ha attraversato, dai reperti fossili che testimoniano di altre ere e di altre specie, che la nostra non ha avuto modo di conoscere direttamente. Soprattutto ha saputo cogliere nel paesaggio, di cui è stato attento osservatore e studioso, il fluire antico e lento, a tratti rovinoso, di una Storia che spesso si confonde con la Natura e di una vita che è tale anche perché si accompagna alla morte.
Il suo Diario, accompagnato da una introduzione di Andrea Zanzotto, raccoglie tre suoi testi, editi precedentemente nel 1967 (Il diario del geologo), nel 1992 (Weekend nel Mesozoico) e nel 2005 (Taklimakan. Il deserto da cui non si torna indietro); tutti intessuti, come affermano i curatori del volume: «nell’identica struttura formale di pensieri sparsi e rivelano quanto lo svolgersi della sua esplorazione del mondo fisico si sia accompagnato lungo gli anni, all’incirca tra il 1955 e le soglie del duemila, a una profonda riflessione intima.»1
Struttura e scrittura che, senza mai rinunciare alla precisione dell’enunciato scientifico, avvicinano le sue prose a una dimensione poetica che è ben difficile rintracciare nelle opere di altri geografi o scrittori di viaggio.
Scrittura e riflessioni che richiamano più l’Infinito leopardiano, in cui l’Io si perde per ritrovarsi nella materialità dell’Universo come sua componente, che l’ambigua domanda Che ci faccio io qui? Tipica di un autore come Bruce Chatwin e dei viaggiatori-esploratori anglo-sassoni sempre alla ricerca del sé e di un Io ben distinto dalla Natura circostante. Affascinante, imponente, ma sempre irrimediabilmente altra rispetto all’osservatore.
Una letteratura, quest’ultima, sempre e comunque alla ricerca dell’istante che dia senso e traiettoria alla Storia e alla vita, sempre intese in modo estremamente personale. E quindi limitate.
In Turri, invece, il lettore si trova davanti ad una sorta di genealogia dell’eternità.
Di quell’eternità, di cui in fin dei conti non conosciamo la reale durata, che ci accomuna agli pterodattili e alle rocce su cui camminiamo anche durante una solitaria gita in collina.
Eternità che, ancora, ci accomuna, noi popoli urbanizzati, ai nomadi delle steppe e dei deserti, agli animali scomparsi, ai ghiacciai, alle cime montane e ai grandi corsi d’acqua. Paradossalmente infiniti poiché finiti, come tutto, nella loro e nostra più intima essenza.
“Un dinosauro è morto l’altra mattina nello stagno. E’ morto di fame e di sfinimento dopo stagioni e stagioni trascorse a cercare le verdi boscaglie in cui era nato. Le boscaglie si sono disseccate, ingiallite, e nuvole di polvere sollevate dal vento hanno invaso la pianura, coprendo gli stagni, togliendo spazio all’ultimo mastodonte rimasto sulla Terra. L’evento è accaduto con l’inflessibilità dei grandi mutamenti naturali, l’inaridirsi delle pianure dopo millenni di umide e crasse stagioni che facevano la gioia dei bestioni. Ora tutto è finito […] La vicenda fu presto assorbita nel silenzio della pianura, sotto il sole infuocato dei meriggi mesozoici.
Così viviamo l’Africa, come fosse la Terra del Mesozoico: nelle sue savane selvagge e spopolate l’apparizione di una giraffa è come l’apparizione di un diplodoco e nei suoi stagni inariditi cogliamo il senso di drammi geologici ignorati. Il cosiddetto mal d’Africa è il nostro male oscuro, profondo.”2“Seguito da una scia di polvere un drappello di giraffe correva nella pianura […] Quelle giraffe in corsa evocavano giovanili fantasie preistoriche (eccitando oscure memorie della specie), con i dinosauri emergenti dai paesaggi vegetali, in una Terra priva di uomini […] Le cadenze eguali degli animali in libera corsa ritmavano il battito vitale delle epoche geologiche ignorate: placido e calmo al confronto di quello aritmico, nevrotico, di noi abitatori delle foreste metropolitane.”3
“Il nostro panorama interiore è come il calco esatto del panorama che abbiamo davanti ora, sulla cima della montagna, in una giornata di silenzi e di luci autunnali, con la pianura lontana, colma di città, di stabilimenti, di case, di traffici, ma tesa nelle alluvioni pleistoceniche, con i monti che la sovrastano, anch’essi colmi di segni umani, di case, ritagli boschivi, e tuttavia giacenti in una loro indifferente fissità geologica.
Tutto ciò che nel mondo fa rumore è attutito dalla distanza e dalla immensità di un panorama che pure vive il respiro della natura e degli uomini. La sublime e silenziosa visione del mondo non lascia spazio agli uomini e alle loro storie particolari, così come non la lascia dentro di noi l’animata vicenda quotidiana”4
Tutto scorre… sembrano suggerire le pagine di Turri.
Tutto è in movimento: intorno a noi, prima di noi, dopo di noi e sopra e sotto di noi.
Ogni rimpianto si perde nel tempo e non possiamo far altro che avanzare verso quel riflesso di luce che ci è sembrato di cogliere nell’oscurità. Che non segnerà la fine del tunnel o il nuovo giorno, ma forse soltanto un fuoco amico. Intorno a cui raccoglierci con altri cavalieri che vagano nella notte come noi. Sarebbe già tanto e, chissà, Eugenio Turri potrebbe essere lì per guidarci.



