di Sandro Moiso
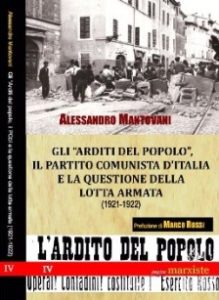 Alessandro Mantovani, Gli “Arditi del popolo”, il Partito Comunista d’Italia e la questione della lotta armata (1921-1922), Pagine Marxiste, 2019, pp. 184, 10,00 euro
Alessandro Mantovani, Gli “Arditi del popolo”, il Partito Comunista d’Italia e la questione della lotta armata (1921-1922), Pagine Marxiste, 2019, pp. 184, 10,00 euro
Definitivo è il fallimento d’ogni programma di lotta costituzionale e morale (La catena, Emilio Lussu – 1929)
In tempi in cui le piazze “antifasciste” si riempiono di giovani inneggianti alla legalità, alla politica educata e non violenta e in cui la conflittualità di classe, ancora una volta, rischia di essere messa sott’olio e sigillata come le sardine che le promuovono, è sicuramente molto utile ripercorrere, dal punto di vista storiografico e politico, le vicende che portarono ad una netta distinzione tra l’organizzazione illegale del Partito fondato a Livorno nel 1921 e quella spontanea e diffusa, soprattutto in ambito proletario, di chi cercava di opporsi armi alla mano alla nascente minaccia fascista.
Una lezione, indipendentemente dai risultati conseguiti e dalle motivazioni politiche che alimentarono le differenti strategie e tattiche assunte dai principali protagonisti, che potrebbe rivelarsi ancora oggi decisiva per distinguere comunque il reale antifascismo da quello di facciata finalizzato soltanto a protrarre oltre ogni possibile limite la sopravvivenza dell’attuale ordine economico e sociale basato sul sopruso e l’oppressione di classe.
All’interno di un conflitto sociale che si muove oggi in un’aura già di guerra civile, nelle diverse aree del globo in cui si va manifestando, ma in cui una parte dei contendenti sembra ancora tardare nel prendere coscienza delle difficoltà e delle responsabilità che l’attendono nel confronto con la violenza dispiegata dagli Stati e dai loro apparati militari e repressivi.
Tale non secondario problema, evidentemente, nel periodo intercorso tra il 1919 e il 1921, fu invece centrale per l’organizzazione di chi, tornato dalla guerra oppure rimasto in officina, doveva fare i conti con la crisi economica successiva alla fine del primo conflitto mondiale e, soprattutto qui in Italia, con l’organizzazione della violenza armata delle milizie che, come quelle fasciste, affiancarono l’opera di controrivoluzione preventiva messa in atto dallo Stato nei confronti dei lavoratori e del proletariato e delle loro iniziative ed organizzazioni politiche e sindacali.
Certo, a differenza di oggi, l’idea della violenza ineliminabile da qualsiasi discorso sullo scontro di classe non era ancora stata cancellata dalla memoria di chi si opponeva all’esistente e alle condizioni di vita e di lavoro che ne conseguivano. E a questo avevano certamente contribuito anni di guerra e di macelli interimperialisti, la leva di massa, le sofferenze di coloro che erano rimasti a casa e la delusione dei reduci e dei sopravvissuti di un conflitto che aveva causato in Europa circa dieci milioni di morti e un’innumerevole quantità di feriti e dispersi tra le file dei soldati di ogni nazionalità.
L’uso delle armi era diventato massiccio e abituale per chi era stato al fronte, ma anche il corso degli avvenimenti precedenti e contemporanei al periodo di guerra (la settimana rossa, l’insurrezione di Torino dell’agosto del 1917, le rivolte per il pane e la terra e le occupazioni delle fabbriche del cosiddetto Biennio rosso) aveva determinato tra i proletari, gli operai e i militanti più decisi delle varie tendenze politiche contrarie al capitalismo una pratica diffusa di detenzione o una più semplice propensione all’uso delle armi per far valere i propri diritti oppure per difendere la propria vita, le manifestazioni, gli scioperi e tutte le strutture connesse all’organizzazione delle lotte (tipografie, sedi sindacali e di partito, case private dei militanti) dall’assalto delle forze della controrivoluzione preventiva: sia che si trattasse di quelle dello Stato che di quelle inquadrate nelle milizie fasciste.
Un’azione militare proletaria che ebbe nell’azione degli Arditi del popolo un’autentica punta di diamante nella risposta al Fascismo e che finì con lo scontrarsi sia direttamente sul campo che giuridicamente con gli apparati repressivi e militari dello Stato Regio.
Stato che sempre e comunque, ben prima della sua completa fascistizzazione, intervenne a difesa delle milizie nere sia a supporto della loro azione repressiva che per soccorrerle in caso di probabile o evidente sconfitta. Ragion per cui gli appelli successivi alla pacificazione o l’invito al ritorno alla tradizione democratica del parlamento e del governo, ancora nel 1924 dopo il delitto Matteotti oppure vent’anni dopo con gli appelli ai “fratelli in camicia nera” del 1938 o la formazione del CLN dopo la caduta del regime, sempre risuonarono, e non avrebbe potuto essere diversamente, come autentici tradimenti dell’iniziativa autonoma proletaria e dello spirito rivoluzionario che l’aveva spontaneamente animata fin dagli anni del primo dopoguerra.
Mantovani prende in esame, nel suo sintetico testo, un problema importante e significativo del rapporto tra organizzazione politica (il partito o i partiti) e azione autonoma del proletariato: quello dell’avvicinamento alle formazioni militari degli Arditi del popolo e del contemporaneo allontanamento di molti militanti dalla disciplina e dalle direttive degli stessi partiti, in particolare da quel Partito Comunista d’Italia che era nato da una scissione a sinistra dell’ormai decotto Partito Socialista.
Proprio la giovane dirigenza del partito, nato rivoluzionario sulla base delle indicazioni della Internazionale Comunista o Terza Internazionale, fu quella che con più decisione si oppose teoricamente e organizzativamente all’unione militare tra militanti del Partito, proletari non ancora inquadrati politicamente e ex-combattenti antifascisti e avversi a quell’ordine socio-economico che li aveva mandati al macello.
Questi ultimi avevano una composizione socio-politica molto diversificata al proprio interno: ex-militari di prima linea, volontari fiumani, anarchici, socialisti, repubblicani, comunisti provenienti da classi sociali diverse (studenti, piccoli borghesi, disoccupati, sottoproletari, lavoratori), ma uniti nel rifiuto dell’esistente e attivi nel rispondere alla minaccia e alle aggressioni fasciste.
Certo non potevano essere portatori di un programma politico ben delineato e definito e proprio da qui nacque l’equivoco, se vogliamo definirlo con un eufemismo, che portò l’allora segretario del Partito Amadeo Bordiga e buona parte del direttivo dello stesso ad opporsi alla pratica di collaborazione militare e a proporre un inquadramento militare, destinato soltanto ai militanti riconosciuti del partito stesso, all’interno delle strutture illegali del Partito.
Molti militanti non diedero ascolto a tali indicazioni (lo dimostrano le cifre delle adesioni agli Arditi del popolo di militanti definiti come comunisti) e ciò naturalmente causò irritazione negli organi dirigenti da una parte e dall’altra una serrata polemica tra la direzione del Partito e la Direzione dell’Internazionale e lo stesso Lenin, favorevoli invece ad una collaborazione militare tra il Partito italiano e le formazioni militari spontanee rappresentate dagli Arditi.
Mentre la dotta introduzione di Marco Rossi, già autore di diversi testi sul teme degli Arditi e del rifiuto della guerra, serve a inquadrare più generalmente il periodo e le pratiche spontanee di resistenza e di organizzazione paramilitare di chi, nel primo dopoguerra oppure durante la guerra stessa, si opponeva allo Stato borghese, al capitalismo, al nazionalismo e al fascismo, la ricostruzione di Mantovani si basa principalmente sulla documentazione e sui testi prodotti all’epoca dal Partito Comunista a direzione bordighiana e dall’Internazionale relativi al medesimo argomento.
E’ un lavoro interessante e, fortunatamente, critico delle formulazioni e delle pratiche messe in atto dal PCd’I in quei frangenti, ma nell’opera quasi ostinata di antologizzazione dei testi (molto ricca è infatti l’Appendice in cui si raccolgono i documenti, gli articoli e gli accesi contrasti tra Partito e Internazionale) rischia di cadere nello stesso errore di schematismo in cui caddero Bordiga e gli altri dirigenti del Partito (fatto forse salvo il caso di Gramsci) che ebbero come unico faro i compiti e i programmi del Partito stesso, senza tener conto delle proposte e delle nuove modalità organizzative e operative che giungevano dal basso e dalla società. Un dibattito che, per forza di cose, era destinato e sarebbe destinato tutt’ora, a rimanere racchiuso nel confronto ideologico e politico interno ad una minima frazione di proletariato e di militanti compresi all’interno del Partito di allora o di quello puramente immaginario di adesso.
In questo, però, occorre anche vedere anche un prolungamento di quelle pratiche bolsceviche e bolscevizzanti messe in atto proprio sulla base delle indicazioni provenienti dall’Internazionale per la formazione dei nascenti partiti comunisti: partiti di quadri e militanti rivoluzionari che dovevano guidare le masse in nome di un chiaro e ben definito progetto di azione tattica e strategica.
Una concezione dell’azione politica militante che non solo avrebbe portato nel giro di pochi anni alla degenerazione staliniana nell’Urss e nei partiti “fratelli”, ma che era riuscita di ostacolo persino agli inizi della rivoluzione russa quando, a febbraio, i rappresntanti del partio presenti a Pietrogrado si erano inizialmente opposti alle iniziative dal basso, di operaie, operai e soldati, che avrebbero portato nel giro di una settimana alla caduta dello Zar.
Una concezione e una pratica militare, quella ereditata dal partito bolscevico, più adatta all’azione armata ristretta delle fasi di difficoltà di un movimento (come quella attraversata dal partito bolscevico dopo la rivoluzione del 1905) piuttosto che all’azione generale di classe in un momento di guerra civile oppure pre-insurrezionale e rivoluzionario. Concezione ristretta che si sarebbe drammaticamente riverberata anche nei cosiddetti ‘anni di piombo’ e nelle tragiche e perdenti scelte operate dalle organizzazioni maggioritarie della lotta armata italiana a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.
Se non sbaglio, poi, l’autore dimentica una specie di autocritica che lo stesso Bordiga avrebbe poi fatto sulle pagine di Prometeo, la rivista teorica del Partito sopravvissuta pochi mesi all’azione fascista statalizzata, riconoscendo l’importanza che il movimento dannunziano e l’impresa di Fiume avrebbero potuto avere come momento di rottura all’interno della società italiana se questa fosse stata riconosciuta dai vertici della Sinistra come una possibile componente del movimento rivoluzionario. Ma questa “autocritica” in realtà tale non era poiché all’epoca del movimento dannunziano il Partito Comunista non esisteva ancora e, quindi, la responsabilità poteva essere rovesciata interamente sul Partito Socialista.
Il testo di Mantovani, edito da Pagine marxiste, è pertanto utile dal punto di vista della conoscenza e diffusione delle teorizzazioni, pro o contro, dell’epoca, ma pecca ancora di una mancata e approfondita analisi delle componenti sociali e degli immaginari che determinarono tali scelte. E questo non è poco in un momento in cui, a livello mondiale, torna a delinearsi uno scontro di classe variegato e contraddistinto dall’essere più guerra civile che non “rivoluzione pura” come alcuni vorrebbero, cosa che condannerà inevitabilmente questi ultimi a ripercorrere ancora le stesse orme lasciate da altre sconfitte nella neve insanguinata della Storia.



