di Fabio Ciabatti
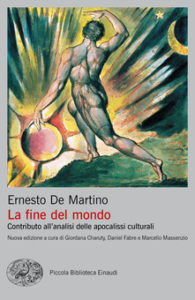 Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi 2019, pp. 612, € 28,90 – Nuova edizione a cura di G. Charuty, D. Fabre e M. Massenzio.
Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi 2019, pp. 612, € 28,90 – Nuova edizione a cura di G. Charuty, D. Fabre e M. Massenzio.
Da molti anni assistiamo a quella che sembra la scomparsa della cultura del movimento operaio. Si potrebbe parlare di una vera e propria apocalisse culturale e anche per questo può essere utile tornare all’opera di Ernesto De Martino che a questo tema ha dedicato un’opera uscita postuma e in forma largamente incompiuta nel 1977, da poco disponibile in una nuova edizione che presenta significative differenze rispetto alla precedente versione. Con La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali De Martino si propone di fare luce su quella che gli appare come una crisi della civiltà occidentale talmente profonda da avviarla verso un assai probabile declino. Per raggiungere questo obiettivo l’autore tratta la figura teologica e antropologica dell’apocalisse analizzando le apocalissi psicopatologiche (anche attraverso le loro espressioni letterarie), il dramma dell’apocalisse cristiana e il rapporto tra apocalisse e decolonizzazione. Al rapporto tra antropologia e marxismo è inoltre dedicato un apposito capitolo che, rispetto alla precedente edizione, è stato ampliato spostando materiali precedentemente pubblicati in altre sezioni.1
E proprio su quest’ultimo tema ci soffermeremo notando, in prima istanza, che il pensiero di De Martino si iscrive nella tradizione marxista e gramsciana in modo molto originale tanto che, nel testo in questione, si fa ampio utilizzo di categorie di provenienza heiddegeriana ed esistenzialista. L’autore, riprendendo Merleau-Ponty, sostiene che il marxismo carica l’uomo di un’immensa responsabilità. Ed è a causa dello “sforzo estremo che il marxismo richiede alla praxis e al suo ethos, che l’antica metafisica della necessità e del materialismo volgare travaglia la storia dello stesso marxismo, e che, per altro verso, tanta parte dell’umanità si abbraccia disperatamente al vecchio Dio con l’agonia del quale sembra non già crescere l’uomo ma rovinare il mondo”.2 In generale, rispetto al tema della funzione della religione nei rapporti sociali, l’antropologo italiano attribuisce una certa ambivalenza al pensiero di Marx: le sue intuizioni sono profonde ma nel contesto fortemente polemico in cui sono espresse possono dare adito ad un’interpretazione piattamente positivistica, come è poi effettivamente accaduto nel marxismo, anche attraverso la mediazione di Engels.
“La critica ha spogliato la catena dei fiori immaginari che la ricoprivano non perché l’uomo porti catene senza fantasia, disperate, ma perché esso respinga la catena e colga i fiori viventi”. Questa brano di Marx, secondo De Martino che lo cita, segnala i limiti di ogni critica che non sia anche critica rivoluzionaria della realtà che genera le religioni. “Se la critica lascia intatti i tratti ierogonici dell’esistenza sociale, le catene rimangono senza ‘speranza’ scatenando angosce senza orizzonte che preparano inautentiche restaurazioni sospingendo verso miserabili surrogati della religione”.3
Ma questa moderna degenerazione del sacro non ci deve fuorviare. Da una parte abbiamo la tesi del “valore eterno” della religione e, dall’altra, quella opposta della religione come illusione, stupidità, stravaganza, riflesso ecc. che spesso è stata adottata dal marxismo la cui storiografia religiosa, secondo l’antropologo, è “innegabilmente infantile”. Tra i due estremi sta la concezione della religione come istituto storico che in date condizioni assolve una funzione positiva di reintegrazione e di mediazione dei valori culturali. Se è vero che nella società borghese la religione tende a perdere la sua funzione rappresentando un fattore di ritardo (“una via indiretta e allungata” per il riconoscimento dell’uomo, per dirla con Marx), ciò non significa che sia lecito proiettare questo giudizio sulle società passate in cui, attraverso la religione, è stata percorsa l’inevitabile strada verso il riconoscimento parziale dell’uomo.
Secondo l’autore, infatti, la condizione umana è caratterizzata da una ineliminabile tensione dialettica tra il divenire della storia e il perdurare dei valori che strutturano la società o, per meglio dire, è contraddistinta dal tentativo continuo di riassorbire ciò che diviene nella permanenza di ciò che vale. Questa rapporto dialettico può andare perduto (per esempio con l’apocalisse culturale) ma non può mai essere oltrepassato come pretendono magia e religione. Ogni esperienza di una situazione nuova è potenzialmente critica perché pone in essere per la coscienza la distanza tra l’accadere in senso naturale (che è o può essere contrario all’uomo) e il far accadere in senso culturale (che tende a decidere le situazioni secondo valori sociali nell’ambito dell’operare intrinsecamente umano).
La religione è dunque una tecnica per destorificare il passaggio critico, reintegrare nella società le realtà psichiche alienate e ritornare alla storicità dell’esistere. Destorificazione, in particolare, significa occultare la storicità del passaggio critico mediante il ritualismo dell’agire: si ripete ciò che gli dei hanno già fatto in un’epoca mitica e fondativa, assimilando le vicende storiche in cui si è immersi a un identico metastorico che si ripete. La vita religiosa, in sintesi, è la mediazione che protegge dal rischio di “passare con ciò che passa”, apparendo così storicamente necessaria nelle condizioni in cui questo rischio è imponente e le potenze culturali dell’operare mondano sono a vario titolo anguste, non ancora mature per l’autocoscienza della loro origine e destinazione umana.
 Questa discussione non ha un valore meramente storico-religioso per De Martino. Il simbolismo mitico-rituale non è una condizione eterna delle società umane, ma sottovalutare la sua importanza significa non comprendere che la vita simbolica, indipendentemente dalle sue declinazioni religiose, ha una funzione permanente nella società, impossibile da sostituire con le scienze della natura o della società. Questo perché l’ordine simbolico non ha solo una valore conoscitivo, ma “include, in un quadro intuitivo e altamente emozionale, origine e prospettiva”4 di una civiltà. Nel caso dell’ordine simbolico mitico-rituale questa inclusione si ammanta di significati assoluti, metastorici. Il problema che si pone De Martino è invece quello di un simbolismo che accetti il fatto che gli uomini fanno la loro storia e ne portano interamente la responsabilità.
Questa discussione non ha un valore meramente storico-religioso per De Martino. Il simbolismo mitico-rituale non è una condizione eterna delle società umane, ma sottovalutare la sua importanza significa non comprendere che la vita simbolica, indipendentemente dalle sue declinazioni religiose, ha una funzione permanente nella società, impossibile da sostituire con le scienze della natura o della società. Questo perché l’ordine simbolico non ha solo una valore conoscitivo, ma “include, in un quadro intuitivo e altamente emozionale, origine e prospettiva”4 di una civiltà. Nel caso dell’ordine simbolico mitico-rituale questa inclusione si ammanta di significati assoluti, metastorici. Il problema che si pone De Martino è invece quello di un simbolismo che accetti il fatto che gli uomini fanno la loro storia e ne portano interamente la responsabilità.
La trasformazione socialista della società è per l’antropologo una condizione fondamentale per il deperimento del simbolismo mitico-rituale. Ma cercando la leva per questa trasformazione il materialismo storico, secondo l’autore, incorre nel limite di ridurre l’attività dell’uomo alla soggettività economica. Ciò non significa sottovalutare l’importanza della sfera economica poiché essa, per De Martino, segna il limite entro il quale possono aver luogo gli altri comportamenti culturalmente significativi, in quanto inaugurale distacco dell’umano dal naturale, dalla mera soddisfazione del bisogno. L’economico è l’orizzonte del domestico, della “datità utilizzabile” secondo un progetto comunitario in cui “tradizione e iniziativa, memorie e scelte si compongono in una viva dialettica”.5 L’economicità è già un valore intersoggettivo che presuppone una volontà di storia, un trascendere la mera individualità per stare con gli altri nel mondo. Ma si tratta comunque di una distinta potenza del fare alla cui base c’è un’energia, un impulso propriamente umano a trasformare le situazioni date secondo un progetto intersoggettivo culturalmente significativo. E’ ciò che De Martino chiama “ethos del trascendimento”.
Nessuna trasformazione, tanto meno quella che porta al socialismo, sarebbe possibile senza questa “energia morale di trasformazione” che, sebbene possibile solo nella concretezza delle contraddizioni materiali di una data società, è alla base di tutti i regimi economici e di tutte le altre forme di coerenza culturale. La maturazione delle forze economico-sociali costituisce una possibilità concreta di cui l’ethos, se maturato, potrà profittare. Lo stesso Marx, anche se implicitamente, fa riferimento a temi etici. Il marxismo diventa dunque comprensibile solo come questo dover essere “mascherato a se stesso”, “vergognoso di sé”, per ragioni polemiche nei confronti dei “dover essere” astratti del suo tempo.
A dire il vero c’è almeno un punto nell’opera marxiana in cui qualcosa di molto simile all’ethos del trascendimento prorompe in modo tutt’altro che timido. Il filosofo tedesco, infatti, si chiede nei Grundrisse: cos’è la ricchezza, una volta cancellata la sua limitata forma borghese, se non
“l’estrinsecazione assoluta” delle doti creative dell’uomo “senza altro presupposto che il precedente sviluppo storico, che rende fine a se stessa questa totalità dello sviluppo, cioè dello sviluppo di tutte le forze umane come tali, non misurate su di un metro già dato? Nella quale l’uomo non si riproduce in una dimensione determinata, ma produce la propria totalità? Dove non cerca di rimanere qualcosa di divenuto, ma è nel movimento assoluto del divenire”?
E non è tutto volendo proseguire nei rimandi tra il pensiero del filosofo tedesco e quello dell’antropologo italiano. Marx, infatti, conclude il brano citato sostenendo che nel mondo borghese
“questa completa estrinsecazione della natura interna dell’uomo si presenta come un completo svuotamento, questa universale oggettivazione come alienazione totale, e la eliminazione di tutti gli scopi determinati unilaterali come sacrificio dello scopo autonomo a uno scopo completamente esterno”. Perciò, se paragonato con il mondo antico, “il mondo moderno lascia insoddisfatti, o, dove esso appare soddisfatto di se stesso, è volgare”.6
De Martino, dal canto suo, afferma che “La quotidianità non è necessariamente volgare, ma lo diventa se norme, atmosfere domestiche e familiari, abitudini vengono perdendo la segreta carica affettiva di fedeltà a concrete valorizzazioni del mondo comunitariamente raggiunte e trasmesse nel corso di generazioni”.7 Quando questo insieme di “memorie culturali dilegua, è il mondo che sprofonda” con la conseguente “catastrofe dell’esistenza e dell’esistente”.8 Di qui il rischio di non essere più in grado di rielaborare il passato restando esposti al suo ritorno gravido di paralizzante nostalgia; il pericolo di “perdere la prospettiva del futuro arretrando sgomenti davanti al possibile, di rifiutare il divenire come campo del progettabile e il fare come potenza progettante … invertendo il movimento dal privato al pubblico in quello opposto di una indefinita privatizzazione che recide ogni legame con la vita sociale” e dunque con la storia e la cultura.9 A fronte di questo annichilimento, continua, “si configura il sospetto, la mostruosità … e in genere una intenzionalità rovesciata carica di estraneità distruttiva … sotto la specie dell’essere-agito, della trama occulta, della allusività sospetta, e infine della mostruosità figurativa”.10
 Sembrano parole scritte per descrivere l’atmosfera politico-culturale dei nostri giorni. L’apocalisse della civiltà occidentale su cui si interrogava De Martino, dopo una crisi economica devastante non ancora superata, ha assunto la forma della strana non-morte del neoliberalismo (per dirla con Colin Crouch) perché nessuna vera alternativa è lontanamente pensabile, data la catastrofe delle culture subalterne: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Ammettere come dato naturale e immodificabile l’ordine cosiddetto neoliberale e più in generale il capitalismo significa oggi per le classi subalterne accettare definitivamente la perdita di quella che De Martino chiamava la domesticità del mondo, vale a dire quell’orizzonte di condivisione intersoggettiva che “riprende il passato e si dischiude al futuro”.11
Sembrano parole scritte per descrivere l’atmosfera politico-culturale dei nostri giorni. L’apocalisse della civiltà occidentale su cui si interrogava De Martino, dopo una crisi economica devastante non ancora superata, ha assunto la forma della strana non-morte del neoliberalismo (per dirla con Colin Crouch) perché nessuna vera alternativa è lontanamente pensabile, data la catastrofe delle culture subalterne: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Ammettere come dato naturale e immodificabile l’ordine cosiddetto neoliberale e più in generale il capitalismo significa oggi per le classi subalterne accettare definitivamente la perdita di quella che De Martino chiamava la domesticità del mondo, vale a dire quell’orizzonte di condivisione intersoggettiva che “riprende il passato e si dischiude al futuro”.11
Al punto in cui siamo, per scongiurare questa catastrofica perdita occorre niente di meno che tornare a pensare, insieme a Marx, un progetto in cui
“l’uomo socializzato, cioè i produttori associati, regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza cieca; che essi eseguano il loro compito con il minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di essa. Ma – prosegue Marx smentendo una sua presunta propensione ad appiattire l’essere umano sulla sua dimensione produttiva – questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso comincia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità. Condizione fondamentale di tutto ciò è la riduzione della giornata lavorativa”.12
Per quanto lontano possa sembrare un simile orizzonte, solo in questo modo si può recuperare oggi una domesticità del mondo e ripensare ordine simbolico integralmente umano. E allora, tanto per cominciare, occorrerebbe riprendere in mano la bandiera della riduzione della giornata lavorativa. Potrebbe sembrare una conclusione banale, visto che abbiamo qui evocato questioni che rimandano ai significati ultimi del vivere sociale. Ma in realtà tali implicazioni sono già presenti nelle intenzioni di De Martino:
“Non si entra nel ‘circolo’ della vita ‘spirituale’ indifferentemente attraverso qualsiasi punto del circolo stesso. Un’idea simile poteva nascere soltanto nel pensiero di filosofi ‘padroni’ per i quali la cultura era sempre un otium … Poteva nascere solo … in chi aveva cancellato in sé ogni memoria viva della fatica contadina, e trovando il pane sulla propria mensa ne mangiava lasciando nell’inconsapevolezza la storia umana che si celava dietro quel ‘nome’ che indicava un ‘cibo sicuro’”.13
Il libro si compone, occorre ricordarlo, di un insieme di materiali preparatori, che nella nuova edizione sono pubblicati seguendo una scansione tematica più che cronologica. Inoltre, rispetto alla precedente edizione, pubblicata sempre da Einaudi, alcuni materiali sono stati omessi, mentre altri sono aggiunti. E’ infine presente un nuovo apparato introduttivo formato dai contributi dei nuovi curatori. Il risultato è un volume di minore lunghezza e più facilmente leggibile. ↩
Ernesto De Martino, La fine del mondo, Einaudi 2019, edizione Kindle, pos. 8183. ↩
Ivi, pos. 7733. ↩
Ivi, pos. 2465. ↩
Ivi, pos. 3729. ↩
Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia, La Nuova Italia, 1978, Vol. II, pp. 112-113. ↩
Ernesto De Martino, La fine del mondo, pos. 6320. ↩
Ivi, pos. 6752. ↩
Ivi, pos. 9225. ↩
Ivi, pos. 6824. ↩
Ivi, pos. 9219. ↩
Karl Marx, Il Capitale, Libro III, Editori riuniti, 1972, pp. 231-232. ↩
Ernesto De Martino, La fine del mondo, Einaudi 1977, pag. 642. Citiamo dalla vecchia edizione perché si tratta di uno dei brani omessi nella nuova . ↩



