di Armando Lancellotti
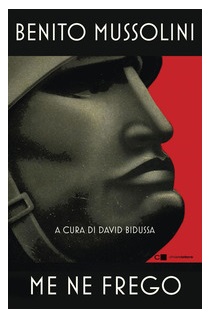 David Bidussa, a cura di, Benito Mussolini – Me ne frego, Chiarelettere, Milano, 2019, pp.144, € 12.00
David Bidussa, a cura di, Benito Mussolini – Me ne frego, Chiarelettere, Milano, 2019, pp.144, € 12.00
L’ultimo lavoro dello storico David Bidussa, recentemente pubblicato da Chiarelettere, consiste in una breve antologia di parole mussoliniane, selezionate all’interno della vastissima diponibilità di interventi, articoli, discorsi parlamentari, comizi di piazza o altro che progressivamente saturarono, occupandoli monoliticamente, lo spazio politico e l’opinione pubblica del nostro paese in un arco di tempo di poco più breve della prima metà del secolo scorso. Bidussa sceglie solo undici esempi di retorica mussoliniana, che vanno dal 1904, quando colui che sarebbe diventato il duce del fascismo era ancora un giovane socialista romagnolo su posizioni rivoluzionarie, al 1927, momento in cui il regime si era già ampiamente consolidato e strutturato dopo la svolta totalitaria del 3 gennaio 1925.
Come risulta subito evidente, la scelta dello studioso non è quella di coprire l’intero arco dell’esperienza politica di Benito Mussolini e neppure solo quella del ventennio fascista. A questo si aggiunga poi che la selezione dei discorsi antologizzati ricade spesso su esempi molto noti – come il discorso “del bivacco”, o quello del 3 gennaio ’25, o quello di “Quota 90” – perché l’intento che sottende il lavoro di Bidussa non è di proporre all’attenzione degli specialisti, spulciando tra i fiumi di parole pronunciate dal dittatore, nuove prospettive di lettura di qualche aspetto del fascismo meno approfondito di altri, bensì quello di mostrare, attraverso un libro agile e di semplice lettura, quanto la “parola” – declamata, urlata, in un qualsiasi modo comunicata al popolo dal leader carismatico – sia stata fondamentale per la costruzione del regime e come molte di queste “parole” ancora oggi siano in circolo – o abbiano ripreso a circolare – nel corpo fragile e frastornato del nostro paese.
Come ricorda Bidussa nella Prefazione (Vocabolario italiano) che introduce questa curatela, Claudio Pavone ha dedicato buona parte dei suoi sforzi di ricercatore e storico all’argomentazione della tesi secondo la quale al momento del cruciale passaggio del 1945 sia stata la “continuità” dello Stato – ovvero la conservazione di apparati, organi e strutture dell’Italia fascista – a prevalere nettamente sulla “discontinuità”, sulla rottura innovatrice auspicata e prospettata dalla Resistenza, soprattutto dalla sua componente più rivoluzionaria e, osserva Bidussa, «Uno dei campi dove misurare questa lunga continuità è il linguaggio, e anche alcune idee strutturali del modo di pensare il rapporto tra “Io individuale” e “Noi collettivo”» (p. XI). Molte delle parole d’ordine, degli slogan e delle espressioni che il fascismo coniò ex novo, o che a sua volta riprese dal linguaggio e dall’immaginario della trincea, del futurismo e del dannunzianesimo, divennero parte integrante del vocabolario italiano e ancora oggi lo sono, spesso in maniera implicita, inconsapevole o latente e gli sviluppi della profonda crisi politica in cui ormai da decenni è precipitato il paese predispongono le condizioni migliori per il loro ritorno in auge.
Ma le parole si riferiscono a concetti, evocano immagini, esprimono idee, risvegliano i ragionamenti e i nessi logici che le hanno prodotte e pertanto – spiega Bidussa – «se pure il problema non è che il fascismo stia tornando, quelle parole, con il loro carico di immaginario, sono tornate a circolare nella nostra mente e spesso nel nostro linguaggio parlato. Cioè sono tornate a essere “parole gridate” e non più solo “parole sussurrate”. E la forza del grido, se senza contrasto, le rende “parole ammesse”. Ovvero “legittime”» (p. VIII). La parola fascista prevale sul pensiero, in un certo senso lo fonda, allo stesso modo in cui per Mussolini sempre l’atto si impone sulla riflessione: in politica quel che conta è l’iniziativa, l’agire ben più dell’elaborazione teorica. Certamente questa convinzione trova nell’esperienza della trincea e nell’interventismo, propedeutici al fascismo, un humus fertile di cui nutrirsi, ma in realtà essa è componente fondamentale del modo di intendere la politica anche del giovane Mussolini socialista. Il gesto, il proclama, la manifestazione di volontà, la parola amplificata ed estesa dalle potenzialità tecniche degli strumenti comunicativi: sono tutte componenti della fascista estetizzazione della politica definita da Benjamin.
Gli undici testi proposti sono ordinati cronologicamente, a parte l’ultimo, posto come Appendice; i primi quattro appartengono al periodo prefascista di Mussolini, i rimanenti vanno dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento, nel 1919, al discorso dell’Ascensione, del 1927, in cui vengono poste le basi della politica demografica, che poi evolverà nella politica razziale. Si tratta di discorsi e scritti che potrebbero essere osservati da molteplici punti di vista ed analizzati su diversi piani e che Bidussa presenta, corredandoli con un breve commento introduttivo, per individuare e mettere a fuoco alcune categorie o concetti (im)politici che oggi, nuovamente, in un momento in cui i sistemi liberal-democratici e rappresentativi annaspano sotto il peso delle loro contraddizioni e dei loro limiti, hanno riacquistato legittimità politica, dando voce alla crescente fascinazione per scorciatoie politiche di tipo populistico ed autoritario.
Nell’articolo (La teppa) del 1904, pubblicato su Avanguardia socialista, l’allora ventunenne Mussolini esprime già quella indifferenza per le teorie politiche, per il rigore teorico, che accentuerà negli anni e decenni successivi. Ciò che conta è agire, prendere l’iniziativa e a questo può servire la teppa che dà il titolo al pezzo, che – giova ricordarlo – è datato 10 dicembre, vale a dire un mese dopo le elezioni politiche del 1904, quelle successive al primo sciopero generale della storia d’Italia. Ma Mussolini distingue poi tra la «teppa autentica che vegeta nei bassifondi della grandi città» (p. 4) e per la quale manifesta un malcelato disprezzo – poiché politicamente inconsapevole e buona pertanto solo per dare il via allo scontro rivoluzionario – e quello che definisce come «agitato oceano proletario», rispetto al quale la teppa è come la schiuma delle onde, che presto si disperde. Comincia a prendere forma una visione elitaria dell’azione politica, che si accentuerà esponenzialmente con il passaggio dal socialismo al fascismo e per la quale le masse sono un mezzo e non un fine. I termini che ricorrono più frequentemente in questo breve articolo sono «forza» e «violenza», che Mussolini contrappone alla «prosa sonora (sonora perché vuota)» (p. 4) degli ideologi e degli idealisti, tra i quali rientrano anche i socialisti riformisti.
Dieci anni dopo, nell’articolo uscito sull’Avanti! il 15 febbraio 1914 e che riassume la conferenza, dal titolo Il valore storico del socialismo, tenuta una settimana prima a Firenze, Mussolini prima espone, con modalità così didascaliche da risultare banali, i presupposti teorici del socialismo e poi passa all’individuazione dei fini e dei mezzi del socialismo rivoluzionario. Dopo aver denunciato l’inefficacia del principio riformista della conquista per via elettorale della maggioranza parlamentare – «C’è chi vuole aspettare per fare la rivoluzione la maggioranza assoluta» (p. 23) – esprime in modo inequivocabile posizioni di avanguardismo ed elitismo politici, affermando che «la massa è quantità, è inerzia. La massa è statica; le minoranze sono dinamiche» (p. 23). Nel rapporto tra masse e partito (in seguito sarà il rapporto tra popolo e leader carismatico), tra maggioranza e minoranze, alle seconde spetta un compito quasi demiurgico, alla prima solo quello di fornire consenso.
Queste idee subiscono un’ulteriore accentuazione qualche mese più tardi, nell’articolo – sempre pubblicato sull’Avanti! il 18 ottobre 1914 – che segna l’abbandono delle posizioni neutraliste del PSI e che prelude all’allontanamento dal giornale e dal partito di Mussolini, che qui elabora il concetto della “neutralità attiva ed operante” da contrapporre alla “neutralità assoluta”, ormai considerata una posizione sterile, improduttiva e destinata e relegare il partito ed il paese ai margini della realtà e del flusso della storia. Per Mussolini l’unico modo per essere protagonisti e non solo spettatori di quel che accade è muoversi nella stessa direzione verso cui la storia sembra tendere. L’intervento italiano può accorciare il conflitto e condurre alla costruzione di un nuovo assetto internazionale. Si percepisce nelle parole di Mussolini una sorta di smania di partecipare, di frenesia di essere protagonisti, di insofferenza per le riflessioni politiche e le elaborazioni teoriche del partito. A questo si aggiunga che alle considerazioni politiche, seppur un po’ sgangherate, di stampo classista degli anni precedenti si è ormai quasi completamente sostituito il nazionalismo interventista, come risulta evidente anche dal testo successivo, vale a dire il primo editoriale de Il popolo d’Italia del 15 novembre 1914, intitolato Audacia.
Il testo successivo è il Discorso di fondazione dei Fasci di combattimento, uscito su Il Popolo d’Italia il giorno dopo (24 marzo 1919) l’adunata di piazza San Sepolcro e i temi portanti, oltre al combattentismo e al nazionalismo, sono quelli dell’antipolitica e della contrapposizione tra movimento e partito, al fine di proporsi come forza antisistema, pronta a scavalcare leggi ed istituzioni vigenti e ad adattarsi pragmaticamente alle esigenze contingenti. L’incoerenza pragmatica verrà poi rivendicata come valore due anni dopo, in occasione del secondo anniversario della fondazione del fascismo, quando Mussolini sul proprio giornale scriverà che i fascisti possono permettersi il lusso «di essere aristocratici e democratici, conservatori e progressisti, reazionari e rivoluzionari, legalitari ed illegalitari a seconda delle circostanze di tempo, di luogo, di ambiente, in una parola “di storia” nelle quali siamo costretti a vivere e ad agire» (p. XVI). Parole pronunciate, in apparenza paradossalmente, solo qualche mese prima di trasformare il fascismo in partito (PNF), abbandonando l’ideale del movimento, ma proprio perché – si potrebbe dire – le «circostanze di tempo, di luogo, di ambiente» avevano reso nel frattempo quel passaggio utile e conveniente per la conquista del potere e del governo.
L’atteggiamento antipolitico ed antisistemico diventa poi apertamente antiparlamentare ed illiberale nel cosiddetto “discorso del bivacco”, ossia il discorso parlamentare di insediamento del primo governo Mussolini (16 novembre 1922), un paio di settimane dopo la marcia su Roma. Tutto l’intervento del nuovo presidente del Consiglio trasuda disprezzo nei confronti del Parlamento, come istituzione rappresentativa e strumento di mediazione tra il popolo e il suo capo. Le parole utilizzate vanno dall’ingiuria alla minaccia, passando attraverso lo scherno. La tracotanza è quella di un uomo che si trova a guidare istituzioni di cui ha scarsa considerazione e che attende di poter oltrepassare e sopprimere, insieme agli ideali liberal-democratici in esse insiti. Che è quanto Mussolini dichiara nel successivo testo proposto da Bidussa, l’articolo pubblicato su Gerarchia nel marzo del 1923 – Forza e consenso – in cui, oltre a ribadire il primato dell’azione sulla riflessione e la legittimità del ricorso alla forza, il capo del fascismo apertis verbis rivendica la legittimità dell’abbandono e del superamento dell’idea, ritenuta inattuale ed obsoleta, di libertà. «Si sappia dunque, una volta per tutte, che il Fascismo non conosce idoli, non adora feticci: è già passato e, se sarà necessario, tornerà ancora tranquillamente a passare sul corpo più o meno decomposto della Dea Libertà» (p. 74).
La convinzione che la libertà non sia da ritenersi un fine in sé, ma solo un mezzo e che ad essa si debbano sostituire nuovi principi quali «ordine, gerarchia, disciplina» sta alla base anche dell’analisi del pensiero politico del Machiavelli che Mussolini elabora nel 1924 sempre su Gerarchia e che Bidussa colloca alla fine del volume come Appendice. Nel Principe il duce del fascismo va alla ricerca dei presupposti del suo modo di intendere il rapporto tra Stato e cittadini, che ritiene di poter accostare a quello stabilito dal segretario fiorentino tra principe e popolo. Per prima cosa, Mussolini dichiara di condividere il pessimismo del Machiavelli riguardo alla natura umana, che nei suoi ragionamenti si trasforma in un pregiudizio sociale e politico nei confronti del popolo, di quelle masse precedentemente definite come “quantità” e “inerzia”. È lo Stato che deve imporsi sugli individui e risolvere le conflittualità delle loro relazioni atomistiche, sussumendole nella propria organizzazione superiore. Per questo Mussolini ritiene di dover prendere le distanze dalle rivoluzioni del Seicento e del Settecento, figlie del pensiero giusnaturalista e liberal-democratico, perché, a suo parere, fondate su un’idea sbagliata di popolo, che – egli scrive – è «un’entità meramente astratta, come entità politica. Non si sa dove cominci esattamente, né dove finisca». Pertanto, conclude, «l’aggettivo di sovrano applicato al popolo è una tragica burla» (p. 106). Sovrano è lo Stato e il “principe” che lo guida, il quale si rapporta direttamente al popolo, conducendolo, senza bisogno delle istituzioni e degli organi intermedi, propri dei sistemi rappresentativi.
Ed è quanto Mussolini lascia intendere che sarebbe accaduto con il Discorso alla Camera dei deputati del 3 gennaio 1925, quello successivo al delitto Matteotti e alla secessione dell’Aventino e con il quale si dà il via definitivo alla dittatura e al totalitarismo. Colpiscono nelle parole del duce l’arroganza e la spudoratezza con cui egli si assume la responsabilità politica, morale e storica di quanto è accaduto, ritenendosi legittimato dalla necessità di perseguire il superiore interesse del paese e degli italiani ed accusando le opposizioni aventiniane di comportamento antinazionale ed eversivo.
Bidussa infine riporta anche il Discorso di Pesaro, pubblicato da Il Popolo d’Italia il 19 agosto del 1926 e il Discorso dell’Ascensione, tenuto alla Camera dei deputati il 26 maggio del 1927. Nel primo si dà l’annuncio di quel provvedimento di politica monetaria che va sotto il nome di “Quota 90”, economicamente svantaggioso per il paese nel suo complesso, ma molto proficuo dal punto di vista propagandistico e del consenso. Come osserva Bidussa, con “Quota 90” Mussolini proclama una politica di nazionalismo e sovranismo monetari, che dichiara di voler difendere la divisa italiana – rivalutandola in realtà oltre il suo effettivo valore – nel contesto economico e monetario internazionale. Si tratta di quell’atteggiamento nazionalista e sovranista che avrebbe trovato il suo culmine nella politica autarchica di una decina di anni dopo.
Il Discorso dell’Ascensione pone le basi della politica sociale e demografica che il regime intraprende a partire dal 1927 e la parte del discorso che Bidussa riporta ha per titolo La difesa della razza. Qui il razzismo fascista si limita ancora sostanzialmente alla pars construens e cioè alle politiche di incremento demografico, di sostegno e divulgazione del modello tradizionale della famiglia prolifica; una decina di anni dopo, con la conquista dell’Etiopia e con la legislazione antisemita, si passerà anche alla pars destruens. Il ragionamento di Mussolini è funzionale all’affermazione imperialistica dell’Italia nel mondo e affinché essa sia realizzabile occorre un incremento demografico quantificato in venti milioni di italiani in circa vent’anni. Solo un popolo numeroso potrà essere forte e potrà conquistare l’impero; ma attraverso il legame posto tra politica demografica e politica di potenza passa anche la visione tradizionalista della società e maschilista della famiglia e del ruolo sociale della donna che è propria del fascismo.
Insofferenza per la riflessione teorica in politica e privilegio accordato all’azione e alla capacità d’iniziativa; disprezzo antipolitico per i partiti tradizionali e i sistemi politici rappresentativi; ricorso alla forza; antiliberalismo; interpretazione elitaria della politica ed utilizzo delle masse esclusivamente come bacino di consenso; superamento delle modalità mediate di rapporto tra popolo e istituzioni e ricorso a modalità di relazione diretta tra leader e masse; populismo; autoritarismo; nazionalismo e sovranismo; adozione di politiche demografiche per la difesa e la promozione del popolo e della sua identità. È un lungo elenco di parole, idee, concetti, slogan fascisti che fino a non molti anni fa erano per lo più esclusi dallo spazio della dicibilità politica o comunque relegati in un sottobosco politico in cui si riteneva che sarebbero stati facilmente confinati. Oggi invece le cose sono cambiate e queste parole d’ordine, questi slogan e questi proclami nuovamente risuonano attorno a noi, con una frequenza crescente ed una insistenza martellante. Si presentano declinate in forme adatte all’oggi, con sfumature e toni differenti rispetto al passato, ma rimangono uguali nella sostanza della loro venefica pericolosità. Ed è questo il “ritorno del fascismo” che deve preoccupare. Non il ritorno di esso come esperienza politica, forma di governo e regime quali si configurarono dal 1919 al 1945, in quanto il fascismo nelle sue forme storicamente determinate rimane ovviamente irripetibile, come ogni altra forma storica particolare; ma il fascismo come forma del pensare politico, sociale e civile ha invece già imboccato la via del ritorno e sembra non incontrare ostacoli capaci di arginare la forza di questa onda nera montante.



