di Gioacchino Toni
 «Se c’è un’eredità visiva che la Grande guerra ha lasciato al Novecento, questa è l’inganno: in battaglia la priorità diventa non più mostrare al nemico un volto minaccioso, ma fingere di non esserci o mostrare ciò che non c’è; per il fronte interno si deve invece inventare una diversa verità, un nemico disumano o una guerra senza dolore» Gabriele D’Autilia
«Se c’è un’eredità visiva che la Grande guerra ha lasciato al Novecento, questa è l’inganno: in battaglia la priorità diventa non più mostrare al nemico un volto minaccioso, ma fingere di non esserci o mostrare ciò che non c’è; per il fronte interno si deve invece inventare una diversa verità, un nemico disumano o una guerra senza dolore» Gabriele D’Autilia
«Cosa e come si vedeva […] durante la guerra, e cosa non si vedeva? Quale reale restituirono le immagini ottiche? Come interagì la percezione della guerra e delle sue immagini con gli immaginari di soldati e civili? Chi stabiliva cosa vedere e quali erano i motivi delle sue scelte? Qual era il rapporto tra l’immagine ottica e l’immagine che prevedeva ancora l’intervento della mano dell’uomo? Cosa ha lasciato la guerra alla cultura visuale successiva?» (p. 22). A questi interrogativi si propone di rispondere il libro di Gabriele D’Autilia, La guerra cieca. Esperienze ottiche e cultura visuale nella Grande guerra (Meltemi, 2018).
La Prima guerra mondiale può dirsi cieca per numerosi motivi. Cieca perché le tecnologie ottiche impiegate non risultarono capaci di mostrarla e raccontarla, perché il nemico finì con l’essere sempre meno visibile, perché attraverso la propaganda e la censura visive al fronte interno si restituì una visione parziale o immaginaria della guerra, perché i signori della guerra guardarono più al passato che al presente o al futuro, perché si tentò di non riconoscere l’orrore e di preservarne il ricordo ma anche perché, sottolinea D’Autilia, la cultura visuale si mostrò priva degli strumenti utili a capire e interpretare la guerra moderna.
Paradossalmente nel momento in cui le tecnologie visive venivano accolte con entusiasmo, la guerra finì col celare alla vista il campo di battaglia mentre l’occultamento e la dissimulazione divennero armi strategiche al fronte oltre che mezzo di orientamento dell’opinione pubblica. La Grande guerra in eredità visiva al Novecento sembra davvero aver lasciato l’inganno, preoccupata com’era di falsificare la visione in battaglia (celare/simulare) e di inventare una diversa realtà (mostrificare/edulcorare) della guerra da raccontare sul fronte interno. «Se ogni guerra del passato poteva essere osservata dai suoi generali come in un teatro (e anche alle popolazioni civili, che pure non erano considerate “opinione pubblica” come quelle moderne, se ne offriva una narrazione lineare e controllata), il soldato subì nel corso dei secoli un progressivo offuscamento del proprio campo visivo fino alla sua totale scomparsa con la Grande guerra, un’esperienza psicologicamente devastante proprio per il disperato senso di smarrimento e di angoscia determinato da un pericolo mai vissuto così in precedenza. In modo diverso però, questa guerra fu una sfida per gli occhi anche dei civili» (p. 120)
Negli anni della Grande guerra ormai fotografia e cinema avevano, soprattutto la prima, notevolmente affinato le loro tecniche e sperimentato l’impiego in ambito bellico. Nei conflitti come quello di Crimea, nella guerra civile americana o nella guerra russo-giapponese, i vari schieramenti non avevano ancora pianificato veri e propri sistemi di comunicazione attraverso le immagini. È con la Grande guerra che le cose cambiano: «la fotografia, immagine del reale, a cui da pochi anni si è affiancata la cinematografia “dal vero” con funzioni analoghe, assume un ruolo centrale, mettendo in gioco tutte le sue potenzialità: è strumento tattico, scientifico e medico, è documentazione “storica”, è memoria individuale, è propaganda; quest’ultima prerogativa è cruciale, perché è con la Grande guerra che la fotografia rivela per la prima volta come la sua capacità di mostrare oggettivamente possa coniugarsi con quella di dimostrare “oggettivamente” il falso» (pp. 12-13)
Il Primo conflitto mondiale si rivela essere una guerra che non si deve né si può vedere. Basta osservare i cataloghi di fotografie militari, suggerisce D’Autilia, e prendere atto di quali siano i soggetti più ricorrenti tanto nelle immagini pubbliche che in quelle private: «sfilate militari, ritratti di gruppo in trincea, artiglierie ciclopiche, granate inesplose, ricoveri fangosi, panorami dove non si riconosce nulla (era ciò che vedevano i soldati), innocui sbuffi di fumo (unica traccia di esplosioni spaventose), immagini da cartolina di villaggi ancora integri oppure con gli occhi vuoti delle case bombardate, ufficiali che scrutano il fronte con i cannocchiali, scherzi tra ufficiali o soldati, messe da campo, traini di cannoni, vedette, foto di noia o di attesa febbrile, tombe, ospedali da campo (ma solo per mostrarne l’organizzazione: i feriti si alzano dalla barella per mettersi in posa), lunghe panoramiche composte, paesaggi romantici al tramonto (un privilegio della guerra di montagna), qualche artigiano militare, barbieri, i volti primitivi delle maschere antigas. Del tutto simili sono le scene dei film “dal vero”» (p. 13)
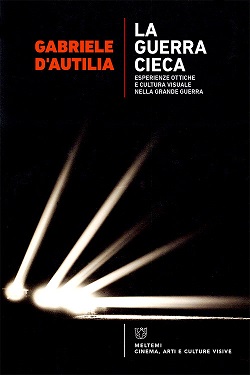 In questo atto d’avvio della guerra tecnologica «restarono invisibili le due cose essenziali dell’esperienza di guerra – e di conseguenza per la sua narrazione – almeno dai tempi di Omero: il nemico e la battaglia. Sarà proprio la potenza delle tecnologie di distruzione e di osservazione a far sì che essere visti (mentre si punta un’arma o un obiettivo fotografico) coinciderà con l’essere uccisi da un nemico invisibile, un nemico disincarnato, e questo, oltre ad avere conseguenze sull’immaginario bellico, comporterà anche la quasi totale assenza di immagini sulla guerra guerreggiata» (pp. 13-14).
In questo atto d’avvio della guerra tecnologica «restarono invisibili le due cose essenziali dell’esperienza di guerra – e di conseguenza per la sua narrazione – almeno dai tempi di Omero: il nemico e la battaglia. Sarà proprio la potenza delle tecnologie di distruzione e di osservazione a far sì che essere visti (mentre si punta un’arma o un obiettivo fotografico) coinciderà con l’essere uccisi da un nemico invisibile, un nemico disincarnato, e questo, oltre ad avere conseguenze sull’immaginario bellico, comporterà anche la quasi totale assenza di immagini sulla guerra guerreggiata» (pp. 13-14).
La cultura visuale, sottolinea Gabriele D’Autilia, oltre che con le esperienze ottiche e le immagini, ha a che fare anche con le immagini del mondo mentale, visto che «ogni nuova immagine entra in relazione o in conflitto con l’immaginario dei singoli soggetti e con l’immaginario sociale, in cui vivono il passato e il mito» (p. 14). Le trasformazioni della cultura visuale operate dalla Prima guerra mondiale hanno coinvolto tanto le immagini che gli occhi degli osservatori, soldati e civili; il conflitto ha determinato un vero e proprio trauma sensoriale innestatosi sulle trasformazioni percettive dell’epoca. Dopo questa guerra, almeno in Occidente, l’essere umano si trova costretto ad «elaborare una nuova etica della visione, a prendere coscienza delle sue astuzie e delle sue menzogne, a stabilire dentro di sé un diverso statuto di verità: accettando le immagini ingannevoli della pubblicità e dei regimi totalitari, con le loro promesse e illusioni, ma anche apprezzando la rilettura soggettiva del reale proposta da quel fondamentale laboratorio di immaginario novecentesco che sarà, a partire dagli anni Venti, il fotogiornalismo (e in modo diverso il film documentario)» (p. 20).
La Grande guerra apre davvero le porte alla perdita dell’esperienza e della possibilità di comunicarla, come aveva intuito Walter Benjamin, e «la sua rappresentazione attraverso film e fotografie mostra già, e tangibilmente, il fallimento della relazione tra esperienza e conoscenza, quella conoscenza oggettiva che era stata e si sarebbe continuato ad assegnare inequivocabilmente alla riproduzione ottica. E tuttavia nuove forme di racconto si annunciano e in questo fotografia e film avranno un ruolo centrale: la narrazione dell’esperienza, e persino la perduta “aura” fotografica, saranno declinate per un pubblico diverso, un pubblico che ha conosciuto la catastrofe tecnologica ma che tuttavia non può rinunciare a credere» (pp. 21-22).
Se Paul Virilio ritiene sia possibile far risalire la guerra tecnologica moderna al conflitto in Crimea e alla Guerra civile americana, sarà però a partire dalla Prima guerra mondiale che si assisterà a quella lotta tra visibilità e invisibilità che caratterizzerà tutti i conflitti successivi. Alle divise sgargianti ottocentesche si sostituiranno tenute atte a rendersi visibili il meno possibile. «Se falliscono gli strumenti per individuare il nemico, quelli per sorvegliare il soldato-cittadino sono invece ben funzionanti. Stato e guerra diventano come sinonimi, lo Stato in guerra si appropria del cittadino, del suo corpo, del suo destino, della sua stessa personalità. Liste di leva, controlli di polizia, censura postale, carte di identità sono già in funzione da decenni, ma ora si va oltre. Sono molti i casi di soldati con l’ossessione di essere spiati, in trincea e poi nei luoghi di detenzione e sanitari dove vengono spediti dopo traumi o ferite. È dunque una dimensione visiva anche l’ossessione, senza poter vedere, di essere visti, dal nemico e dallo Stato» (p. 134). Del resto è con la Grande guerra che fa la sua comparsa quella “visione verticale”, una visione aerea che si propone come “occhio vedente” della “guerra cieca”, che può essere considerata un’anticipazione della “strategia della visione globale”, della “ubiquità della visione” prospettata da Virlio, non più umana ma automatizzata.
Il libro di Gabriele D’Autilia affronta pertanto la complessità della trasformazione percettiva e dell’immaginario visuale che prende il via con la Grande guerra e che arriva fino ai giorni nostri, cioè a un’epoca contrassegnata dal ricorso ai droni, dal controllo dei corpi, dalle visioni aumentate o celate, dalle guerre filtrate dalle messe in scena dei media e via dicendo di cui si è occupato il volume curato da Maurizio Guerri, Le immagini delle guerre contemporanee (Meltemi, 2018) e su cui siamo tornati più volte su Carmilla, così come occorrerà riprendere alcuni spunti offerti dal libro di D’Autilia a proposito dell’interazione tra la percezione della guerra e delle sue immagini con gli immaginari di soldati e civili e su cosa abbia lasciato questo conflitto alla cultura visuale e all’immaginario bellico successivi.
Per la parte del volume di Gabriele D’Autilia che si occupa delle modalità con cui alcune opere cinematografiche britanniche hanno mostrato e raccontano il conflitto bellico durante il suo svolgimento si rimanda allo scritto pubblicato su “Il lavoro culturale” incentrato soprattutto su The Battle of the Somme (1916) di Geoffrey Herbert Malins, film considerato da numerosi studiosi come l’opera che ha cambiato la percezione della guerra.
Serie “Guerrevisioni”



