di Gioacchino Toni
 John Clarke, Football hooliganism. Calcio e violenza operaia, DeriveApprodi, Roma, 2019, pp. 120, € 12,00
John Clarke, Football hooliganism. Calcio e violenza operaia, DeriveApprodi, Roma, 2019, pp. 120, € 12,00
L’importanza dei lavori di John Clarke, tra i primi studiosi a occuparsi delle radici dell’hooliganismo in Gran Bretagna negli anni Settanta indagando il legame tra calcio e condotte violente delle fasce popolari, è messa in risalto nell’Introduzione stesa da Luca Benvenga al volume: «Attraversando epoche differenti [Clarke] mette sotto la lente conoscitiva, oltre all’evoluzione che ha investito questo sport in termini strutturali e più propriamente di partecipazione agli eventi, la tesi della violenza come conditio sine qua non per una crescente preoccupazione di gruppi di giovani partoriti dalla deindustrializzazione. Così riaffermando nella “passione aggressiva” i valori di una classe e l’esasperato senso di territorialità con la riappropriazione dei campi, in una logica tutta operaia di presidio simbolico di uno spazio (come lo street corner, la piazzetta o il quartiere) che emerge per contrapposizione […]. Secondo Clarke il progressivo cambiamento che interesserà il gioco del calcio nel secondo dopoguerra è, per i figli della working class britannica, il pretesto per l’esplosione di un sentimento di frustrazione e di un generale malcontento nei confronti della società. Il “football hooliganism” si afferma così in nome di una volontà di esprimere una refrattarietà all’imposizione di un modello-calcio che si sposta coattivamente verso la professionalizzazione […], la commercializzazione […] e la spettacolarizzazione» (p. 13).
Nelle alienanti società moderne avare di avvenimenti straordinari capaci di fuoriuscire dalla routine quotidiana, il calcio resta una dei pochi ambiti in grado di soddisfare tanto la domanda di emozioni forti che la possibilità di una loro espressione pubblica. «A partire dalla Rivoluzione industriale la vita di gran parte dei lavoratori si definiva nell’organizzazione tecnica e nella disciplina oraria del lavoro in fabbrica. Il calcio ha così offerto un’alternativa alla routine, ridisegnando l’esperienza quotidiana della classe operaia […] L’eccitamento si intensifica con l’esperienza di considerarsi parte di un vasto pubblico di tifosi. La pressione fisica, il trasporto psicologico, essere “uno” tra altri cento a incoraggiare la propria squadra è parte essenziale del fascino del gioco» (p. 38).
I settori popolari degli stadi sono stati storicamente occupati da lavoratori manuali abituati allo scontro dal loro dover fare i conti con la sopravvivenza sociale e un gioco come quello del calcio, caratterizzato dal corpo a corpo e dallo scontro fisico, non poteva che attrarre una classe operaia abituata da sempre al conflitto e alla durezza della vita quotidiana spesa tra lavoro e quartiere. All’interno di una working class abituata a fare i conti con l’aggressività e contraddistinta da una notevole dose di machismo, la violenza, sostiene Clarke, non era di certo vista come problema, né doveva essere giustificata.
Il calcio, scrive C. R. Critcher (Football as popular culture – an outline), «ci restituisce complessivamente la prospettiva operaia della violenza: “In questo alternativo universo morale la violenza è legittimata come in nessun altro contesto della società, ma è allo stesso tempo abbondantemente localizzata, come se il calcio consentisse di formalizzare delle attitudini proprie dei lavoratori, come fosse un sistematico aspetto della vita di ognuno che può periodicamente manifestarsi, ma non ci si aspetta che ciò sfugga di mano o che si trasformi in uno stato d’animo pervasivo”» (p. 40).
Il calcio, puntualizza Clarke, ha a lungo rafforzato quel senso di comunità, di territorialità e di mutualità della working class. Nella squadra veniva vista una sorta di rappresentativa della comunità impegnata nella difesa del territorio dagli estranei. Tale senso territoriale alle origini è stato rafforzato dal fatto che molti giocatori erano nati e vissuti in quei quartieri, spesso erano di estrazione operaia e per certi versi restavano parte della classe di provenienza in termini salariali e di stile di vita.
Il volume si sofferma anche sul ruolo rivestito dalla vittoria nell’immaginario popolare. Riferendosi agli anni Venti, scrive a tal proposito Arthur Hopcraft (The Football Man, 1971) che andare alla partita significava «lasciarsi alle spalle uno stato di profondo sconforto e immergersi nella lotta. L’identificazione con la squadra di casa restituiva un’individuazione positiva attraverso la forza e i goal. La vittoria era un successo personale, la sconfitta un altro schiaffo dato dalla vita. Il calcio non era tanto una droga per la gente, quanto un baluardo scagliato contro il capitalista che chiude la fabbrica e il padrone di casa armato di ufficiali giudiziari» (p. 43).
È a partire dal dopoguerra che il calcio cambia profondamente indirizzandosi verso la professionalizzazione, l’internazionalizzazione e la commercializzazione. «Tutte queste trasformazioni sono legate alla fiducia nella struttura sociale della Gran Bretagna negli anni Cinquanta. È l’era dell’Affluenza, del consenso politico, dell’emergere di una società senza classi. I club di calcio, in questo nuovo ordine sociale, anticipano la scomparsa del supporter con il tradizionale cloth-capped, percepiscono di dover affrontare una crescente competizione per accaparrarsi il pubblico, in concorrenza con forme alternative di intrattenimento, cinema e tv su tutti. Se lo storico fan non esiste più, rimane tuttavia il tradizionale attaccamento; i club si propiziano il nuovo consumatore senza classi, razionalmente selettivo. Egualmente, il gioco deve essere reso il più possibile coinvolgente “per attrarre” il nuovo spettatore, metterlo a proprio agio e accoglierne ogni richiesta. Era impensabile che si recasse ogni sabato ad assistere agli incontri di una squadra debole e perdente, perciò occorreva maggiore attenzione per scongiurare l’insuccesso» (p. 46).
Ian Taylor (Football Mad a Speculative Sociology of Soccer Hooliganism, 1971) ricorre al termine “borghesificazione” per indicare quel processo che vede la classe media appropriarsi di ciò che in passato apparteneva alla working class. Quella generale trasformazione tendente a piegare l’intera società inglese sul modello della classe media, sostiene Clarke, provocherà una modificazione della figura del tifoso “genuino” non più riconducibile al proletario tradizionale che viveva nell’attesa della partita settimanale «con le sue fortune inestricabilmente legate alle sorti della squadra, partecipante attivo del gioco», bensì a un «consumatore razionale e selettivo dei servizi di intrattenimento, che commenta dal suo comodo posto in tribuna. Questa antinomia trova la sua ipotesi esplicativa nelle figure del “Fan” da un lato e dello “Spettatore” dall’altro (una simile distinzione è stata adoperata per altre attività di svago della classe operaia, come il pub, per citare un esempio, nei termini di una ripartizione tra frequentatori e clienti)» (p. 48).
È a partire dalla metà degli anni Sessanta che il teppismo calcistico inizia ad essere etichettato come problema e attraverso la retorica gonfiata dai media sul teppismo legato agli stadi prenderanno piede alcuni stereotipi duri a morire, come l’idea che vede negli hooligan giovani ignoranti appartenenti alla working class che frequentano gli stadi privi di qualsiasi interesse per la partita al solo scopo di creare disordini per sfogare una violenza del tutto gratuita e irragionevole. Sui media inglesi spesso i settori popolari sono descritti come luoghi lerci, avvolti dal puzzo rancido di birra e cipolle, ove risuonano oscenità e vanno in scena comportamenti del tutto incivili. Affinché il calcio potesse essere confezionato su misura per la middle class, occorreva ripulirlo da tutto ciò: la working class andava ammaestrata.
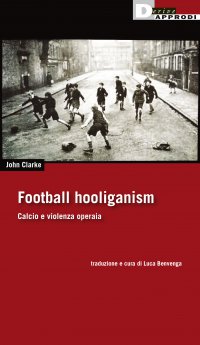 In balia di tali trasformazioni molti giovani fan di estrazione popolare finirono per sentirsi derubati del loro gioco e della loro squadra. Secondo Ian Taylor a questi giovani non è restato che tentare di mantenere in vita alcune caratteristiche tradizionali del loro gioco. «Mantengono vive le antiche rivalità, oramai di poca importanza per i club, l’“invasione” del territorio nelle partita in trasferta lascia ora il posto al take the ende nella più recente occupazione del centro città. La natura del viaggio è di per sé significativa. La giornata per soli maschi della classe operaia ha rappresentato per lungo tempo un’occasione per “lasciarsi andare” e bere senza freni» (pp. 54-55).
In balia di tali trasformazioni molti giovani fan di estrazione popolare finirono per sentirsi derubati del loro gioco e della loro squadra. Secondo Ian Taylor a questi giovani non è restato che tentare di mantenere in vita alcune caratteristiche tradizionali del loro gioco. «Mantengono vive le antiche rivalità, oramai di poca importanza per i club, l’“invasione” del territorio nelle partita in trasferta lascia ora il posto al take the ende nella più recente occupazione del centro città. La natura del viaggio è di per sé significativa. La giornata per soli maschi della classe operaia ha rappresentato per lungo tempo un’occasione per “lasciarsi andare” e bere senza freni» (pp. 54-55).
Se Ian Taylor ha avuto il merito di cogliere e analizzare il collegamento tra violenza e calcio, palesa però il limite, scrive Clarke, di non spiegare i motivi per cui numerosi giovani vivono il calcio in maniera così totalizzante in un momento storico in cui si tanti loro coetanei si sono spostati verso altre culture giovanili.
Nella seconda parte del volume Clark analizza le trasformazioni sociali che hanno agito sul mondo del calcio a partire dalla comparsa del fenomeno Skinhead, considerato da molti l’estrema sintesi del fenomeno hooligan. Comparsi originariamente nel 1968 nell’East End di Londra, in poco tempo i gruppi Skinhead hanno fatto la loro comparsa negli stadi di tutto il paese attirando l’attenzione perché spesso coinvolti in episodi di violenza e per un modo di presentarsi decisamente connotato: scarponi da lavoro spesso dotati di rinforzo metallico, jeans con risvolto, bretelle, capelli rasati ecc. Il fenomeno Skinhead viene alla luce in un’epoca di mutamenti sociali che segnano la rottura dello stile di vita della working class la dissoluzione delle comunità tradizionali segnate dall’arrivo nei quartieri di immigrati e di famiglie della classe media attraverso trasformazioni urbanistiche che spostano molti nuclei famigliari nei nuovi quartieri sorti attorno ai sobborghi più periferici e per mezzo di una progressiva sostituzione dei tradizionali trenini di case orizzontali che correvano a stretto contatto con la vita di strada fatta di pub, negozietti e spazi comuni con grandi palazzoni in verticale. Questa sistematica rimozione dei vecchi spazi di socializzazione ha comportato un arroccamento nei pochi luoghi rimasti, come il campo da calcio, che hanno così assunto ulteriore valenza identitaria-culturale; è significativo, afferma Clarke, che le zone in cui si strutturano i gruppi di Skinhead corrispondono a quei nuovi o vecchi quartieri di edilizia popolare riprogettati e in cui giungevano sempre più “outsider”.
A cambiare non sono però soltanto gli stadi; gli stessi pub e i club vengono trasformati in “divertimentifici” e la concentrazione nel centro città delle strutture dedicate ai giovani comporteranno un indebolimento delle comunità periferiche. Se negli anni Cinquanta ha preso piede l’idea di una società che si voleva senza classi, avviata all’opulenza, il decennio successivo ha invece manifestato la povertà e i conflitti di classe, con un’istituzione scolastica vissuta come un luogo alieno da molti giovani della working class.
«Fin dall’avvento del rock’n’roll e dei Ted all’inizio degli anni Cinquanta, i giovani hanno cercato di risolvere questa crisi culturale e la conseguente mancanza d’identità creando delle culture più appropriate alle proprie esigenze ed esperienze. (La classe operaia ha reagito a questi cambiamenti in maniera difforme, tra chi aveva nostalgia dei tempi passati, e chi attraversava la sindrome del “Lavoratore Benestante” mediante un ritorno introspettivo in seno alla famiglia). Verso la metà degli anni Sessanta, le due tendenze di sviluppo della cultura giovanile erano la continuazione dell’“era Mod” e la crescita dell’underground inglese. Nessuna delle due correnti si adattava alle esperienze dei giovani che sarebbero diventati degli Skinhead» (p. 61).
Nel libro viene sottolineato come nonostante molti Mod provenissero dalla classe operaia, il centro della scena di questa cultura giovanile fosse in mano a giovani colletti bianchi occupati nei lavori più umili, inoltre lo stile Mod finì presto per rivolgersi a consumatori benestanti per divenire alla fine degli anni Sessanta una vera e propria impresa commerciale ben supportata dalle band musicali più in vista. «Da quel momento piombarono nella scena gli Skinhead, il vero impeto dei Mod scompariva e restava solo l’aspetto commerciale. Gli Skinhead stravolsero l’immagine Mod, esattamente come i Mod fecero con i Rocker. […] Lo stile Skin riaffermava le vecchie tradizioni di una cultura minacciata da una contaminazione di valori e simboli middle-class. L’uniforme Skinhead è una versione stilizzata della working clothes, è l’immagine rivisitata della classe operaia attraverso il taglio di capelli, attitudine, violenza, ma tutto ciò si esprimeva in tinte esagerate, come fosse una forma di auto-rappresentazione caricaturale […] e l’inevitabile scenario per ricostruire i tradizionali valori della working class era il classico luogo di ritrovo del sabato pomeriggio, il campo di calcio» (pp. 63-65).
Dunque, sostiene Clarke, nel fenomeno degli hooligan nel calcio è possibile scorgere un tentativo di mantenere o riportare il calcio alla working class, «un tentativo di difendere la cultura operaia dall’usurpazione della borghesia. La violenza, il razzismo, il puritanesimo e il localismo (l’effetto della comunità nel gruppo, ovvero l’aiutarsi l’un l’altro quando il pericolo incombe) fanno tutti parte di questo ricrearsi un tipo di vita» (p. 65).
Nel libro Clarke illustra «come il “declino della comunità d’origine”, l’aumento della ricchezza e le diseguaglianze socio-economiche possono essere ritenuti i responsabili della formazione di differenti risposte come quelle Mod e Skinhead. […] I Mod emergevano in un periodo della vita inglese in cui i temi della società senza classi e dell’opulenza erano fortemente significativi, mentre il quadro era cambiato notevolmente alla fine degli anni Sessanta, e il fenomeno Mod divenne parte del background sociale in cui trovarono spazio gli Skin» (p. 66)
Al tentativo disperato di questi settori giovanili di mantenere il calcio all’interno della working class si debbono aggiungere i media nel loro far da grancassa agli episodi di violenza negli stadi, contribuendo così a richiamare sugli spalti chiunque avesse voglia di menar le mani a prescindere dai motivi, le esigenze dei club calcistici avviati verso una riorganizzazione indirizzata a una middle class che voleva poter godere in tranquillità lo spettacolo calcistico, dunque il rafforzamento della presenza poliziesca. Con tali premesse la profezia della violenza non poteva che auto-avverarsi.
Secondo lo studioso il calcio ha a lungo mantenuto uno stretto legame con la classe operaia perché quest’ultima vi individuava valori comuni come l’abilità fisica, l’identità territoriale e il desiderio di vittoria. «L’assunto centrale era una precisa idea di mascolinità, su ciò che significa “essere uomo”. Un uomo si pensava dovesse essere “rude”, non nel senso di brutale o vizioso, ma in grado di sopportare un “castigo” (una “punizione”). Nel caso del calciatore significava essere colpiti alle spalle, farsi scaraventare a terra dall’avversario, tollerare tali “offese” e mostrarsi pronto a subire dell’altro. Per il tifoso della classe operaia questa “rudezza” era una qualità molto preziosa nella vita quotidiana. Egli doveva sopportare i rigori, le imposizioni, le pressioni del lavoro in fabbrica e sperimentare nuove tensioni ogni qualvolta si recasse sul posto di lavoro. Il lavoratore (come salariato) non poteva accettare di arrendersi a queste pressioni, così il calciatore non si poteva sottrarre allo scontro fisico sul terreno di gioco. Sia nel calcio che nella vita dei lavoratori maschi certi tipi di violenza erano “normali” – “un uomo deve essere in grado di badare a se stesso”. È importante comprendere che solo alcune condotte violente erano accettate: la slealtà, ad esempio, era tenuta fuori dalla “normalità” (pp. 76-77).
Gli operai inglesi d’anteguerra vedevano nella durezza a cui veniva sottoposto il fisico del calciatore un’analogia con quella a cui erano costretti a sottoporre il proprio nelle fabbriche. «I campi di calcio delle più antiche società sportive nascevano quasi tutti nelle aree industriali delle principali città. I fari, gli spalti, le terrace sorgono tra le ciminiere delle fabbriche e le file di case a schiera. Questa disposizione è l’aspetto più visibile della connessione tra il club e il territorio. […] L’interazione tra il gioco del calcio e gli spettatori veniva intensificata da un’origine che avevano in comune calciatori e il pubblico. Al contrario delle star di oggi, i primi rimanevano lavoratori nello stile di vita e nelle ambizioni» (pp. 77-78).
Sebbene il controllo del calcio professionistico non sia mai stato davvero nelle mani dei tifosi di estrazione popolare, si può dire che sia stato «attraverso il modo di guardare il football e di sostenere la propria squadra che le classi lavoratrici hanno “colonizzato” questa forma di intrattenimento e fatta propria» (p. 78). Prima della guerra il rapporto tra i tifosi delle aree popolari e il calcio, scrive Clarke, non aveva nulla a che fare con il rapporto attuale divenuto ormai “spettatoriale”; all’epoca il coinvolgimento era decisamente più profondo. «Andare allo stadio non significava semplicemente guardare la partita, bensì rappresentava un’attività sociale di gruppo […] La partita non era solo ciò che accadeva “laggiù”, ma l’intero campo era parte di un evento sociale. Il tifoso non era una figura neutrale, ma qualcuno – parte del gruppo – coinvolto nella creazione di un evento fuori dal gioco. Da un’altra ottica, il tifoso non era neutrale ma un «militante», un partigiano del club nel suo senso più ampio. Questo significava avere un rapporto sentimentale con la partita, viverla non come un confronto tra due squadre, ma tra la “propria” e quella avversaria, una posizione che non sollecitava una banale complicità, ma incentivava il diritto di critica e i commenti nei confronti della dirigenza e del club» (pp. 78-79). Si trattava di una vera e propria appropriazione dello sport da parte dei tifosi.
Nel dopoguerra, quando la società dell’intera Gran Bretagna è sembrata avviarsi verso un generale miglioramento delle condizioni di vita e le opportunità di intrattenimento si sono ampliate, il calcio ha intrapreso quella strada della spettacolarizzazione e del business che, negli anni Sessanta e Settanta, ha portato alla ristrutturazioni degli stadi, ai posti a sedere e alla creazione di una serie di servizi di intrattenimento come bar e ristoranti. Il tifoso si stava ormai trasformando in uno spettatore propenso ad assistere al gioco «solo se gli sono offerti degli standard di benessere che troverebbe altrove». Il nuovo tifoso divenuto spettatore si avviava così a non essere più parte integrante dell’evento.
Nel processo di spettacolarizzazione un ruolo centrale spetta indubbiamente alla televisione. «Il calcio in tv non è semplicemente calcio, ma parte dell’intrattenimento mediatico, e come tale è soggetto alle regole e alle pratiche della creazione televisiva di un evento. […] Prima della guerra, l’esperienza di guardare il calcio era collettiva e fisica, la folla era coinvolta nel gioco, nel fare propria l’esperienza dell’incontro. Per il nuovo spettatore, il calcio è un divertimento offerto – qualcosa che sta al di fuori, piuttosto che un fatto interno alla relazione tra ciò che accade sul campo e la folla. Il nuovo spettatore vive distaccato, è in grado di formulare giudizi critici, di scegliere tra questa o un’altra forma di svago. Per lo spettatore di calcio televisivo questo aspetto si intensifica» (pp. 86-87). Il fenomeno dell’hooliganismo, sostiene Clarke, «si palesa quando le forme tradizionali dell’assistere alle partite intercettano la professionalizzazione e la spettacolarizzazione del gioco» (p. 88).
Dunque, se la lettura ufficiale dell’hooliganismo tende a ricondurre il fenomeno a una condotta che ha poco a che fare col vedere il calcio, Clarke sostiene invece che il teppismo calcistico possa essere problematizzato soltanto comprendendolo come parte del modo di contemplare il calcio e la violenza tra tifosi avversari dovrebbe essere letta come parte di una volontà di partecipazione al gioco, una sorta di «estensione della lotta sul campo che include anche quella sugli spalti […] L’importanza attribuita alla durezza, come nella cultura calcistica anteguerra, è ancora trasferita nella vita» (p. 95), i tifosi più accesi intendono pertanto mettersi fisicamente alla prova come «difensori delle identità locali e dei campanilismi – è la loro squadra, il loro territorio a essere in gioco […] La violenza è solo la parte più visibile dei differenti stili di assistere a una partita – i giovani tifosi hanno conservato ed esteso le tradizioni del tifo collettivo e partecipativo proprio mentre il gioco concedeva delle modifiche per attirare i nuovi consumatori. […] Se il gioco è cambiato per diventare più spettacolare, così la partecipazione dei tifosi è cambiata da attiva, al gioco, ad attiva in favore dello spettacolo» (pp. 95-97). Insomma, se il consumatore si limita ad osservare, i tifosi, necessariamente al plurale, intendono prendere parte allo spettacolo.
Fanno parte del volume anche una Prefazione – Sottocultura ultras e generazione X – scritta da Andrea Ferreri in cui si insiste sull’importanza di contestualizzare il fenomeno ultras italiano e l’hooliganismo inglese sviluppati dalla generazione nata in Occidente tra il 1960 e il 1980, all’interno di quei cambiamenti che hanno segnato i decenni del conservatorismo reganiano e thatcheriano e una preziosa bibliografia ragionata curata da Luca Benvenga: 100 titoli sui giovani, le sottoculture spettacolari e la violenza nel calcio.
Altro materiale di Sport e dintorni



