di Gioacchino Toni
 Daniele Serapiglia, Uno sport per tutti. Storia sociale della pallavolo italiana (1918-1990), Clueb, Bologna, 2018, pp. 200, € 19,00
Daniele Serapiglia, Uno sport per tutti. Storia sociale della pallavolo italiana (1918-1990), Clueb, Bologna, 2018, pp. 200, € 19,00
Rifacendosi alle riflessioni elaborate da Pierre Bourdieu sul consumo di sport come rilevatore dei gusti e delle tendenze sociali, lo studioso di storia sociale dello sport Daniele Serapiglia – ricercatore presso l’Instituto de História Contemporânea dell’Universidade Nova de Lisboa e membro dell’European Committee for Sports History – nel suo Uno sport per tutti indaga le modalità con cui la pallavolo è divenuta una pratica di massa pur avendo un numero di spettatori inferiore a quello raggiunto da altri sport, cercando di «comprendere come il volley sia entrato in contatto con l’edonismo estetico e sentimentale dei praticanti durante un periodo di progressiva globalizzazione dei consumi, su cui [hanno] agito “l’innovazione tecnologica, l’espansione del mercato, l’intervento dello Stato”» (p. 14).
Per raggiungere tale scopo è stata costruita una narrazione dove la storia del volley fa da sfondo a un discorso più ampio legato all’evoluzione sociale e politica dello sport nel nostro paese. In questo senso si è scelto di applicare allo studio della pratica sportiva degli italiani la teoria di Colin Campbell, spogliata dalla sua dimensione religiosa, circa “la logica culturale della modernità”, in base alla quale quest’ultima nasce “dalla tensione tra sogno e realtà tra piacere e utilità” Pensiamo, infatti, che lo sport si incanali nell’immaginario collettivo nella stessa direzione. Come la moda, per Campbell lo sport “offre uno spazio ’onirico’ in cui compensare le delusioni del quotidiano”, proponendo modelli di vita “lontani dalla banalità”, che possono rispondere al bisogno di sognare ed evadere (p. 14).
Se le classi dirigenti hanno a lungo visto nello sport una valvola di sfogo sociale e uno strumento di disciplinamento, non di meno esso ha saputo ritagliarsi una dimensione onirica in grado di donare piacere a chi lo pratica e a chi ne è spettatore. Il ricorso da pare del potere allo sport come pratica di quella che Michel Foucault definisce governmentality non sempre ha conseguito risultati in linea con le aspettative: l’azione esercita dal potere, soprattutto nei paesi dittatoriali, sull’immaginario collettivo attraverso lo sport si è mostrata contraddittoria e la componente del sogno e della fuga da una realtà richiedente sacrifici ha finito col rendere frequentemente vane le finalità poste dai regimi. Insomma, la capacità dello sport di toccare le corde profonde della passione parrebbe derivare più da un bisogno dal basso che non da un’imposizione dall’alto.
È attorno alla tragedia della Grande guerra che la pallavolo, disciplina sportiva creata negli Stati Uniti dal reverendo William G. Morgan della Young Men’s Christian Association (YMCA) nel 1895, giunge in Italia per poi intraprendere quel lungo cammino che la vede diffondersi nell’ambito del tempo libero delle classi lavoratrici e nella scuola, trasformarsi per qualche tempo persino terreno di scontro politico e divenire oggi lo sport più praticato nel paese dopo il calcio.
La prima parte del volume tratta la pallavolo in Italia tra la fine degli anni Dieci e la metà degli anni Quaranta. Sono le truppe statunitensi che nel corso della Prima guerra mondiale fanno conoscere il volley a un esercito italiano che prendere a modello le pratiche sportive in uso tra i militari americani per la ricreazione, la preparazione atletica e per sfogare le frustrazioni del quotidiano dei soldati.
Anche in Italia la paura della sconfitta conseguente alla disfatta di Caporetto aveva fatto comprendere che l’attività fisica, oltre alla preparazione del corpo del soldato, poteva contribuire ad alleviarne i traumi della psiche attraverso il suo aspetto ludico. Per raggiungere questo scopo, però, dovevano essere riformati i programmi relativi all’educazione fisica, fino ad allora basati sulla ginnastica. Il 1° febbraio del 1918, quando il Comando supremo diede vita al Servizio P, incaricato della propaganda bellica al fronte e nelle retrovie, venne proposta ai militari la pratica degli sport di squadra. Favorirono questa scelta sia il contatto con le truppe anglo-franco-americane, che già impiegavano tali discipline in ambito ricreativo, sia, soprattutto, la collaborazione delle Case del soldato con l’YMCA, nell’ambito della quale gli sport di squadra si erano imposti con una certa rapidità (p. 30).
Se è attorno alle trincee della Grande guerra che la pallavolo fa capolino in Italia è però con il fascismo che diviene una pratica di massa. In generale il regime ricorre allo sport come strumento di creazione dell’uomo nuovo fascista e, più prosaicamente, di controllo del tempo libero. Inserita nell’ambito delle attività dell’Opera nazionale dopolavoro, la pallavolo ha modo di svilupparsi come sport amatoriale e probabilmente è proprio per questo che non riesce mai ad entrare davvero in sintonia con il regime che preferisce sport come il pugilato e il calcio considerati “più virili” è più funzionali alla politica di potenza da “esportare” a livello internazionale. «Sullo sfondo di questo affresco c’è la società italiana degli anni Trenta con i suoi principi, ma anche con le sue contraddizioni che il regime fascista cercò di governare. La nascita del divismo sportivo e la conseguente pubblicizzazione del benessere di alcuni atleti andavano in controtendenza rispetto alle continue richieste di frugalità e sacrificio lanciate dal governo Mussolini. La nuova concezione del corpo, inoltre, sembrava mutuata più dal cinema americano che dalla retorica estetica del regime» (p. 17). In generale gli sport di squadra
costituivano una perfetta metafora del fascismo. La collaborazione in campo, i ruoli ben definiti dei singoli atleti, l’inflessibile gerarchia (le strategie di gioco erano dettate dal capitano e dall’allenatore) e il dover rispondere a un rigido regolamento facevano delle discipline di squadra un importante mezzo per educare i praticanti alla vita quotidiana imposta dalla dittatura. […] Gli sport di squadra erano però importanti tanto per chi li praticava quanto per il pubblico che, disposto negli stadi in base alla gerarchia, al genere e all’appartenenza sociale, diveniva spettatore e attore di una liturgia collettiva (pp. 39-40).
Se la Prima guerra mondiale, con gli uomini impegnati al fronte, apre improvvisamente le porte dei luoghi di lavoro a molte donne, il regime mussoliniano tende ben presto a soffocare il nuovo ruolo sociale femminile riproponendo un «virilismo di anteguerra». Nonostante ciò lo sport consente, soprattutto alle donne delle classi sociali più agiate, la possibilità di ritagliarsi un ruolo nella sfera pubblica. Se la pratica pallavolista, forse perché meno cruenta rispetto ad altre pratiche sportive basate sul contatto fisico, sembra rappresentare uno sport più attraente per le donne del periodo, è solo nel secondo dopoguerra che si diffonde la passione per tale disciplina in ambito femminile.
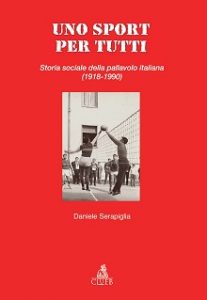 La parte centrale del volume è incentrata sulla nascita della Federazione italiana pallavolo, sul riconoscimento del volley come sport agonistico e sulla sua diffusione nelle scuole nel periodo compreso tra la Liberazione e la fine di quegli anni Sessanta contraddistinti da una trasformazione epocale dei costumi e del tempo libero. Oltre a ricostruire la lunga e tortuosa strada che porta la pallavolo a far parte delle discipline agonistiche aderenti al Comitato olimpico, nel saggio viene posto l’accento su come, al contempo, il volley non abbia mai perso la sua caratteristica di sport amatoriale, tanto da ritagliarsi un ruolo importante all’interno delle strutture del Centro sportivo italiano (Csi) e dell’Unione italiana sport popolare (Uisp) che riverbereranno all’interno dello sport il conflitto politico tra mondo cattolico e sinistra che attraversa il paese.
La parte centrale del volume è incentrata sulla nascita della Federazione italiana pallavolo, sul riconoscimento del volley come sport agonistico e sulla sua diffusione nelle scuole nel periodo compreso tra la Liberazione e la fine di quegli anni Sessanta contraddistinti da una trasformazione epocale dei costumi e del tempo libero. Oltre a ricostruire la lunga e tortuosa strada che porta la pallavolo a far parte delle discipline agonistiche aderenti al Comitato olimpico, nel saggio viene posto l’accento su come, al contempo, il volley non abbia mai perso la sua caratteristica di sport amatoriale, tanto da ritagliarsi un ruolo importante all’interno delle strutture del Centro sportivo italiano (Csi) e dell’Unione italiana sport popolare (Uisp) che riverbereranno all’interno dello sport il conflitto politico tra mondo cattolico e sinistra che attraversa il paese.
Sin dall’immediato dopoguerra in Italia, nel fronte comunista, non senza qualche continuità con il periodo fascista, si vede nello sport uno strumento utile alla creazione di “individui nuovi”, capaci di “difendere” e “costruire” la patria. Non è un caso se le organizzazioni comuniste insistono nell’elogiare l’impegno sovietico volto a costruire un sistema sportivo diffuso. Più in generale
attraverso gli enti di propaganda i vari partiti cercavano di sfruttare la dimensione educativa dello sport per la creazione dell’uomo nuovo. La Chiesa e la Democrazia cristiana volevano quest’ultimo legato alla tradizione cattolica, il fronte social-comunista lo voleva invece costruito sul prototipo dell’atleta sovietico, mentre il Movimento sociale lo voleva ancorato alla tradizione fascista. Nel mirino degli enti c’erano perciò i giovani, i quali, attraverso le attività ludiche svolte nelle parrocchie, nelle case del popolo o in strutture similari, durante le ore pomeridiane potevano assimilare il discorso ideologico sia che fosse frutto della religione tradizionale, che di una religione civile come poteva essere stata quella fascista o come poteva diventare quella socialista. Una tale propensione all’utilizzo dello sport da parte delle forze politiche e religiose ci porta a ridimensionare le teorie di quanti pensano che quest’ultimo sia stato utilizzato dai governanti come anestetico della società piuttosto che come motore per la creazione del consenso. […] Gli sport al contrario, come durante il fascismo, potevano svolgere proprio una funzione politica e ciò era maggiormente visibile nel contesto di una società democratica. A sostegno di questa tesi è da sottolineare che il legame tra sport e politica era più forte dove più forte era la lotta tra i partiti. Non è un caso che il Csi e la Uisp si siano sviluppate soprattutto nelle regioni più calde da questo punto di vista (p. 76).
La crescita e la diffusione della pallavolo italiana risulta sicuramente debitrice della rivalità tra questi enti e tra i rispettivi modelli ideologici e politici di riferimento, rivalità che finisce col palesarsi anche negli scontri tra le squadre di volley.
Un altro snodo importante su cui si sofferma lo studioso è rappresentato dagli anni Sessanta quando, tra i grandi cambiamenti che caratterizzano la società italiana dell’epoca, si assiste a una profonda trasformazione del rapporto tra sport, pubblico e praticanti, che permette a un numero crescente di italiani di potersi permettere di assistere agli eventi sportivi a pagamento e di praticare direttamente diverse discipline.
Nell’ultima parte del volume Serapiglia si occupa della pallavolo nazionale in quella che è considerata la sua “epoca d’oro”, cioè nel periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta, quando sia a livello di nazionale (maschile) che di club (maschili e femminili) le squadre italiane mietono successi internazionali e le partite iniziano ad avere una copertura mediatica, soprattutto televisiva, senza precedenti.
Per la pallavolo l’incontro con la televisione sarebbe stato fondamentale, poiché mise in connessione questo sport con la cultura d’intrattenimento di massa. Essa fin dalla sua nascita aveva cambiato il modo stesso di concepire lo sport, attribuendogli diversi significati tra cui “il senso della nazione, di classe, del ruolo della donna e dell’uomo”, ma, soprattutto, avrebbe reso gli eventi sportivi uno show e gli atleti dei personaggi mediatici. Alla vigilia degli anni Ottanta tali peculiarità erano essenziali per la crescita di uno sport, visto che l’attenzione mediatica per una disciplina e per i suoi attori avrebbe convogliato su di essa l’attenzione non solo del pubblico, ma anche degli sponsor, che avrebbero finanziato lo sport in questione rendendolo maggiormente appetibile per le emittenti televisive, che a loro volta avrebbero pagato per riprendere le varie manifestazioni. In questo senso, i mondiali del 1978 rappresentarono per la pallavolo italiana, ma anche per quella mondiale, un primo e decisivo passo verso il suo ingresso tra gli sport mediatici (p. 137).
Nel volume viene dedicato spazio anche all’ascesa del volley femminile che procede di pari passo con il nuovo ruolo della donna e con il mutamento dei costumi in un’Italia ancora decisamente retrograda dal punto di vista culturale: «l’avvicinamento delle donne allo sport in generale e alla pallavolo in particolare fu la conseguenza di un processo di emancipazione di queste ultime rispetto al proprio contesto familiare, più avanzato nelle regioni centrosettentrionali che in quelle centromeridionali» (p. 19). Tra i motivi che spiegano la maggiore diffusione della pallavolo nelle regioni centro-settentrionali, alle ragioni culturali debbono comunque essere aggiunte anche le importanti differenze che contraddistinguo il centro-nord e il centro-sud a proposito di disponibilità di impianti e risorse per la pratica sportiva. In un intreccio tra nobili aspirazioni a una più diffusa partecipazione popolare e scopi meramente propagandistici indirizzati alla “fidelizzazione elettorale”, sembra di poter dire che le regioni italiane in cui lo scontro politico nel dopoguerra è stato più acceso hanno più facilmente lasciato in eredità mentalità e strutture utili alla pratica sportiva sia agonistica che dilettantistica della pallavolo.
Il libro di Serapiglia si colloca nell’ambito degli studi storici e sociologici sullo sport che contano su una lunga tradizione in altri paesi, in particolare nell’area anglosassone, e si stanno consolidando anche in Italia. Il saggio, oltre a ricostruire in modo rigoroso la storia della pallavolo italiana, ha il merito di offrire, attraverso uno sguardo originale, analisi e spunti di riflessione sul contesto sociale, politico e culturale in cui essa si è manifestata nel corso del Novecento. Come scrive Juan Antonio Simón Sanjurjo, docente presso l’Universidad Europea de Madrid, nella Prefazione al volume, Uno sport per tutti
non è catalogabile come un semplice libro di sport, probabilmente neppure come una storia della pallavolo. È, senza dubbio, un libro di storia, di storia con la “S” maiuscola, di analisi e ricerca sociale che intende mostrarci, tramite lo studio della pallavolo, un’immagine dell’Italia che fino a pochi anni fa il mondo accademico si ostinava a non voler riconoscere. In un paese in cui lo sport è dagli anni Venti un fenomeno sociale, nelle facoltà di storia si continuava a considerare temi quali lo sport, il cinema o l’ozio in generale come ambiti ancillari, anche da parte degli stessi colleghi che – in conversazioni informali – non esitavano a mostrare una smodata passione per la propria squadra di calcio o per alcuni grandi giocatori. […] L’importanza della pallavolo in questo paese è indubbia, ma il significato di ricerche come questa non si estrinseca tanto nello sport in se stesso, quanto in ciò che la sua pratica ci può rivelare in relazione al quadro sociale nel quale si è inserito durante il secolo passato (p. 9).



