di Giacomo Marchetti
 Quella che segue è un’intervista a Silvia Moresi, traduttrice e curatrice di Undici pianeti, scritto da Mahmud Darwish, uno dei più importanti poeti del Novecento, nel 1992.
Quella che segue è un’intervista a Silvia Moresi, traduttrice e curatrice di Undici pianeti, scritto da Mahmud Darwish, uno dei più importanti poeti del Novecento, nel 1992.
Un lavoro, forse, tra i più completi del poeta palestinese, legato a una data chiave per la storia araba e mondiale, il 1492 anno della scoperta dell’America e della definitiva espulsione di musulmani ed ebrei dall’Andalusia, pubblicato quest’anno da Jouvence.
L’ultimo componimento di “Undici Pianeti”, “Un cavallo per lo straniero (a un poeta iracheno)” è per certi versi una poesia profetica, perché parlando della “prima guerra del Golfo”, tratta di una delle tappe più significative della fine del mondo bipolare e dell’avvio di tendenza alla guerra che tutt’ora continua permane. La poesia sembra “annunciare” ciò che sarà una sequenza di fatti tragici che continuerà, dopo questa prima tappa, con l’aggressione e l’invasione a guida nord-americana dell’Iraq nel 2003 e più recentemente con il periodo di massima estensione dell’ISIS (o Daesh).
La guerra, così come l’esilio, e il rapporto con un passato che accompagna costantemente il flusso storico sono fortemente presenti qui come in tutta la raccolta, e nell’intera opera.
C’è un verso che colpisce particolarmente tra gli altri: Amico mio siamo mai riusciti a distinguere tra vista e visione? In cui è rinchiuso il significato della poesia, o meglio di questa “alterazione percettiva” che è connaturata all’utopia poetica, e che sembra stagliarsi sopra le disgrazie belliche. Puoi parlarci di come “questa” sindrome caratterizza l’opera di Darwish, e si ritrovi in Undici Pianeti?
Non è un caso che Un cavallo per lo straniero (a un poeta iracheno) sia il componimento che chiude l’opera; era il 1992 quando Darwish compose Undici Pianeti, e l’Iraq, appena devastato dalla prima guerra del Golfo, rappresentava il nuovo collasso della Storia araba, iniziato in Andalusia, ma soprattutto l’ennesimo e ultimo cimitero dell’umano.
L’intera raccolta è caratterizzata da un flusso storico circolare, tragedie e devastazioni si ripetono in spazi e tempi lontani, ma i protagonisti cambiano, le vittime diventano aggressori e viceversa, sono la distruzione e la morte ad essere identiche sempre e ovunque. È in questo senso, forse, che quest’opera di Darwish può dirsi profetica e ammonitrice. Il poeta palestinese è riuscito a fare in modo che, ad esempio, leggendo dell’esilio di Arabi ed Ebrei dall’Andalusia, o del genocidio dei nativi americani, ritrovassimo tracce di una tragedia, quella palestinese, avvenuta quasi cinquecento anni più tardi, e che, leggendo “dell’Iraq assassinato”, ci venissero in mente tutte le altre guerre e brutalità che in questi anni si sono succedute e moltiplicate, e alle quali Darwish, morto nel 2008, non ha nemmeno assistito. Il poeta palestinese racconta così non una tragedia specifica, ma la tragedia umana che sembra non aver fine, e in cui tutti siamo coinvolti. Come spezzare il cerchio di questa lunga sequenza di morte? È qui che entra in scena la poesia, un luogo utopico. Darwish sapeva bene che la poesia non è in grado cambiare il mondo, ma credeva che, forse, raccontando le cose semplici, i sentimenti, e rivolgendosi all’identità umana e non a quella nazionale e ideologica, la poesia potesse avvicinare le persone, svuotando di significato una parola come “straniero”, concetto purtroppo molto attuale nell’Italia di oggi.
La poesia di Darwish è “casa” e “patria” per milioni di esuli palestinesi, è tomba per milioni di vittime, è lapide che racconta di queste vittime dimenticate dalla Storia, è rifugio dalle violenze e dalla disumanizzazione. La poesia non è una pavida fuga dal mondo, ma il luogo nel quale ristabilire le priorità, io stessa, di frequente, mi trovo a dover chiedere asilo alla poesia quando sento che la realtà, inevitabilmente, sta corrodendo la mia umanità.
La battaglia contro l’oblio è uno delle finalità poetiche di Mahmud Darwish, come di tutto il Movimento di Liberazione Palestinese, un antidoto a ciò che un giorno disse Golda Meyer a proposito della Catastrofe palestinese (Nabka) del 1948: «i vecchi moriranno, i giovani dimenticheranno». Darwish non si presta a nessuna operazione di “invenzione della tradizione”, ma rivisita il passato, intreccia le storie gemellari di più popoli, con la consapevolezza che la narrazione è l’antidoto alla rimozione per esempio della questione del “diritto al ritorno profughi”, questione per cui tra l’altro romperà con l’OLP in seguito ai contenuti degli Accordi di Oslo che escludevano questa storica rivendicazione.
In ultima sera di questa terra, l’Andalusia è più una metafora a cui potrebbero adattarsi vari contesti, quasi la condizione umana stessa, e sembra essere la prima e propria vera “cesura” della storia araba, l’inizio di un ciclo verso cui indirizzare la propria attenzione. Come interpreti i versi finali del componimento: Dov’era l’Andalusia? Qui o lì… Sulla terra… o in una poesia? Che apre la raccolta e contribuiscono a dare la cifra di tutti gli altri componimenti.
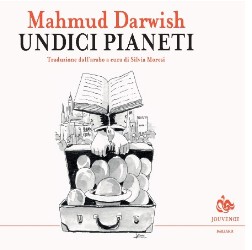 La geografia e la Storia del popolo palestinese sono state distrutte, materialmente dalla rampante colonizzazione israeliana, che prosegue ancora oggi con la costruzione di nuovi insediamenti, ma anche dalla retorica del movimento sionista che, attraverso un sistema ben progettato di narrazione distorta, negazione e interdizione della realtà, ha tentato di rendere “invisibili” i palestinesi, degli “assenti”, dei fantasmi. La Storia la scrivono i vincitori, la letteratura, invece, è spesso il “megafono” delle vittime e degli sconfitti. Tutta l’opera di Mahmud Darwish, e in particolare Undici Pianeti, rappresenta, assieme al resto della letteratura palestinese, una “resistenza culturale”, la resistenza di cui questo popolo ha più bisogno per non soccombere ad un tragico “memoricidio”. Soprattutto in Una pietra cananea nel Mar Morto e in Sceglieremo Sofocle, Darwish scava nel passato del popolo palestinese per riappropriarsene, e riporta alla luce quei “nomi” che furono cancellati attraverso il processo di riebraizzazione della terra. La realtà fu resa irriconoscibile per i palestinesi che diventarono così, per un fantasioso capovolgimento della realtà, una comunità che “non era più al suo posto”.
La geografia e la Storia del popolo palestinese sono state distrutte, materialmente dalla rampante colonizzazione israeliana, che prosegue ancora oggi con la costruzione di nuovi insediamenti, ma anche dalla retorica del movimento sionista che, attraverso un sistema ben progettato di narrazione distorta, negazione e interdizione della realtà, ha tentato di rendere “invisibili” i palestinesi, degli “assenti”, dei fantasmi. La Storia la scrivono i vincitori, la letteratura, invece, è spesso il “megafono” delle vittime e degli sconfitti. Tutta l’opera di Mahmud Darwish, e in particolare Undici Pianeti, rappresenta, assieme al resto della letteratura palestinese, una “resistenza culturale”, la resistenza di cui questo popolo ha più bisogno per non soccombere ad un tragico “memoricidio”. Soprattutto in Una pietra cananea nel Mar Morto e in Sceglieremo Sofocle, Darwish scava nel passato del popolo palestinese per riappropriarsene, e riporta alla luce quei “nomi” che furono cancellati attraverso il processo di riebraizzazione della terra. La realtà fu resa irriconoscibile per i palestinesi che diventarono così, per un fantasioso capovolgimento della realtà, una comunità che “non era più al suo posto”.
La Palestina era già stata “scritta” prima del sionismo, così affermava il grande poeta palestinese; Israele, da settant’anni, porta avanti un violento progetto di “sovrascrittura”, ma la Palestina è sempre lì con le sue pietre, i suoi ulivi e le sue storie, basta scavare un po’, gli scrittori e i poeti palestinesi la riporteranno sempre alla luce.
Darwish non risparmiò mai critiche alla dirigenza dell’OLP, soprattutto dopo la beffa degli Accordi di Oslo, e non credo che oggi sarebbe più clemente, anzi. In una situazione di totale smarrimento politico e offuscamento di obiettivi, come quella che si vive oggi in Palestina, poter ascoltare ancora la voce e il pensiero di un intellettuale come Darwish sarebbe stato essenziale; ma la sua morte è stata un’enorme perdita per il mondo intero, popolato ultimamente da troppi ciarlatani.
I versi di Ultima sera su questa terra che tu citi, si riferiscono, invece, a mio parere, a quell’eden perduto che fu l’Andalusia, ma anche la Palestina prima del sionismo, cioè il luogo della coesistenza pacifica tra Arabi ed Ebrei, che oggi, purtroppo, sembra non essere mai esistito nel mondo reale, ma solo in qualche poesia.
La cacciata di Arabi ed Ebrei dalla penisola iberica è una tragedia che accomuna il destino di due popoli di un luogo in cui, come nella Palestina Storica, la convivenza era uno stato di fatto e non un anelito, e di cui la Storia non può essere cancellata: non ero un narcisista, ma difendevo la mia immagine nello specchio è uno dei versi d’apertura di Un giorno siederò sul marciapiede. La matrice comune della Storia è difesa e rivendicata come un terreno di conflitto rispetto ad una ricostruzione che vuole “eliminare” la presenza d’altro, legittimando la propria politica di potenza. Ma oltre il fare riemergere la storia è nell’“erranza”, il perdersi nell’altro sembra esserci che sembra celarsi la possibilità di trovarsi: Camminavo verso il me stesso racchiuso negli altri, ed eccomi qui, smarrisco me stesso e gli altri, scrive in Chi sono io… Dopo la notte della straniera. Questa è la fonte di una identità in divenire in dialettica con l’altro che sembra essere l’unica soluzione per l’umanità sofferente, non solo per il popolo palestinese. Puoi parlare di come questa identità non statica e ripiegata su sé stessa viene sviluppata nel corso della raccolta?
Sul finire del 1800, l’identità palestinese si stava formando mescolando le sue diverse appartenenze: araba, ebraica, islamica, cristiana, ottomana, familiare, tribale etc. L’arrivo del sionismo bloccò questo naturale processo, negando l’esistenza della Palestina e del suo popolo, che fu poi frammentato dopo la nascita dello Stato di Israele.
Mahmud Darwish sapeva bene che sulla sua terra erano passate innumerevoli culture, e rivendicava il diritto di potersi identificare con tutte le voci risuonate in Palestina; ma l’altro, il sionismo, Israele, condannano ancora oggi i palestinesi ad essere degli “stranieri”, rivendicando il “monopolio dell’autenticità”, e proclamandosi come unici e legittimi “padroni” di quella terra.
Al contrario, in tutta la raccolta, Mahmud Darwish, scavando nella memoria del suo popolo, non ha alcun timore di “incontrare” tracce dell’altro: Adesso io ti vedo nel passato così come sei arrivato, sei tu a non vedermi, scriverà in Una pietra cananea nel Mar Morto.
Il punto focale di Undici Pianeti, infatti, è proprio l’importanza di sapersi percepire sempre come “stranieri”, una facoltà capace di creare identità in divenire, fluide ed accoglienti, opposte alle identità statiche e separatiste degli Stati etnici, come Israele: Straniero, è finalmente giunto il momento di incontrarci da stranieri nella stessa epoca? (Penultimo discorso del «pellerossa» all’uomo bianco).
La lotta del popolo palestinese per riconquistare la “patria”, per riaffermare la propria esistenza nella Storia, non ha creato di riflesso, come spesso accade, una identità chiusa e immobile, e questo risulta evidente in letteratura, dove alcuni scrittori arrivano molto vicini al concetto di post-nazionale.
Nel verso che tu citi c’è la parola “specchio”, una parola presente in quasi tutti i componimenti, e che si lega alla questione identitaria. L’atto di specchiarsi e riconoscersi nell’altro può essere spesso un atto positivo, ma, in Undici Pianeti, diventa il modo per appropriarsi dell’identità altrui, e poi negarla. Il sionismo (come molti movimenti coloniali), infatti, ha tentato, e tenta ancora oggi, attraverso l’istruzione, di proporre una improbabile continuità storica tra il popolo israeliano e quella terra, e lo fa “rubando” parti di cultura palestinese: Storia, tradizioni, gastronomia, abbigliamento. Se pur di recente immigrazione dall’Europa o dall’America, l’israeliano deve apparire come un nativo di quella terra per potersi sostituire al “palestinese reale” e farlo così “scomparire”.
L’Olocausto dei Nativi Americani coincide con la “scoperta dell’America”, che è uno dei temi portanti della Raccolta, il componimento di Darwish del ’92 prende spunto anche da questo. In particolare in Penultimo discorso del “Pellerossa” all’uomo bianco, il poeta riprende e reinterpreta una famosa lettera che “Seattle”, capo della Nazione Duwamish, aveva scritto e inviato al presidente americano Franklin Pierce nel 1854. Questa missiva è una messa a nudo della concezione che della Terra avevano (ed hanno) le elités nord-americane ed un atto di denuncia di ciò che sarà l’”ecocidio”, e che il poeta fa arrivare fino ad oggi in un continuum di un progresso regressivo e distopico dove: dai nostri cimiteri aprirete strade che portano ai satelliti. Come fa dialogare queste tragedie e resistenze gemellari Darwish?
Penultimo discorso del «pellerossa» all’uomo bianco è il componimento in cui, a mio parere, sono forse più evidenti i rimandi alla colonizzazione palestinese e alla retorica sionista, ma i versi raccontano anche benissimo il genocidio dei nativi americani. Questa perfetta sovrapposizione di mondi è frutto sicuramente, e in buona parte, della eccezionalità di Darwish come poeta, che riesce a narrare più storie contemporaneamente, ma anche della corrispondenza delle pratiche coloniali nel tempo e nello spazio. Sfruttamento brutale del territorio, distruzione nel mondo precedente, disumanizzazione e conseguente sterminio dei nativi, che, nel migliore dei casi, vengono ridotti a manodopera, sono i punti saldi di tutte le imprese di tipo coloniale.
Ritenere e descrivere gli altri come inferiori, ad uno stadio di sviluppo ancora infantile, e pensare alle società non industriali, ma più legate alla terra, come comunità da “civilizzare” o da far scomparire, è il leitmotiv di ogni movimento coloniale, e non solo di quello delle elités nord-americane, e penso, ad esempio, ai territori del Sud America o all’Algeria, per fare due esempi temporalmente e spazialmente distanti.
Darwish, con questi versi, sembra volerci dare un avvertimento, esattamente come fece Primo Levi: “Meditate che questo è stato”, ma purtroppo è ancora e ancora sarà, se non riuscirà a spezzare questo mortifero cerchio.
Un’ultima domanda, riguarda l’intreccio tra la storia personale, autobiografica, e la Storia in senso generale, in cui condizione individuale (quella del poeta), specifica (quella del popolo palestinese), e universale (quella dell’essere umano) si intrecciano, si sovrappongono e dialogano all’interno di due polarità: la guerra e l’amore sostanzialmente, in un linguaggio ricco di metafore, denso di simboli e di rimandi storici. Leggendo la tua traduzione uno riesce ad immaginare a stento lo sforzo intellettuale nel rendere intellegibile la poesia di Darwish, e la passione da “decifratore di sciarade” che serve. Quali difficoltà hai incontrato in questo lavoro di “scavo” per carpire il significato delle sue poesie e per renderlo al pubblico italiano?
Il lavoro di studio e, successivamente, di traduzione di questo testo è stato molto lungo, ogni volta che pensavo di aver terminato, mi rendevo conto che c’era ancora da “scavare”, c’erano nuovi racconti da portare alla luce. Darwish, in Undici Pianeti più che altrove, gioca con la lingua araba, e in una sola poesia, in un solo verso ma anche con una sola parola, riesce a far dialogare mondi, a metterli in connessione. La maggiore difficoltà è stata proprio la scelta delle parole, parole che riuscissero a raccontare di una storia, senza “nascondere” le altre storie.
Poter tradurre i versi di Mahmud Darwish è stato un onere, ma anche un grande onore, vista la grandezza di questo poeta. Io forse ho sentito maggiormente il “peso” di questo lavoro perché ritengo il pensiero di Darwish una parte importante della mia formazione culturale. La sua coerenza intellettuale e personale, così poco di moda oggi, è quella con cui io provo a confrontarmi, e i suoi versi sono la lente di ingrandimento con cui guardo il mondo. Anche per questo spero di aver fatto un buon lavoro.



