di Marc Tibaldi
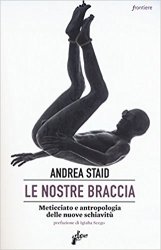 Andrea Staid, Le nostre braccia. Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù, Milieu edizioni, 2018, pp. 169, € 14,9o.
Andrea Staid, Le nostre braccia. Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù, Milieu edizioni, 2018, pp. 169, € 14,9o.
Il concetto di invenzione della tradizione, e di conseguenza il mito dell’indentità nazionale o etnica, è stato indagato, nel libro che porta lo stesso titolo, da Eric Hobsbawm e Terence Ranger. Le tradizioni inventate sono spesso l’elaborazione di una risposta a tempi di crisi, a epoche di rapido cambiamento sociale, alla necessità di fronteggiare nuove situazioni; il richiamo al passato serve per acquistare legittimità. Secondo la definizione dei due autori “per ‘tradizione inventata’ si intende un insieme di pratiche dotate di una natura rituale o simbolica, che si propongono di inculcare determinati valori nei quali è implicita la continuità col passato. Nella mutevole situazione economica attuale e nella conseguente ridefinizione socio-politica, “tradizione” e “identità” sono parole-bandiera per partiti e movimenti venuti alla ribalta negli ultimi anni. E quindi arriva con tempismo perfetto Le nostre braccia. Meticciato e antropologia delle nuove schiavitù di Andrea Staid, in un momento politico caratterizzato di sovranismi e fronti identitari, dal rigurgito di razzismi espliciti o camuffati, dipanando un groviglio di tematiche non facile da districare.
Partendo dalle analisi di Francesco Remotti, per cui l’identità è un modo distorto di guardare al passato che impedisce di pensare il futuro, Staid distingue tra comunità immaginaria e comunità reale: la prima ha scarsi legami con la storia, è il frutto del nostro pensiero. Una rappresentazione. Un’invenzione. Infatti l’identità non è un oggetto storico, ma un oggetto mentale, un parto della mente, che può avere conseguenze storiche reali. Come sostengono François Laplantine e Alexis Nouss, l’identità è presieduta, dalla logica binaria del principio di non contraddizione e del terzo escluso, e come tale pone le basi per una cultura fondata sulla logica dell’essere, contrapposta a quella del divenire: è ostile al ‘pensiero del fuori’ (Foucault, Deleuze) e l’unico rapporto possibile di questa logica identitaria – a livello individuale e sociale – con l’altro da sé non può che essere quello a cui mette capo ogni fanatismo, che proprio da tale logica, si alimenta: la violenza della guerra.
Il concetto di identità e le sue ossessioni hanno ricevuto negli ultimi decenni diversi colpi demolitori, dagli studi Luigi Luca Cavalli-Sforza, che ci hanno permesso di ritrovare nell’attuale patrimonio genetico dell’uomo i segni lasciati dai grandi movimenti migratori del passato e delle società transculturali, azzerando definitivamente ogni idea di razzismo biologico; alle teorie di Judith Butler, che pervengono a una messa in discussione e critica radicale dell’identità sessuale, sostenendo che la costruzione del soggetto sessuato, desiderante, non sia una scelta, ma una conseguenza del discorso disciplinare; alle proposte di Anna Camaiti Hostert, per cui il passing è l’abbandono dei punti di vista obbligati da cui si è presa la parola e si è osservato il mondo fino ad ora; a Sandro Mezzadra per cui “la condizione postcoloniale” non è solo quella vissuta dai Paesi che hanno subito la colonizzazione, ma la condizione planetaria che rimette in discussione culture, confini e forme statuali, da cui possono venire indicazioni per una teoria critica della politica all’altezza delle sfide del mondo globale contemporaneo.
“Nel ‘meticcio’, nel pensiero transculturale, ogni differenza non allude a privilegi né ad alcuna discriminazione. La transcultura esige che gli uomini, migranti o meno, godano delle medesime ‘universali’ possibilità e scelgano privi di vincoli comunitari, dove, come e quando vivere. Ogni persona ha il diritto di essere valorizzata nella sua unicità e irrepetibilità, nella sua continua trasformazione, nella sua continua negazione di purezza originaria”, sostiene l’autore, confermando la vivace e fruttuosa commistione che caratterizza anche altri suoi studi (I dannati della metropoli, Abitare illegale, sempre editi da Milieu), dove l’antropologia critica viene mixata al pensiero libertario, vivificando e innovando il sentiero percorso da Pierre Clastres nei suoi libri, tra cui il fondamentale La società contro lo stato.
“Un mondo aperto, senza muri e pregiudizi, pronto al mescolamento culturale per un divenire transnazionale, un’’ecumene globale’ con al suo interno una miriade di culture differenti pronte al cambiamento, all’ascolto e all’incontro”, continua Staid. E se in Logiche meticce Jean-Loup Amselle, critica la “ragione antropologica”, non complice ma figlia di un’ideologia coloniale che tendeva a separare i soggetti dal loro contesto e a classificare, distribuendo così, grazie al rapporto di forza favorevole, attributi e definizioni destinati inevitabilmente a diventare categorie politiche, Staid rivendica alla sua antropologia lo statuto di sapere di frontiera che l’avvicina “a una delle priorità del pensiero libertario ovvero quella della negazione dei confini, della convinzione che le frontiere sono fatte per essere scavalcate”.
Quello di Staid non è solo un libro di ricche riflessioni teoriche e politiche, ma un’utile bussola per orientarsi nel reale proprio perché parte dalla concretezza di una solida inchiesta che si basa su interviste a molti migranti, sulla loro vita e sullo sfruttamento subito, e sull’attento utilizzo dei dati riportati da Renato Curcio in I dannati del lavoro. Anche per questa sua caratteristica il testo di Staid è “necessario” in un mondo “confuso e lasciato in balia dell’odio da chi non sa come risolvere i dilemmi economici e lavorativi”, come scrive Igiaba Scego nell’introduzione. Le postfazioni di Andrea Perin e Bruno Barba articolano ulteriormente i concetti di transculturalità e meticciato tra lavoro vivo e nuda vita.



