di Sandro Moiso
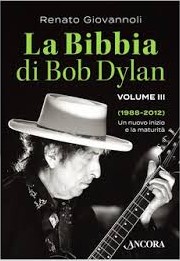 Renato Giovannoli, La Bibbia di Bob Dylan. Volume III (1988 – 2012) Un nuovo inizio e la maturità, Ancora Editrice 2018, pp. 424, € 26,00
Renato Giovannoli, La Bibbia di Bob Dylan. Volume III (1988 – 2012) Un nuovo inizio e la maturità, Ancora Editrice 2018, pp. 424, € 26,00
Come già precedentemente annunciato, è giunta al termine la monumentale opera dedicata da Renato Giovannoli ai rapporti tra l’opera di Dylan, la Bibbia e l’uso che di questa si è fatto nella canzone popolare americana. Il terzo tomo appena pubblicato conclude degnamente l’opera, fornendo al lettore indici analitici riguardanti i testi, le canzoni, gli autori e i passi della Bibbia citati nei tre volumi della stessa. Tali indici, soltanto per darne un’idea, occupano più di cento pagine di quest’ultimo volume, su un totale di 1132 che costituiscono nel suo complesso l’intera ricerca.
Le altre 316 pagine del testo in questione sono dedicate alla musica prodotta da Dylan negli anni compresi tra il 1988 e il 2012. Si tratta quindi del periodo in cui sono stati registrati i suoi ultimi dischi composti da brani originali prima dei tre album dedicati alla canzoni interpretate da Frank Sinatra oppure tratte dal grande American Songbook di interpreti come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sara Vaughn o Ray Charles.
Tale scelta è pienamente giustificata dalla ricerca tematica svolta, poiché non solo gli ultimi tre presentano canzoni più legate al mainstream musicale americano più che all’ambito folk e popular, ma anche perché in tale ambito è più difficile rintracciare eventuali richiami, vicini o lontani, alla Bibbia e alle sue parole.
Senza tornare a quanto già detto nella precedente recensione dei primi due volumi dell’opera, (qui) si rende ancora necessaria l’analisi di quali siano le motivazioni “poetiche” che hanno spinto Dylan e una gran parte di folksinger americani ad utilizzare le parole e i riferimenti all’Antico e al Nuovo Testamento nelle loro canzoni. Escludendo però l’indagine dalle personali convinzioni religiose che, soprattutto nel caso di Dylan ma anche in quello di molti altri (ad esempio Kris Kristofferson), possono apparire spesso altalenanti oppure soltanto occasionali.
Analizzare, d’altra parte, l’autenticità o meno della conversione religiosa dei singoli interpreti potrebbe costituire un lavoro non soltanto lungo e complesso ma, probabilmente, anche fuorviante e tutto sommato poco scientifico considerato che ogni interpretazione delle convinzioni religiose di qualunque individuo, famoso o meno che sia, finisce inevitabilmente con l’intersecare le convinzioni religiose o laiche di chi interpreta. Analisi che, comunque e nel migliore dei casi, riguarderebbe principalmente la psicanalisi o la sociologia più che l’interpretazione del testo poetico e la sua valenza comunicativa.
Certamente il periodo preso in esame nell’ultima fatica di Giovannoli non corrisponde al periodo più religioso di Dylan. Eppure, eppure…basta scorrere molti dei testi delle canzoni prese in esame nel terzo volume per rendersi conto che con l’età l’abile trickster di Duluth non ha rinnegato l’uso dell’enunciato biblico, anzi.
Pur escludendo infatti l’album di canzoni natalizie, in cui Adeste Fideles è presente, in una versione cantata con una voce più roca di quella di Tom Waits, insieme ad una pruriginosa immagine di una pin-up natalizia posta sulla copertina in compagnia di altre immagini dei Re Magi e di gioiose slitte trainate da cavalli sulla neve,1 quasi a voler giocare sulla componente sacra e profana (molto) delle festività natalizie, Dylan sembra aver incrementato negli album presi in esame l’uso della citazione biblica. Diretta o indiretta a seconda dei casi.
Il periodo corrisponde a quello in cui il cantautore dichiarerà apertamente che l’unica chiesa alla quale sente di appartenere è “quella della mente avvelenata”, ma allo stesso tempo i testi continueranno a riprendere citazioni del Vecchio e Nuovo Testamento oppure da canzoni (blues, gospel, spiritual, country song) in cui tali citazioni sono presenti anche se modificate o utilizzate in un contesto non propriamente legato ad una esperienza o speranza di ordine religioso o spirituale.
Ecco allora “the land of milk and honey” ( la terra del latte e del miele) che si trasforma nella “land of money” (la terra del denaro). L’allusione all’infranto sogno americano di libertà e vita migliore è evidente, ma è tutto lì? Davvero? O non riguarda forse tutta la società moderna, di qua e di là dell’oceano, a Nord come a Sud? O forse costituisce soltanto un’evocazione, qualcosa che sa trovare in ogni ascoltatore una diversa prospettiva interpretativa, tale da rivelare più i sogni o i demoni di chi ascolta che quelli di chi canta?
Oppure, come capita in Political World contenuta in Oh Mercy (del 1989), la sapienza (wisdom) di cui si parla nella terza strofa, dicendo che è stata gettata in prigione e che non c’è nessuno a raccoglierne la traccia (trail), è una reminiscenza del libro di Giobbe in cui si parla di una “Sapienza nascosta agli occhi di ogni vivente” (il mistero di cui l’essere umano non può appropriarsi se non avvicinandosi a Dio) oppure tratta delle idee che il potere vuole nasconder agli occhi di chi non “deve” sapere?
Affermava il romantico tedesco Novalis: la vera poesia può avere al massimo un vasto significato allegorico, come la musica. Aggiunge umilmente chi scrive che la poesia come la musica costituisce una sorta di vibrazione che percorre il mondo, tenendolo insieme e separandolo allo stesso tempo, poiché tutti possono trovare nello stesso testo poetico e nella stessa esecuzione musicale motivi comuni ed espressioni estremamente differenti di quella medesima Sehnsucht (struggimento, nostalgia, desiderio di qualcosa che non si sa bene interpretare né tanto meno si conosce con certezza) di origine romantica che sembra far vibrare le corde più intime dell’inconscio collettivo e di ognuno di noi.
E’ ancora Novalis ad affermare che nella lontananza tutto diventa poesia: montagne, uomini, accadimenti lontani. E allora come non comprendere che questi discorsi tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento scaturiscono, come i miti greci o di altre civiltà, da un tempo lontano, in cui era la voce a produrre la parola e a ricordare gli eventi, gli uomini, gli insegnamenti e le storie da trasmettere ai posteri.
La poesia e l’oralità scaturiscono dalla stessa fonte: la voce dell’uomo. Tonante, dimessa, autorevole o timida che sia. I profeti parlavano e dovevano trovare le giuste parole e i giusti esempi. Gli anziani dei clan, i capi tribù e i re parlavano e dovevano convincere chi guidavano e governavano. I sacerdoti cantavano e danzavano e dovevano coinvolgere i possibili adepti nei loro culti. I cacciatori cantavano e dovevano ammansire gli Dei e gli animali per farseli amici e ringraziarli, magari dopo averli uccisi.
I guerrieri e gli schiavi dovevano trovare esempi e modelli che li sostenessero nella battaglia e nella rivolta. Gli agricoltori tramandavano ai figli i loro insegnamenti e le loro conoscenze e così pure facevano le donne, le uniche a tramandare i segreti più veri della vita, della nascita e dell’amore.
Tutto ciò è andato avanti per millenni e si è depositato in un vastissimo immaginario collettivo che non ha e non può avere confini nazionali o di classe, anche se a tale scopo può essere talvolta utilizzato, perché spesso si è formato ancor prima che quelli esistessero nelle loro forme attuali. Un immaginario che coinvolge le figure del Mito, autentico patrimonio di archetipi, che da Ulisse e Atena a Mosè e Gesù Cristo, da Maria Maddalena a Hermes e a Gilgamesh si è trasmesso fino a noi, inconsapevolmente.
Così come si è depositato in opere che sono state scritte secoli dopo l’inizio della loro diffusione orale: l’Iliade, l’Odissea, l’Antico Testamento, così ricco di canti e poesie. Oppure attraverso una narrazione disordinata e popolare come quella contenuta negli infiniti Vangeli apocrifi, in cui magari un dispettoso Gesù ancora bambino fa morire un compagno di giochi per poter dimostrare la sua potenza facendolo poi risorgere. Un intero universo narrativo, evidentemente tutto di origine umile ed orale, da cui i Padri della chiesa hanno poi dovuto scindere il grano dalla pula per ottenere una narrazione più rispettabile ed accettabile.
E allora cosa fa il poeta, il cantautore, il poeta-cantautore vincitore di un premio Nobel come Dylan, se non rielaborare all’infinito temi antichi e sempre attuali, edificanti o devastanti, ma sempre in grado di toccare le menti e i corpi di chi lo ascolta. Cosa può fare se non dare voce alla Musa che canterà, magari polifonicamente, attraverso di lui? E’ soltanto una superficiale abitudine della società borghese, l’unica in cui la scrittura sia stata pienamente dominante dopo l’invenzione della stampa, quella di considerare il testo sempre come scritto e stabile, anzi stabilito una volta per tutte.
E’ una febbre filologica, nata con l’Umanesimo, che fa cercare sempre il testo definitivo e completo di un’opera, quasi che questa non fosse in costante evoluzione nel tempo e non soltanto nella o per la volontà dell’autore (ah già…i diritti d’autore…questo è mio, questo di qualcun altro etc.) e non soltanto per sua mano.2 Ed è stata spesso la cultura “bassa” e collettivamente condivisa, che molti ritengono sottocultura, quella che nel tempo ha rimodellato e ridefinito collettivamente i messaggi selezionando, in tempi e momenti diversi e attraverso rapsodi casuali oppure coscienti, ciò che alla fine rimarrà dell’umana esperienza e dell’umano errare. A dispetto dei palazzi della cultura “alta” dove tutto è via via classificato, canonizzato e definitivamente imbalsamato.
Ed è poi ancora un male interpretato laicismo di stampo perbenista e borghese che vede nella citazione religiosa soltanto un elemento di arretratezza ed ignoranza senza saper coglie invece la potenza del discorso figlio di secoli di rielaborazioni orali, in cui tutti i problemi dell’individuo e della specie sembrano essere già stati elaborati e rielaborati più volte. Magari senza l’aiuto della penna, del computer o dell’istituto universitario e degli specialisti che ne sono la malferma ma autoritaria espressione.
Ed è altrettanto il prodotto di un razionalismo portato all’eccesso, e conservativo quanto il buio che voleva inizialmente combattere, l’incapacità di cogliere il fatto che dentro a quelle parole antiche sia racchiusa la capacità di donare la speranza, di suscitare la rivolta oppure di consolare la sconfitta e la miseria, che non è sempre e soltanto economica.
 Soltanto per questa via si può realmente avvicinare Dylan, cercare di comprendere il suo uso delle citazioni, il suo modificare sempre ciò che il pubblico si aspetta come dato una volta per tutte, come ancora ha fatto nel primo dei tre concerti tenuti a Roma ad inizio aprile (qui). Solo così si può comprenderne ad un tempo la genialità, la poetica e l’arte come l’opera ricca e profonda di Renato Giovannoli ci stimola a fare.
Soltanto per questa via si può realmente avvicinare Dylan, cercare di comprendere il suo uso delle citazioni, il suo modificare sempre ciò che il pubblico si aspetta come dato una volta per tutte, come ancora ha fatto nel primo dei tre concerti tenuti a Roma ad inizio aprile (qui). Solo così si può comprenderne ad un tempo la genialità, la poetica e l’arte come l’opera ricca e profonda di Renato Giovannoli ci stimola a fare.
Si tratta dell’album Christmas In The Heart del 2009 ↩
Per meglio comprendere questo basterebbe che ogni lettore di questo articolo potesse rileggerlo nella sua forma originale e nelle dieci diverse versioni che hanno preceduto questa stesura definitiva (?), osservando come ogni minima variazione di termini o periodi possa portare il lettore stesso a recepirne il senso in maniera diversa, sia in positivo che in negativo. ↩



