di Roberto Carocci
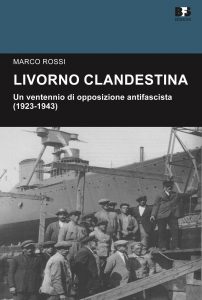 Marco Rossi, Livorno clandestina. Un ventennio di opposizione antifascista (1923-1943), Bfs, 2017, pp. 129, € 14,00
Marco Rossi, Livorno clandestina. Un ventennio di opposizione antifascista (1923-1943), Bfs, 2017, pp. 129, € 14,00
La storiografia ha a lungo dibattuto la spinosa questione dell’esistenza di un consenso di massa al fascismo. Attraverso lo studio delle realtà territoriali e urbane è possibile cogliere nel dettaglio gli aspetti di quella “zona grigia” che attraversò il ventennio mussoliniano, un ambito della società indefinito che se per un verso significò una tacita accondiscendenza nei confronti del regime, dall’altro fu il luogo fisico in cui il “silenzio” non coincise necessariamente con l’approvazione. Al suo interno, anzi, si celavano tutta una serie di sfumature in cui l’adesione passiva o la silente estraneità costituivano le premesse a un antifascismo che avrebbe via via assunto le forme di un’opposizione esplicita, finanche armata.
Le particolarità che contraddistinsero la laboriosa società livornese forniscono un valore d’indagine più generale sulla persistenza di un antifascismo diffuso tra gli anni della guerra civile (1921-22) e la Resistenza sviluppatasi in seguito all’8 settembre 1943. È proprio questo periodo di tempo che il libro di Marco Rossi affronta tramite una dettagliata ricognizione tra le carte di polizia e quelle tribunalizie dalle quali emerge tutta la fragilità dell’affermazione e della penetrazione culturale del regime tra le classi subalterne cittadine.
Dalla conquista militare del municipio livornese da parte dei fascisti nell’agosto 1922, dunque prima della marcia su Roma, ai primi mesi del ’23 si scatenò una vera e propria caccia al sovversivo che non risparmiò alcun mezzo, dall’aggressione fisica ai rastrellamenti per le strade, all’epurazione sui posti di lavoro fino all’invio in manicomio degli oppositori. Alla violenza del regime la popolazione rispose con la sua tradizione sovversiva di derivazione risorgimentale all’interno della quale si incontravano, e a loro modo si scioglievano, le diverse tensioni politiche e culturali – repubblicane, socialiste, anarchiche – che albergavano nei rioni popolari, in comunità socialmente omogenee e politicamente riottose formate per lo più da artigiani, operai e sottoproletari, la cui normalizzazione da parte del regime risultò tutt’altro che facile e, in buona sostanza, fallimentare.
Un fallimento particolarmente evidente nel mancato disciplinamento dell’elemento femminile che, anzi, segnò una dimensione di opposizione permanente nelle agitazioni e negli scioperi delle lavoratrici che si susseguirono durante tutto l’arco della dittatura. L’autonomia femminile si avvaleva di una complicità di genere che utilizzava forme e canali comunicativi propri come il passaparola nei luoghi di lavoro o nei mercati rionali dove erano frequenti gli scontri tra le popolane e i fascisti.
Tra le correnti politiche cittadine, gli anarchici furono tra i più colpiti dalla repressione pur mantenendo una rete organizzata in almeno tre circoli territoriali, una certa influenza tra i lavoratori del porto e legami stabili sul piano nazionale. Il movimento comunista presentava invece una realtà composita con almeno tre gruppi dissidenti che si aggiungevano a quello legato al partito ufficiale. Così articolato, il comunismo livornese svolse un ruolo fortemente attrattivo delle diverse componenti sovversive catalizzandone le aspettative di rivalsa, soprattutto tra la gioventù, anche a fronte di un partito socialista poco coeso, ma che fornì un discreto numero di militanti antifascisti. I repubblicani, dal canto loro, dopo una prima divisione tra filofascisti e antifascisti, si riunirono nell’avversione a un regime asservito alla corona, mentre nella gioventù, fin dal 1926, si giunse alla costituzione di un organismo unitario, il Comitato giovanile per l’unità proletaria, che riuniva esponenti di tutte le correnti.
Tutte queste espressioni di antagonismo poggiavano su un proletariato cittadino che aveva dato una poco convinta adesione al fascismo – per lo più motivata dalla necessità di mantenere il posto di lavoro – che si rifletteva nella scarsa adesione alle corporazioni o alle associazioni fasciste. Tale insofferenza era dovuta al mantenimento di un certo livello di autonomia di classe che si spinse fino a tentare di riorganizzare una rete sindacale clandestina unitaria dalle finalità più rivoluzionarie che rivendicative. Proteste spontanee e motivi di indisciplina si espressero infatti in maniera permanente in tutti i comparti produttivi, anche i quelli più piccoli, fino a una ripresa più robusta con gli scioperi scoppiati all’inizio del 1943, mentre momenti di scontro frontale si ebbero, per esempio, in occasione dei funerali del comunista Mario Camici nel ’33, che si trasformarono in una pubblica manifestazione cui seguirono attentati dinamitardi di una certa entità.
L’antifascismo livornese si componeva dunque di atteggiamenti diversi, dalla protesta morale all’agitazione sociale, dal volantinaggio clandestino alla lotta armata. Vi erano anche conflitti simbolici come indossare la camicia rossa garibaldina nelle manifestazioni ufficiali o non consegnare e nascondere la bandiera di un circolo operaio – la cui ostentazione era considerata un atto di sedizione – o il crescente utilizzo delle scritte murali, tutte meritoriamente riportate nell’appendice documentaria del volume. Altre espressioni di opposizione erano invece di carattere ironico, come la traduzione del motto dannunziano nell’irriverente, e molto popolare, Eja eja baccalà!
Quella studiata da Marco Rossi è una realtà operaia e popolare di una provincia italiana non solo non pacificata né normalizzata, ma fucina di un antifascismo diffuso e combattivo, particolarmente radicato tra i ceti subalterni che, oltre a segnalare tutte le fragilità dell’affermazione del regime mussoliniano, avrebbe costituito l’energica base sociale della Resistenza e della lotta di Liberazione.



