di Gioacchino Toni
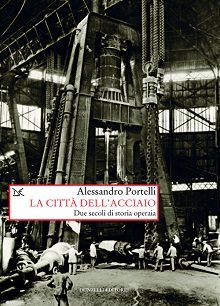 Alessandro Portelli, La città dell’acciaio. Due secoli di storia operaia, Donzelli editore, Roma, 2017, pp. XII-452, € 32,00
Alessandro Portelli, La città dell’acciaio. Due secoli di storia operaia, Donzelli editore, Roma, 2017, pp. XII-452, € 32,00
Il volume di Alessandro Portelli La città dell’acciaio (2017), nato dall’accorpamento di Biografia di una città (1985) e Acciai Speciali (2008), riesce a dar conto di diverse trasformazioni: dell’universo ternano che da rurale diviene prima industriale poi postindustriale; della storia orale che nel periodo che intercorre tra i due saggi qui riuniti da marginale è stata prima accettata e poi, forse, suggerisce l’autore, persino eccessivamente celebrata; del linguaggio degli intervistati che da «epico, vernacolare, intriso di politica, di identità e organizzazione di classe» dei più anziani, alcuni nati nel lontano 1890, diviene «ironico, disincantato, spoliticizzato, più istruito ma non meno arrabbiato» nei più giovani, specie quelli nati dopo il 1980; del registro orale che muta in scrittura e che da privato, nel divenire libro, si trasforma in racconto pubblico; dei nudi fatti storici che si modificano mescolandosi con i sogni e i desideri di chi li racconta.
Se la prima parte di questo immenso lavoro è incentrata su Terni, la seconda si apre ad una dimensione globale che tocca anche gli stabilimenti ThyssenKrupp di Nashik in India, di Ibirité e San Paolo in Brasile e di Johannesburg in Sudafrica. Nelle oltre quattrocento pagine del volume si dipana un affascinante e coinvolgente lungo viaggio tra i racconti operai meritoriamente e sapientemente raccolti e tradotti in forma scritta da Portelli che dedica l’apertura agli aspetti metodologici su cui è costruito il lavoro e ad alcune problematiche inerenti la storia orale.
Lo studioso sottolinea sin dalle prime pagine che il suo ricorrere alle fonti orali non deriva da alcuna pretesa di superiorità o autenticità di queste rispetto ad altre fonti, «ma perché la parola delle classi non egemoni e della gente comune, per sopravvivere e funzionare in condizioni di dislivello di cultura e di potere, ha dovuto e saputo attrezzare l’oralità con forme e modalità più articolate e coerenti di quelle per molto tempo conseguite nell’appropriazione della scrittura» (p. 5).
Se la parola operaia in quel di Terni si forma in continuità con la tradizionale cultura orale contadina, sono soprattutto le strutture organizzate comuniste ad insegnare a questo mondo operaio a leggere e discutere i giornali e i libri. «Le classi popolari hanno ricevuto l’accesso non a tutta la scrittura, ma solo a una sua parte: hanno imparato a leggere, ma ci si è preoccupati meno di porle in grado di scrivere. La cultura si riceve, non si produce: perciò la cultura che si riceve è solitamente quella di qualcun altro […] La produzione non egemonica di discorso resta così affidata un’oralità svalorizzata agli occhi dei suoi stessi portatori e attraversata da livelli e gerarchie, o a una scrittura posseduta in modo imperfetto» (p. 4).
Nel caso della storia orale il ricercatore non si limita a reperire i dati ma, inevitabilmente, contribuisce a formarli. «La storia orale comincia nel momento in cui l’incontro tra ricercatore e narratore produce un discorso a due voci che verrà poi elaborato, interpretato e pubblicato. I dati nascono dunque già come prodotto di un’interferenza» (p. 6). All’intervista prendono parte un osservatore e un osservato, con tutti i rischi di distorsione dei dati che questo rapporto fondato sulla diseguaglianza comporta. Non di rado, ad esempio, l’osservato, sentendosi in posizione subalterna nei confronti dell’osservatore, adotta pratiche di compiacimento e dissimulazione. Siccome «uguaglianza non significa assimilazione […], la parità mancante va denunciata come una condizione da costruire ai fini della trasparenza e dell’attendibilità dei dati. È questo il nocciolo duro di politicità implicito in ogni incontro su campo» (p. 6). Se l’intervista non viene pensata e costruita come scambio «di sguardi tra soggetti diversi ma uguali», continua Portelli, allora l’osservato è ridotto ad oggetto, appendice degli strumenti dell’osservatore.
Il racconto orale deve poi essere tradotto in testo scritto per essere trasmesso attraverso il libro e il passaggio dall’oralità alla scrittura apre diverse problematiche. La trascrizione fedele del contenuto dei nastri risulta spesso inefficace in quanto incapace di rendere il senso di quanto trasmesso nel racconto orale. Portelli ricorda come diversi intervistati, nel momento in cui hanno avuto modo di leggere la trascrizione di quanto raccontato oralmente, siano restati delusi per l’eccesso di esattezza riscontrato, aspettandosi, probabilmente, nel passaggio alla forma scritta, un miglioramento formale a cui avrebbe dovuto ottemperare l’intellettuale. Vivendo il racconto colloquiale come racconto privato, gli intervistati si aspettavano che lo studioso, nel trasformarlo in forma scritta, si preoccupasse anche di renderlo più presentabile. Lavorare con le fonti orali costringe a fare i conti con molte ambivalenze e contraddizioni; se esiste una fedeltà alle fonti, consistente nel garantire il diritto all’autorappresentazione, esiste anche la fedeltà che il ricercatore deve a se stesso, alla descrizione fedele di ciò che ha visto e sentito.
Esattamente come avviene per ogni altra traduzione, anche la trascrizione non può essere intesa come riproduzione meccanica del testo di partenza. Si tratta piuttosto di una sua rappresentazione in un medium diverso e occorre tener presente che rispetto all’orale la scrittura è maggiormente standardizzata. «L’ambivalenza della storia orale si esprime dunque anche nella doppia forma di rispetto del testo: mantenerlo intatto e/o farlo funzionare per iscritto; rispettare la lettera e salvarne la qualità (un “bel” discorso orale può diventare insensato in una trascrizione meccanica; e anche la falsificazione della qualità è un’infedeltà). Trascrivere significa stare in un spazio intermedio dove vengono rispettate e violate al tempo stesso le leggi dell’oralità e quelle della scrittura, cercando di stabilire fra i due poli una tensione costante, che a suo modo rispecchia anche l’ambiguità culturale delle fonti» (p. 11). Inoltre, occorre tener presente che mentre l’oralità quotidiana è un discorso in fieri, spesso riaggiustato in corso d’opera, nella sua trascrizione si rende spesso necessario intervenire ripulendo il testo da ripetizioni, affermazioni restate in sospeso ecc. Ciò risulta necessario, sostiene lo studioso, sia per dare maggior leggibilità e coerenza al testo scritto che per rispetto nei confronti dell’autorappresentazione dei narratori.
Esiste poi la questione del montaggio in fase di trasformazione in scrittura dei testi registrati. «La storia orale è un tessuto di racconti: considerarla dal punto di vista dell’arte del raccontare può servire a recuperare una parte della fluidità che il passaggio della scrittura congela […] Guardiamo questi discorsi come narrazione, anziché come informazione: vi riconosciamo le manipolazioni creative nel rapporto tra tempo della storia e tempo del racconto; la focalizzazione limitata e il punto di vista circoscritto come limite di prospettiva ma anche come tenace difesa della presenza del soggetto narrante; un solido senso della struttura; un uso consapevole dei simboli. Costringere questo discorso nella sintassi del discorso storiografico significa rischiare di violarne la forma e il senso; si tratta piuttosto di far entrare la dimensione romanzesca dei materiali orali dentro il testo storiografico e lasciare che questo – pur mantenendo tutta la propria affidabilità referenziale – sia contaminato dall’impurità letteraria delle sue fonti» (pp. 12-13).
Riferendosi alle modalità con cui nel volume ha tentato di dare forma narrativa ad una città intera, intrecciando storie individuali e collettive, documenti d’archivio e frammenti giornalistici, Portelli sostiene si possa effettuare una similitudine con la struttura adottata dalla trilogia USA di John Dos Passos che presenta «un montaggio basato su una logica associativa di accostamenti sincronici attraversati da fili di biografie di personaggi riconoscibili nella folla delle voci della città» (p. 14). Portelli sostiene di avere la sensazione di avere così trasformato Terni nella sua Yoknapatawypa personale, soltanto che, a differenza di quella di William Faulkner, non è immaginaria.
«Quasi tutte le interviste, e soprattutto le più significative e complete, procedono per grosse unità temporali disposte in ordine cronologico; ma all’interno di ciascuna unità il racconto si muove liberamente avanti e indietro, spesso addirittura a ritroso, molte volte partendo da un episodio centrale che dà il senso del tutto per poi tornare indietro e andare avanti. Questa struttura ha finito per diventare la struttura complessiva del libro: leggerlo è, in qualche modo, come ripercorre un’unica grande intervista. L’isomorfismo tra interviste e montaggio segue anche le trasformazioni generazionali della memoria. Fino, all’incirca, alla seconda guerra mondiale i racconti sono filtrati dalla dimenticanza e levigati dalla ripetizione, costituendo un repertorio in cui ogni affermazione è corredata dal suo racconto, che viene richiamato in forma in gran parte combinatoria. Dalla generazione degli anni quaranta in poi, non c’è più il tempo di dimenticare e selezionare; la grande massa di informazioni ricordate produce un flusso verbale ancora in gran parte in cerca di forma, nel quale i “materiali preparatori” prevalgono sugli elementi strutturati. Mentre i racconti più antichi si avvolgono della memoria dell’arte dell’oralità preindustriale, questi sono attraversati dalla perdita graduale di riferimenti precisi nella struttura industriale, urbanistica, politica della città – a partire dal “taglio netto” dei licenziamenti del 1953. Infine, avvicinandosi alla contemporaneità, si incontra una parola più riluttante, tesa e nervosa, che non si distende quasi mai in una forma ampia, ma procede per unità sminuzzate, serrate, incompiute, o per i cicli seriali che torno ossessivamente su se stessi (e i tempi verbali adesso sono quelli dei mass media, dell’elettronica, del Rock). Anche le unità del montaggio del testo seguono questo andamento, facendosi (solo in parte dalle scelta consapevole) sempre più frammentarie ed ellittiche a mano a mano che ci si avvicina al presente e che un tipo di narratore prende gradatamente il sopravvento su un altro» (pp. 15-16).
Una riflessione fondamentale Portelli la dedica alla questione dell’attendibilità della storia orale e, soprattutto, alla sua capacità di accrescere i freddi e nudi fatti con l’apporto caldo dei sogni e dei desideri dei soggetti intervistati. «Non tutto quello che si racconta in questo libro è vero; ma tutto è stato veramente raccontato. Il rapporto fra racconto dell’evento e racconto come evento sottolinea la funzione della memoria non come magazzino di fatti ma come matrice di significati […] Ciò che mi ha coinvolto nella storia orale non è la sua attendibilità, ma la frequenza e ricchezza degli scarti e delle invenzioni, dove si addensa la funzione valutativa del racconto, il giudizio, il sogno, il desiderio. Perciò, quello che segue non è tanto la ricostruzione di quasi due secoli di storia di una città attraverso la nascita, il fulgore e la crisi della civiltà industriale, quanto una ricerca del rapporto della gente con questa storia» (p. 16-17).
Ai fini dell’opera di Portelli nei racconti degli intervistati quel che poteva succedere è altrettanto importante di quello che è successo «questa storia fatta coi “se” e coi “ma”, che intreccia alla memoria dei fatti le ipotesi del desiderio, affonda le radici in una delle grandi forme del rifiuto dell’esistente, l’ucronia» (p. 17). Secondo lo studioso, «I racconti immaginari e ipotetici costituiscono il grado più alto d’intermediazione della soggettività tra evento e racconto (già implicita nella manipolazione della sostanza fonetica, nelle variazioni di registro linguistico, nell’articolazione delle forme retoriche e narrative). Sapremmo molto di meno su tutta questa storia, senza gli errori creativi della memoria e della fantasia che ne salvano il senso» (p. 18).



