di Armando Lancellotti
Detto approssimativamente: Dire di due cose, che esse siano identiche, è un nonsenso; e dire di una cosa, che essa sia identica a se stessa, non dice nulla (L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 5.5303)
È cosa facilmente verificabile per chiunque che il concetto di identità sia oggigiorno uno dei più frequentemente utilizzati in tutti gli ambiti del discorso pubblico e questo ha dato luogo ad una moltiplicazione delle sue possibili declinazioni e delle sue differenti accezioni: identità occidentale, europea, nazionale, culturale, religiosa, etnica, locale o regionale, personale ecc. E poco importa se molte di queste espressioni abbiano oppure non abbiano un senso compiuto che ne permetta un utilizzo valido e pertinente, perché la rivendicazione identitaria sembra essere diventata un’ossessione a tal punto evidente, pervasiva e diffusa da non riuscire più neppure a mascherare le dinamiche che la producono, le esigenze e le difficoltà individuali e collettive che la alimentano. È come se lo sbriciolamento della realtà sociale, politica, economica, lavorativa – conseguenza di un mondo reso globale da un mercato totale in costante corto circuito e aggrovigliato su stesso nel circolo vizioso della riproduzione di iniquità sociale – avesse reso necessario il ricorso a pratiche identitarie, ovvero all’arroccamento difensivo su posizioni identitarie sufficientemente forti per fornire l’illusione di un barlume di sicurezza.
Che si tratti del più volte evocato “scontro di civiltà” o delle baggianate su presepi ed alberi natalizi da difendere da chissà quale nemico come simboli culturali-religiosi; che si parli delle frontiere mediterranee o balcaniche da presidiare per bloccare l’arrivo o il passaggio dei migranti o dei sempre più richiesti interventi politici di esclusione economico-sociale dei migranti stessi e di altre minoranze per la conservazione di un benessere invariabilmente decrescente, tutto ciò lo si fa sempre riferendosi, come base di legittimazione, ad una identità, da rivendicare, da riaffermare, soprattutto da difendere. Ci si definisce, a seconda di casi e contesti, occidentali, europei, cristiani, addirittura anacronisticamente patrioti, italiani o di altra nazionalità, insomma ci si propone come titolari di una identità, che ci determina, ci profila, ci consolida e infine ci contrappone agli altri, ai nemici.
Lo scenario politico poi (e non solo quello italiano), desertificato da una povertà di pensiero mortificante, abbonda di richiami ed appelli identitari, in applicazione della più elementare e banale legge del mercato, quella della domanda e dell’offerta che reciprocamente si condizionano: leader e partiti politici offrono temi identitari ad un’opinione pubblica che li domanda esponenzialmente; domanda a sua volta alimentata da un’offerta crescente e variegata.
Stando così le cose, una riflessione approfondita sul concetto di identità, come quella che propone Francesco Remotti nel suo Ossessione identitaria [Laterza 2010, ripubblicato nella collana Economica nel 2017], risulta particolarmente utile ed interessante. L’autore – antropologo e professore emerito all’Università di Torino – affronta lo studio del concetto di identità con gli strumenti dell’antropologia, delle scienze umane e sociali, della filosofia, giungendo a conclusioni, per sua stessa ammissione, diverse da quelle da lui proposte negli anni ’90 del secolo scorso, quando, in saggi come Contro l’identità [Laterza, 1996], ancora riteneva che l’idea di identità fosse un qualcosa di irrinunciabile e che bastasse attenuarne la forza, evitarne l’uso unilaterale ed invasivo. Oggi Remotti ritiene che si possa, che si debba fare un passo deciso in avanti e in direzione del rifiuto del concetto di identità, del suo definitivo abbandono, a causa della sua “tossicità”; l’identità infatti, afferma esplicitamente l’autore, è una “parola avvelenata” e pertanto socialmente perniciosa e contagiosa.
Le analisi e le argomentazioni di Remotti presuppongono una preliminare distinzione di due piani: quello analitico, delle riflessioni elaborate dagli studiosi delle scienze umane e sociali e quello operativo, dei concreti soggetti ed attori sociali; ovvero il piano della definizione teorica del concetto di identità e della storia dei suoi significati e quello pratico dell’effettivo agire sociale dei soggetti, individuali e collettivi, che attuano logiche e prassi identitarie.
La parola “identità” di per sé è «nitida, limpida, elegante, pulita» (p. X) e queste sue caratteristiche sono forse la conseguenza dell’ambito logico e metafisico in cui essa è stata originariamente elaborata e di quello giuridico ed amministrativo in cui è largamente impiegata. La “certificazione dell’identità” costituisce, infatti, uno degli atti fondamentali previsti dal nostro ordinamento giuridico e quello all’identità personale è considerato un diritto inalienabile dell’uomo. L’assunzione di una identità funge da ancoraggio a qualcosa di solido e stabile, quasi fosse una sorta di declinazione esistenziale e sociale del principio logico di identità e di non contraddizione: ognuno è se stesso e non può essere un altro. Pertanto, in quanto “promessa” di riconoscibilità e stabilità, il concetto di identità parrebbe essere meritevole di giudizio positivo, mentre la tesi di fondo del saggio di Remotti è del tutto opposta.
La negatività del concetto è data innanzi tutto dal fatto che “identità” è una parola ingannevole, mistificante, poiché promette o lascia intendere qualcosa che non c’è e che non può esserci, racconta un mito, un grande mito del nostro tempo. Almeno due – spiega lo studioso piemontese – sono le categorie principali dei miti: quelli che non si preoccupano di dissimulare la propria natura, tanto incredibili e fantasiosi sono le vicende e i personaggi narrati, e quelli che invece «esigono di essere trattati come realtà» (p.XII) e l’identità è uno di questi; il mito identitario è serio, anzi serioso, pretende rispetto e accreditamento di realtà, pur essendo in verità qualcosa di concretamente inafferrabile, indefinibile.
L’identità è un concetto “sostanzialistico”, cioè metafisico in senso classico, perché rimanda ad una sostanza, ad un nucleo originario, stabile e permanente. La sostanza infatti è il fondamento, ciò che permane pur nel variare dei suoi attributi; per l’ontologia classica è il significato più forte dell’essere, «è ciò che garantisce l’identità di una cosa sia nell’evolversi nel tempo e nel mutare delle condizioni, sia attraverso la molteplicità degli oggetti» (p. 26). Dal punto di vista filosofico il concetto trova il suo fondamento logico nel principio di identità e di non contraddizione, che ritaglia, delimita l’identità e la separa dall’alterità, la quale è definita solo relativamente, negativamente ed è allontanata dall’identità a tutela della sua purezza. È l’essere identico a se stesso dell’ontologia eleatica, che relega l’alterità nell’ambito del non essere.
Con la dialettica hegeliana – osserva Remotti – identità e alterità si riavvicinano: nella relazione dialettica l’identico si rovescia nel proprio negativo – l’altro da sé – che però viene riassorbito dallo sviluppo speculativo della ragione dialettica e dalla riaffermazione di una identità non più immobile e statica, ma progredente. Hegel emenda l’idea classica del principio di identità, affermandone l’astrattezza da un punto di vista dialettico: il principio di identità e di non contraddizione è lo strumento con cui opera l’intelletto producendo universali astratti, che solo il lavorio dialettico della ragione, che passa attraverso la relazione con l’altro, con il negativo dialettico, riesce a rendere concreti. L’identità si rovescia nell’alterità e l’Intero (la realtà, l’essere) è processualità storica non fossilizzata in sostanze statiche separate le une dalle altre. «A e non-A si intrecciano e si combinano per formare, a loro volta, altre entità in un movimento trasformativo continuo e inarrestabile» (p. 28). In Hegel l’identità statica è superata dalla convinzione che la realtà sia trasformazione, ma «l’idea di un principio unitario permanente» (p. 28) ricompare sotto la forma della direzione necessaria, che tutto ricomprende, che a tutto dà un senso e che l’Intero segue, realizzando se stesso come Risultato del proprio processo.
Mutatis mutandis, la stessa logica universalistica e necessitante dell’hegelismo sottende anche la dialettica marxista – sostiene Remotti – e così pur «fondando la dialettica su altri presupposti (materialistici invece che idealistici), il marxismo adotta una prospettiva di universalità, la quale giustifica l’inglobamento anche violento delle realtà locali entro un processo storico avente un significato e una destinazione universali» (p. 29).
Quando, a partire dagli anni ‘60/’70 del XX secolo, tramontano prospettive ed impostazioni universalistiche e fortemente generalizzanti, nelle scienze umane e sociali riprende l’attenzione per il concetto di identità, ma non più definito in termini sostanzialistici ed universalistici (non esistono più vie maestre, ma solo deviazioni dall’inesistente via maestra), bensì ripensato sotto la forma dei “soggetti”, individuali o collettivi, che prendono forma in un contesto di concrete e divenienti relazioni sociali e che aspirano ad una identità nella misura in cui sono in grado di richiedere ed ottenere “riconoscimento” dagli “altri”. Una nozione sociologica di identità, quella elaborata dalle scienze umane e sociali del Novecento, ben diversa da quella ontologica classica, ma che comunque richiede un «sufficiente grado di compattezza interna e una soddisfacente definibilità esterna» (p. 34).
È possibile – osserva Remotti – distinguere tra due diverse e fondamentali tipologie di richiesta sociale di riconoscimento, non necessariamente entrambe identitarie. La prima è quella identitaria in cui il soggetto richiede il riconoscimento della sua sostanza, della sua “essenza”; la seconda (riconoscimento non identitario) è quella in cui il soggetto richiede il riconoscimento della sua “esistenza” (diritti, progetti, obiettivi, ecc). Diritti, progetti, obiettivi di vita sono dialettici, mutevoli e precari, possono essere discussi, mediati, corretti in itinere, mentre l’identità sostanziale è un’essenza, pretende di essere riconosciuta come immutabile ed immobile. Essa vuole essere difesa nella sua purezza e percepisce l’”alterità” e l’”alterazione” come pericoli.
Secondo la logica identitaria l’altro è una minaccia anche quando o anche se non compie alcuna azione propriamente minacciosa e occorre liberarsene al più presto, anche preventivamente. L’identitarismo tende a dividere l’umanità in “gli uni” e “gli altri”. E infatti, sostiene Remotti, tra razzismo ed identitarismo non c’è poi molta differenza, perché entrambi si appellano ad una sostanza – prevalentemente biologica nel primo caso e storico-culturale nel secondo (anche se poi le due componenti possono spesso mescolarsi) – ed entrambi si pongono il fine prioritario della difesa della propria purezza dal contagio dell’alterità. Oggi il mito della razza, per ben note ragioni storiche, non gode di particolare fortuna e credito, anche se non mancano di certo e da più parti i tentativi di un suo rilancio e di un suo riaccreditamento nell’ambito del politicamente pensabile e dicibile. Allora a sostituirsi al mito della razza e, potremmo dire, a veicolarlo surrettiziamente è l’altro mito, invece molto in voga, il mito dell’identità, che per giunta non è considerato un mito, ma qualcosa di assolutamente reale.
Risulta, allora, chiaramente giustificata da quanto detto la proposta di Remotti di sbarazzarsi del concetto di identità e delle sue nefaste conseguenze e, sul piano terminologico, di sostituirlo con il concetto di “noi”, ben più concreto, meno velleitario ed assoluto. I “noi” sono da intendersi come soggetti sociali richiedenti riconoscimento, ma non necessariamente un riconoscimento identitario. Tra NOI e IDENTITA’, quindi, vi è differenza. Innanzi tutto i “noi” di cui possiamo fare parte in uno stesso momento della nostra esistenza sono molteplici: famiglia, vicinato, partito politico, classe sociale, fede religiosa, tifo calcistico, scuola, amicizia, ecc e ognuno di questi gruppi si può a sua volta suddividere in “noi” sempre più piccoli e differenziati. Inoltre l’”identità” è qualcosa di astratto, mentre i “noi” sono concreti. In quanto astratta, l’”identità” pretende l’immobilità, l’immutabilità, mentre i “noi” sono fluidi, divenienti, dinamici, situazionali. Il “noi” può essere un concetto poroso, che comprende l’alterità al suo interno, mentre l’”identità” o il “noi identitario” escludono l’alterità e rifuggono l’alterazione.
Occorre, pertanto, ridefinire, proprio alla luce degli sviluppi delle scienze umane e sociali, il concetto di identità, intendendolo non come qualcosa di già dato una volta per tutte e a cui assimilarsi, un qualcosa che pretenda di essere riconosciuto come identico a sé, bensì come il risultato di pratiche ripetute di riconoscimento all’interno di un contesto di relazioni reciproche che fanno dell’identità un qualcosa in fieri, un qualcosa di transitorio ed approssimativo. E questo qualcosa si definisce a posteriori, mai a priori e in quanto meta di approssimazione continua. L’identità va pensata – potremmo dire – come una kantiana “idea della ragione”, il cui uso corretto non è quello assoluto, cioè sostanziale e fondativo, bensì quello regolativo, cioè costituente un’ideale termine di tensione.
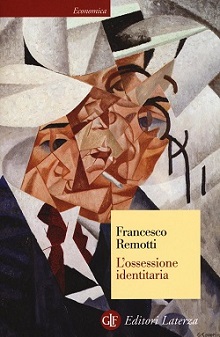 Il rapporto con l’alterità, inoltre, è da intendersi come qualcosa di indispensabile per il processo di definizione di un soggetto (individuale o collettivo) in qualche modo identitario, di una società o di una cultura. Si potrebbe dire che l’alterità è complementare e consustanziale all’identità. La “sfera eleatica” che l’identità pretenderebbe di essere mostra in realtà al proprio interno punti di discontinuità, fratture, un alternarsi continuo di pieno e di vuoto.
Il rapporto con l’alterità, inoltre, è da intendersi come qualcosa di indispensabile per il processo di definizione di un soggetto (individuale o collettivo) in qualche modo identitario, di una società o di una cultura. Si potrebbe dire che l’alterità è complementare e consustanziale all’identità. La “sfera eleatica” che l’identità pretenderebbe di essere mostra in realtà al proprio interno punti di discontinuità, fratture, un alternarsi continuo di pieno e di vuoto.
Per argomentare questa tesi Remotti fa ricorso alla teoria antropologica del “vincolo di particolarità”. «Che si tratti di sistemi, di istituzioni, di costumi, di culture, la convinzione è che essi siano sempre particolari e locali. L’universalità inerisce soltanto all’insieme delle potenzialità iniziali e inespresse, da cui prende avvio qualunque realizzazione umana, qualunque forma culturale» (pp. 10-11). All’interno delle “molteplici potenzialità iniziali” occorre operare numerose scelte, talvolta consapevoli e più di frequente inconsapevoli – quelle «che sono alla base delle configurazioni culturali, e che determinano i caratteri di ciò che si usa chiamare identità, si realizzano [spesso] a livello inconscio» (p. 11) – ma comunque sempre delle scelte che comportano l’esclusione delle opzioni altre, che però, proprio perché fatte oggetto di esclusione, determinano in modo vincolante il profilo di quanto è stato scelto, contribuiscono alla sua delineazione o definizione. Come a dire che una scelta è sempre limitata e limitante, cioè particolare e strettamente legata (vincolata) a ciò che ha scartato.
La consapevolezza delle dinamiche proprie del “vincolo di particolarità” permetterebbe, secondo Remotti, una riformulazione del concetto di identità in grado di mettere in evidenza i tratti di arbitrarietà, relatività, precarietà, incertezza e fluidità della scelta che ne costituisce il fondamento.
«Siamo così (questa – se proprio vogliamo – è la nostra identità), ma avremmo potuto essere diversamente» (p. 12).
L’identità pertanto, pensa Remotti, è un altrove, un al di là e tale deve rimanere. In questo modo si evidenzierebbero gli sforzi che i soggetti compiono per tendere verso la stabilizzazione. Sono gli sforzi che contano ben più del risultato, il quale non è da intendersi come qualcosa di astratto ed inafferrabile quale è il concetto di identità, ma come qualcosa di ben più concreto, seppur di grado inferiore: un po’ di coerenza, un po’ di continuità, un po’ di stabilità. Inoltre se l’identità viene prelevata da quell’altrove utopistico in cui deve rimanere e viene introdotta nell’ambito della concreta esperienza, questo comporta l’abbandono, la dimenticanza di una serie di importanti valori come l’alterità e l’alterazione, importanti tanto quanto quelli di stabilità e coerenza.
Il soggetto (individuale o collettivo) si trova, pertanto, all’interno di una banda di oscillazione i cui estremi sono l’Identità e l’Alterità e si avvicinerà all’uno o all’altro estremo a seconda delle circostanze, delle necessità, dei momenti. Entrambi gli estremi sono pericolosi: quello dell’Identità comporterebbe fossilizzazione ed esclusione di ogni forma di divenire e di dinamismo, quello dell’Alterità comporterebbe il rischio dello sfaldamento e del dissolvimento della soggettività stessa.
Appare chiaro come qui si tratti del ripensamento complessivo dell’idea di identità, che si pone in alternativa al tradizionale modo di intenderla che ne definisce il concetto in termini di necessità e di universalità immutabile; caratteri del concetto di identità che si fondano e si legittimano sulla base di una operazione di condanna e di cancellazione delle possibilità alternative scartate e di successiva ipostatizzazione della scelta operata. In questo modo si disconosce come l’identico e l’altro siano entrambi conseguenze, strettamente apparentate, dello stesso atto, l’atto della scelta che produce la biforcazione identità-alterità.
«Se le scelte sono possibili (non necessarie), se sono particolari (non universali), se sono precarie (non inevitabilmente durature o permanenti), ciò significa che sono anche revocabili. L’alterità è lì, minacciosamente incombente, inquietantemente a portata di mano: non è soltanto il sottoprodotto delle scelte (i suoi scarti), qualcosa che appare o si determina dopo il gesto della scelta; è invece alla radice stessa delle scelte» (p. 13).
Le nostre società, invece, tendono sempre più evidentemente in direzione dell’estremo dell’Identità, così evidenziando – ritiene Remotti – una crescente fragilità strutturale.
«Rincorrendo un sogno impossibile ed irrazionale, quello di afferrare un principio di per sé inafferrabile e inesistente, la cultura identitaria finisce per essere una cultura povera, che per giunta non conosce la sua miseria. In fondo, l’identità è l’ultima risorsa che rimane quando c’è penuria di strumenti per immaginare un futuro diverso, quando si chiudono gli occhi di fronte alle possibilità dell’alterazione» (p.XXV).
Se le scelte che fondano culture, civiltà, società, sistemi ed istituzioni sono inevitabilmente arbitrarie e precarie, allora ciò che si produce è quanto Remotti, diversamente rendendo l’espressione freudiana Das Unbehagen in der Kultur, esprime come “il disagio nella cultura”, applicando però il concetto secondo modalità prese a prestito – dice l’autore – da John Dewey. Per sfuggire a tale disagio, società e culture ricorrono al “camuffamento” della scelta fondativa e della sua precaria arbitrarietà, che viene sostituita da una pretesa necessità di tipo storico o naturale, operazione questa del camuffamento che poi si traduce nella “reificazione” (sopra da noi chiamata ipostatizzazione) dei prodotti della scelta, che risultano essere oggetti a sé stanti, dotati di realtà ed esistenza proprie ed indipendenti dall’atto decisionale da cui conseguono.
«Valori, significati, idee, tutto ciò che è incorporato nelle istituzioni, nei costumi, nella cultura non è più considerato come l’esito di scelte, ma come se avesse una realtà a sé stante, come se fosse una res, una “cosa” a parte rispetto alle possibilità di scelta degli individui. […] La reificazione uccide il senso delle possibilità; sopprime (o tenta di sopprimere) il senso della precarietà» (p. 14) e di conseguenza contrappone la pretesa di “integrità” (e la tutela di essa) alla possibilità di “integrazione”.
Sul piano operativo, infatti, cioè su quello pratico dei concreti attori e soggetti sociali, non su quello analitico degli studi delle scienze umane, permane l’aspirazione alla conquista e alla rivendicazione di un’identità concepita in termini ontologici, essenzialistici, che permetta agli attori stessi di sottrarsi al confronto e all’interazione all’interno dei concreti contesti di relazione sociale e di arroccarsi a difesa di una pretesa propria natura identitaria immutabile ed indiscutibile.
Due, riflette Remotti, sono le categorie principali dei processi di costruzione identitaria, «quella dell’”io” e quella del “noi”, intendendo per categoria dell’”io” i soggetti individuali e per categoria del “noi” i soggetti collettivi» (p. 39). Entrambe le categorie presentano alcuni tratti fondamentali comuni, come, innanzi tutto, il fatto che sia gli “io” sia i “noi” non siano delle entità già date e costituite, che poi agiscono e intrecciano rapporti, ma, al contrario, sono il risultato delle loro azioni e relazioni. In secondo luogo, l’essere sia degli “io” sia dei “noi” è prevalentemente di natura sociale, culturale, storica e in modo decisamente meno importante di natura biologica, anche se questo configurarsi come “artefatto umano” più che come “dato di natura” risulta più evidente nel caso dei “noi”, i quali, inoltre, si presentano in forme e modi estremamente più variabili e differenziati rispetto agli “io”.
Pertanto, dal punto di vista, per esempio, quantitativo, i “noi” possono variare dal limite minimo della coppia di individui al limite massimo dell’umanità intera, passando attraverso un popolo, una nazione, una civiltà, ecc. Inoltre, se l’impostazione tradizionale del pensiero e della cultura occidentali aveva per lo più ritenuto che prima vi fosse l’uomo come individuo, come soggetto a sé stante e poi che questo costituisse una collettività sociale, la filosofia e le scienze umane del Novecento si sono preoccupate di capovolgere il punto di vista, dimostrando che «l’io è un costrutto sociale, un artefatto culturale [e che pertanto prima] vi sono i noi entro cui si costruiscono gli io […], ovvero ancora che prima vi sono le relazioni e poi le entità entro cui esse intercorrono» (p. 41).
Entrambe le categorie di soggetti, però – io o noi – nel momento in cui rivendicano una identità, aspirano alla compattezza, alla eliminazione delle differenze interne, alla costituzione di una unità solida escludente gli altri; l’insistenza o l’ossessione identitarie conducono alla chiusura, alla indisponibilità al confronto e al rifiuto deciso della alterazione, che diviene un vero e proprio tabù: il terrore del “meticciato”.
La scelta identitaria è una scelta per niente affatto necessaria o inevitabile, bensì una scelta – dice Remotti – miope ed impoverente, in quanto si preclude la possibilità dell’arricchimento nel contatto con gli altri, disconoscendo che “noi” e “altri” costituiscono due entità complementari, mai definite o definibili una volta per tutte, ma mobili e simbiotiche, in quanto costituite di materia porosa e predisposta alla trasmissione e allo scambio. Portata all’estremo, una scelta identitaria assoluta conduce all’adozione di logiche di pensiero e di comportamento “totalitarie”, in quanto quello che potremmo definire come un “rischio totalitario” è insito nel concetto di identità, quando interpretato in senso sostanzialistico. Il totalitarismo come regime politico, sul piano ideologico e dell’autorappresentazione, si è sempre richiamato ad un concetto forte di identità, definendo in modo preciso un “noi” identitario, da contrapporre ad “altri” noi, di seguito gerarchizzati e combattuti sia difensivamente sia – più spesso – offensivamente.
Sostiene Remotti che per sfuggire al pericolo di derive violente prodotte dalle logiche identitarie occorrerebbe tenere a mente che «Per loro natura […] i noi sono noi-altri. Di solito, nelle lingue europee questa espressione è utilizzata per segnare ulteriormente la peculiarità e l’esclusività di un noi, il suo contrapporsi agli altri, configurandosi appunto come “altri” nei confronti degli “altri” (il “noialtri” rafforza il senso di identità del noi) […]. [Come a dire quindi che] il noialtri delle lingue europee è un noi-noi. Qui […] vorremmo attribuire all’espressione “noialtri” un diverso significato. Nella sua struttura morfologica l’espressione “noialtri” sarebbe infatti particolarmente adatta per sottolineare non l’esclusività e la contrapposizione, bensì la compresenza e l’intreccio intimo tra le due componenti, quella del “noi” e quella degli “altri”» (pp.49-50).
Sul nesso ricerca-rivendicazione identitaria e violenza, Francesco Remotti scrive alcune pagine davvero illuminanti, con cui concludiamo queste riflessioni sull’odierna ossessione identitaria.
In qualunque contesto o livello si posizioni, ogni noi comporta un qualche grado di violenza dovuto alla distinzione originaria, al gesto di separazione che lo costituisce e lo fa esistere. Ma la rivendicazione dell’identità è un sovrappiù di violenza; è un trasformare la separazione da gesto momentaneo, parziale, provvisorio, revocabile e rimediabile, in una situazione definitiva, permanente, bloccata, irrimediabile. Senza l’ossessione dell’identità, i noi, mentre si separano, si congiungono agli altri: sono noi e altri insieme. L’affermazione dell’identità sottrae invece il noi alle sue implicazioni con l’alterità: invocando l’identità i noi si purificano delle scorie dell’alterità al loro interno e assumono verso l’esterno, verso gli altri, un atteggiamento di radicale, essenziale estraneità. Con l’identità i noi si trasformano in isole, in fortezze, e si armano. Con l’identità i noi sono, divengono o pretendono di diventare “solo noi”, o meglio vogliono essere solo se stessi (A=A) (p. 48).
L’identità è quindi una strategia di difesa, anzi di iper-difesa, cieca ed eccessiva; ma proprio per questo è anche una strategia assai pericolosa, in quanto aumenta a dismisura i pericoli dell’alterazione. […] I “noi” interessati alla propria identità sono molto irritabili, suscettibili e quindi reattivi. I “noi” senza identità […] sono invece molto più tolleranti e molto più disponibili al mutamento […]. In conclusione, i “noi” ossessionati dall’identità sono assai più fragili, e proprio per questo assai più terribili. L’identità infatti non è soltanto una strategia di difesa: fomenta anche strategie di offesa. Ci vuole poco che dalla preoccupazione della propria integrità, dal senso di minaccia per la propria “purezza”, si passi ad una concezione dell’”altro” come un “nemico”, null’altro che un nemico. […] La “fine” dell’altro è la conclusione contenuta fin dall’inizio nella logica dell’identità. […] Fino a che i noi mantengono una certa distanza – una distanza di sicurezza, potremmo dire – rispetto all’ideologia dell’identità, si può sperare che essi non scivolino fino in fondo nel baratro della disumanizzazione dell’altro. Ma se le risorse (materiali e soprattutto culturali) a disposizione dei noi si riducono drasticamente, vi è da aspettarsi che la logica dell’identità invada la mente e il comportamento dei noi. Da questa logica i noi traggono motivi di massima solidarietà interna […] e nello stesso tempo da questa logica i noi sono condotti alla distruzione dell’altro, avendo come obiettivo la soluzione finale: eliminare definitivamente l’altro, affinché finalmente non vi siano più minacce per il noi. La storia del Novecento in Europa e altrove (dalla Germania nazista alle guerre dell’ex Jugoslavia, ai massacri del Rwanda) è una dimostrazione di questa tesi (pp. 98-99).
Per evitare questi rischi e per concludere con un auspicio propositivo, quanto mai adeguate risultano infine queste parole:
Se c’è un rapporto di identità che davvero può essere affermato, paradossalmente questo non è con se stessi, ma con l’alterità. Non solo, dunque, “je est un autre” (Rimbaud): “io è un altro”, ma anche “noi siamo gli altri”. Che lo vogliamo o no, che ne siamo consapevoli o meno, noi siamo inevitabilmente noialtri (p. 50).



