di Fabio Ciabatti
 Alessio Gagliardi, Il 77 tra storia e memoria, manifestolibri, 2017, pp. 128, € 12,00.
Alessio Gagliardi, Il 77 tra storia e memoria, manifestolibri, 2017, pp. 128, € 12,00.
E se il movimento del ’77 avesse lavorato per il re di Prussia? Se quella generazione di giovani militanti contrapponendosi frontalmente alla cultura, ai valori e alle pratiche della sinistra storica in nome di un altro tipo di comunismo non avesse fatto altro che aprire la strada ai modelli individualistici e consumistici che si sarebbero affermati definitivamente negli anni successivi? È questa una delle possibili chiavi interpretative del ’77 che, attraverso la rassegna di testimonianze e studi storici, emerge dal breve ma denso volume di Alessio Gagliardi, Il 77 tra storia e memoria. Nel libro affiorano molte altre tematiche. Tra le più significative c’è la negazione dell’idea che si possa tirare una netta linea di separazione tra la cosiddetta ala creativa del movimento e quella violenta. Però, dal mio punto di vista, la domanda iniziale pone forse la questione più inquietante. Rispondere affermativamente significherebbe dare ragione a uno dei mantra dei nostri tempi, formulato con esemplare chiarezza da Margaret Thatcher poco tempo dopo le vicende qui considerate: “there is no alternative”. Se anche chi voleva fare la rivoluzione ha finito per favorire l’affermazione dell’ideologia neoliberista, quale speranza può rimanere per pensare un cambiamento radicale?
“Non abbiamo né passato né futuro. La storia ci uccide”1 si leggeva su un muro dell’università di Roma. Uno slogan che sembra consegnarci a un eterno presente, in pieno mood postmoderno. Eppure la superficiale ilarità che contraddistingue il postmoderno non appartiene al ’77. “Siamo ironici, non siamo felici”2 dice un indiano metropolitano citato nel testo. Le metafore della festa e del carnevale, utilizzate per interpretare il movimento, ci ricorda Gagliardi, non indicano atteggiamenti di semplice gioia e spensieratezza, ma esprimono la partecipazione collettiva priva di gerarchie, la sospensione del tempo, il rovesciamento della serietà politica tradizionale.
È l’idea stessa di conflitto politico che assume connotati carnascialeschi dal momento che, sostiene l’autore, esso sembra conoscere solo il qui e ora e non la lineare e razionale evoluzione dei tempi e della storia. La fiducia nel futuro è completamente assente in una generazione che assiste all’esaurirsi del ciclo di crescita post-bellico. Viene meno l’idea di rivoluzione come città futura. Il conflitto è imperniato sull’affermazione del desiderio e sull’appropriazione immediata. Appropriazione di beni e servizi, attraverso autoriduzioni, occupazioni e espropri proletari, ma anche di rapporti umani e dei tempi della vita, come testimonia l’idea del personale che è politico. Non si tratta di conquistare lo stato, ma di attuare la rivoluzione nella società, costringendo semmai i poteri costituiti (stato e capitale) ad adeguarsi ai nuovi rapporti di forza, ad arretrare. Più microfisica del potere di Foucault che lotta di classe di Marx. Più liberazione che uguaglianza.
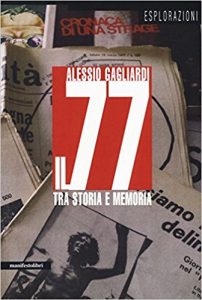 La differenza culturale, comportamentale e antropologica con il tradizionale militante di sinistra è abissale, segnala l’autore. Il Pci e il sindacato sono considerati l’emblema dell’ascetismo rosso, cioè dell’abnegazione del militante a tempo pieno, dell’etica del lavoro, del primato della ragione sul corpo e sui desideri, del culto del collettivo a discapito dell’individualità, della subordinazione del presente al futuro. Lo scontro è frontale. Una simile distanza si riscontra anche nei confronti delle Brigate Rosse, la principale organizzazione clandestina. Ciò non toglie tuttavia che si siano registrate alcune esperienze diffuse, per quanto minoritarie, di cosiddetto “terrorismo movimentista”, di cui Prima Linea rappresenta l’esempio più importante.
La differenza culturale, comportamentale e antropologica con il tradizionale militante di sinistra è abissale, segnala l’autore. Il Pci e il sindacato sono considerati l’emblema dell’ascetismo rosso, cioè dell’abnegazione del militante a tempo pieno, dell’etica del lavoro, del primato della ragione sul corpo e sui desideri, del culto del collettivo a discapito dell’individualità, della subordinazione del presente al futuro. Lo scontro è frontale. Una simile distanza si riscontra anche nei confronti delle Brigate Rosse, la principale organizzazione clandestina. Ciò non toglie tuttavia che si siano registrate alcune esperienze diffuse, per quanto minoritarie, di cosiddetto “terrorismo movimentista”, di cui Prima Linea rappresenta l’esempio più importante.
Il ’77, sottolinea Gagliardi, pur professandosi interno a una prospettiva comunista si mostra sempre meno legato a una cultura e a un linguaggio di classe. Nonostante il persistere di una certa retorica, la centralità operaia e l’idea canonica della classe appaiono sempre meno centrali nelle rappresentazioni di una parte consistente della gioventù rivoluzionaria. Cambia rapidamente il rapporto tra giovani generazioni e lavoro, non solo tra i non garantiti e marginali, ma anche tra i giovani operai inseriti in un rapporto di lavoro “classico”. Dal lavoro come fonte di appagamento e di identità si passa al rifiuto del lavoro.
Tutto ciò sarebbe incomprensibile se, come sottolinea l’autore, non si collocasse il ’77 nel contesto della profonda trasformazione che attraversa l’Italia di quegli anni: esaurimento della parabola fordista e del ciclo di sviluppo postbellico, crisi delle politiche d’inclusione, crescita della disoccupazione, in particolare quella giovanile, nascita del fenomeno del lavoro precario, diminuzione dell’occupazione nelle grandi fabbriche, processi di ristrutturazione tecnologica e organizzativa, d’esternalizzazione e di terziarizzazione. Come recita una scritta apparsa sui muri delle università occupate: “Come il 68? No ora c’è la crisi”.3 A partire a questo contesto il ‘77 è un’esperienza con marcato carattere generazionale che portava in primo piano, accanto agli universitari, i giovani delle periferie urbane che si percepiscono come destinati a un futuro di marginalità.
Possiamo così capire le condizioni storiche che rendono possibile l’affermazione nel movimento di un universo simbolico e pratico che contribuisce a destrutturare i valori collettivi e comunitari tipici della tradizione comunista. Ma ciò non significa ridurre il ’77 a mero sintomo dei tempi che cambiano, perché se il movimento utilizza in certa misura le parole peculiari dello spirito del tempo, lo fa a modo suo, traducendole in termini politici antagonisti, ci ricorda Gagliardi. Se il movimento esprime una totale estraneità e contrapposizione verso la politica istituzionale, tutto ciò non si traduce in una rinuncia alla politica. C’è al tempo stesso un fenomeno di iperpoliticizzazione e di fuga dalla militanza, un tentativo di invadere l’arena politica e contemporaneamente di rifiutarne i linguaggi. Se nel rifiuto della logica dei sacrifici e dell’austerità si afferma l’irriducibilità dell’individuo e dei suoi desideri a qualsiasi logica macrosociale, per il ’77 la realizzazione dei bisogni rimanda ancora a una dimensione comunitaria.
Provando a resistere ai processi di depoliticizzazione e di privatizzazione, il ’77 rappresenta un tentativo estremo di pensare che felicità pubblica e privata possano arricchirsi reciprocamente al di fuori delle logiche di mercato, attraverso un allargamento della partecipazione orizzontale. Da questo punto di vista il ‘77 appare all’autore “più che prefigurazione del nostro presente, una storia del passato; più che un evento capace di anticipare quello che sarebbe venuto, l’emblema di una sconfitta”.4
Per tutti questi motivi il lascito del ‘77 non consiste nell’aver alimentato consumismo e individualismo, ma nell’aver “costituito di fatto un momento nel quale la crisi di vecchi paradigmi culturali e politici incontra l’emergere di nuove traiettorie culturali, sensibilità, linguaggi e forme d’azione”.5 Da lì nasce l’inedita politicizzazione di sfere come la famiglia, la salute, l’alimentazione, la sessualità e il corpo; da quell’esperienza collettiva emergono i nuovi movimenti antinucleari, per la pace e la difesa dell’ambiente.
Se questo è il consuntivo in sede storica, in una prospettiva più strettamente politica vorrei formulare alcuni interrogativi. Se la centralità operaia stava venendo meno, lo slancio rivoluzionario del ’77 sarebbe stato pensabile senza la recentissima memoria della forza antagonistica dell’operaio massa? Era stato proprio quel segmento di classe a mostrare con i fatti che ribellarsi non era solo giusto, ma anche fattibile. Ora che quella memoria si è affievolita, che non appartiene più all’immaginario collettivo, è possibile pensare una nuova insorgenza di massa senza che, in qualche forma, certamente non identica al passato, si affermi una nuova centralità di qualche segmento di classe? E se questa nuova centralità non può darsi certo per scontata, a fronte della locomotiva della storia che sembra viaggiare a tutta velocità verso il baratro, si può rimandare una sperimentazione organizzativa in grado di costituire una massa critica minima senza dare per scontata quella spontanea capacità aggregativa che affondava le sue radici in condizioni storiche, almeno a livello di immaginario collettivo, oramai tramontate? In questa prospettiva è possibile, oltre che auspicabile, riproporre vecchie modalità di impegno politico che non tengano conto delle acquisizioni del ‘77 quanto a rapporto tra collettivo e individuo? Si può far tesoro del rifiuto della politica istituzionale, nato nel ’77 e cresciuto sempre più negli anni successivi, sforzandosi di coniugarlo nel lessico marxiano della critica della politica piuttosto che limitarsi a riprodurre un astratto anti-isitituzionalismo che fossilizza comportamenti del passato?
“Non abbiamo più niente, compagni, siamo orfani” si legge nella prima pagina di Lotta continua del 31 dicembre 1977. Dopo aver letto il libro di Gagliardi questa affermazione non dovrebbe sorprendere. Il ’77 è il primo movimento che si confronta con le condizioni della politica contemporanea e in particolare con l’indebolimento delle identità collettive di classe; è forse l’ultimo movimento occidentale di ampia portata con un’esplicita vocazione rivoluzionaria. Per questi motivi quelle vicende, nel bene e nel male, hanno ancora rilevanza per il nostro presente. Il movimento del ’77 è stato sconfitto. Si tratta ora di riscattare il generoso impegno di una generazione che ha lottato in condizioni improbe, così come di tutte le generazioni passate che hanno lottato, partendo proprio dall’ineludibile assunzione di quella sconfitta.



