di Gioacchino Toni
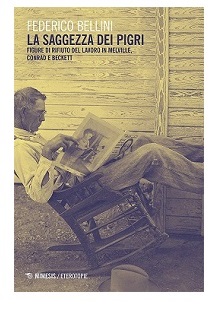 Federico Bellini, La saggezza dei pigri. Figure di rifiuto del lavoro in Melville, Conrad e Beckett, Mimesis, Milano-Udine, 2017, pp. 204, € 18,00
Federico Bellini, La saggezza dei pigri. Figure di rifiuto del lavoro in Melville, Conrad e Beckett, Mimesis, Milano-Udine, 2017, pp. 204, € 18,00
«Colui che non agisce, in mezzo al mondo di coloro che invece fanno dell’azione il senso della loro vita, diventa l’oggetto estraneo, il negativo assoluto che deve essere rigettato, colui per il quale non c’è posto: allo stesso tempo, egli è colui con il quale tutti hanno a che fare in quanto testimonianza di quella passività da cui tutti veniamo e verso la quale tutti siamo destinati a tornare» (p. 176).
Federico Bellini nel suo saggio analizza pagine di resistenza all’egemonia dell’azione scritte da autori come Herman Melville (Bartleby, 1853), Joseph Conrad (The Nigger of the “Narcissus”, 1897) e Samuel Beckett (Murphy, 1938). Ad accomunare i personaggi attorno ai quali i tre grandi scrittori costruiscono le loro opere – Bartleby, James Wait e Murphy – è, seppure in modalità differenti, il non lavoro. Il mite impiegato Bartleby di cui racconta Melville inizia improvvisamente a rifiutarsi di assolvere alle mansioni d’ufficio: di punto in bianco “preferirei di no” diviene la sua risposta automatica alle richieste che gli vengono fatte. Il marinaio James Wait, originario delle Indie Occidentali, di cui ci racconta Conrad, è reso pigro dalla malattia che lo condurrà alla morte prima di sbarcare dopo un lungo viaggio in cui l’intera ciurma si prodiga per sostenerlo. Il giovane perdigiorno Murphy di origini irlandesi che vive nel sud ovest londinese narrato da Beckett, è alle prese con una serie di nevrosi che gli impediscono l’azione e lo isolano dal resto della società. Attraverso tali personaggi letterari che si rifiutano di lavorare i tre scrittori riescono a dare corpo a uno sguardo alternativo sulla loro epoca, su quella fetta di modernità, che grossomodo copre la seconda metà dell’Ottocento, costruita sull’egemonia dell’azione, del fare e del trasformare.
Scrive Giovanna Borradori nella Prefazione del volume che intrecciando l’analisi dei personaggi creati dai tre grandi scrittori, La saggezza dei pigri invita il lettore a «immaginare tre distinte possibilità di quello che potrebbe succedere se ci lasciassimo alle spalle l’ansia di plasmare il nostro circostante, per usarlo e trasformarlo» (p. 14). Bellini «ci fa scoprire […] come il livello simbolico che innerva e accomuna le narrazioni di Melville, Conrad e Beckett catapulti ciascuno dei loro eroi fuori dal solco della modernità: ovvero fuori dallo spazio in cui l’umano, attraverso quell’azione orientata alla produzione che è il lavoro, non solo stabilisce la propria funzionalità sociale ed economica, ma afferma il proprio senso della vita» (p. 14). Dunque, Borradori invita a leggere La saggezza dei pigri «a partire da una riflessione su almeno tre domande chiave dell’orizzonte neoliberalista che ci forza a interrogarci sul senso del fare anche al di là del lavoro, almeno come l’abbiamo concepito a partire dalle rivoluzioni industriali che hanno contraddistinto la modernità: in che senso l’essere umano è capitalizzabile? Che cosa sta dietro all’incessante esortazione di investire su noi stessi? E da ultimo, è possibile disinvestire nel capitale umano, soprattutto quando si tratta del proprio? » (p. 17). In effetti, a ben guardare, le pagine passate in rassegna da Bellini sembrano esplorare «un aspetto importante della condizione contemporanea della precarietà, che è il non-lavoro» (p. 17).
Seppure, per dirla con le parole di Marcel Mauss, il lavoro è il «fatto sociale totale» della civiltà moderna occidentale, l’idea di lavoro ed il suo statuto, ricorda Bellini, sono variati nel corso della storia. Ricostruendo sommariamente le tappe principali di tali trasformazioni, l’autore riprende quanto sostenuto da Dominique Méda (Le travail: une valeur en voie de desparition?, 2010) circa il far coincidere l’inizio del concetto moderno di lavoro con la pubblicazione nel 1776 di An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations di Adam Smith, in cui il lavoro viene pensato come astratto e come unità di misura del valore economico. Al secolo successivo spetta il compito di elevare il lavoro a valore etico rendendolo criterio di giudizio dell’umanità dell’uomo. In Georg Wilhelm Friedrich Hegel il lavoro viene inteso come processo attraverso cui l’essere umano si appropria della natura e realizza la propria essenza. «Lavoro, Arbeit, diventa allora il nome dell’attività dello Spirito stesso, il processo attraverso il quale esso si esplica nel reale e nella storia. Il lavoro trapassa dunque dall’essere unità di misura del valore a essere valore in sé, forma essenziale e generica di sviluppo della coscienza» (p. 20).
Successivamente Karl Marx riporta il lavoro al piano concreto della struttura economica del suo tempo. «Così facendo Marx distingue l’essenza del lavoro come essa si configurava nel pensiero hegeliano […] dallo stato reale del lavoro come si offriva storicamente. La conformazione del lavoro sotto il dominio del capitale conduce infatti agli occhi di Marx a uno stato antitetico rispetto a quello del lavoro considerato secondo la propria verità: al posto di consegnare all’uomo la sua essenza esso gliela nasconde. Nello spazio che si apre fra l’essere e il dover essere del lavoro si colloca la dimensione dell’azione politica cui Marx affida la possibilità di condurre il lavoro verso la propria essenza. Così facendo, anche nella critica alle forme storiche e concrete del lavoro, diventa ancora più cogente l’identificazione che si afferma fra lavoro ed essenza dell’uomo» (pp. 20-21). Michel Foucaut spiega invece come la concezione moderna della malattia mentale sia legata all’etica del lavoro dalle sue origini. Nel corso dell’Ottocento il lavoro finisce per identificarsi con la normalità, dunque con la salute, tanto che esso diventa la cura privilegiata di parecchie malattie. Dunque, «il lavoro nel corso dell’Ottocento viene a identificarsi anche come più alto valore morale, principio antropologico, garante della norma sociale e della salute individuale e fonte di ispirazione estetica» (p. 23).
A fianco di tutto ciò, tuttavia, scrive Bellini, si sviluppa un’altra storia che vede nel lavoro un valore negativo. «Come l’etimo della parola esprime in tutte le principali lingue indoeuropee una dimensione di fatica e sofferenza, così i miti sulla sua origine – dalla cacciata dal Paradiso Terrestre ai vari racconti dell’Età dell’Oro – mostrano il lavoro come una caduta da un primitivo e perduto stato di beatitudine» (p. 23). Si tratta di una lettura negativa del lavoro radicata e diffusa quanto quella positiva e, anche in questo caso, si tratta di un’ostilità storicamente variabile; al variare delle forme, del ruolo e del senso del lavoro, variano altrettanto le forme e i significati del suo rifiuto. «La passività di Diogene il cinico non coincide con l’otium della latinità classica; l’isolamento dell’eremita medievale non ha molto da spartire con il ritiro finalizzato allo studio del De Vita Solitaria del Petrarca; i malinconici rinascimentali hanno poco in comune con i flâneurs che passeggiano per la Parigi “capitale del XIX secolo”» (p. 23).
Se la storia dell’affermazione del lavoro come valore egemonico della cultura occidentale ha una qualche unità, sottolinea Bellini, le voci letterarie, artistiche e filosofiche che hanno reagito ad esso risultano frammentate e disparate. «Diverse e anche opposte intenzioni possono infatti supportare il rifiuto del lavoro: la rivendicazione di privilegi aristocratici, l’edonismo individualistico romantico, l’esaltazione utopica della tecnologia come liberatrice dell’umanità dalla fatica, la nostalgia per la società preindustriale compongono una varietà che non si lascia includere sotto un solo indice o in un’unica genealogia» (pp. 23-24).
Il “diritto alla pigrizia” di Paul Lafargue è ben altra cosa rispetto, ad esempio, dall’esaltazione del rien faire del dandismo; se nel primo caso si auspica un proletariato emancipato dalla logica borghese capitalista nell’indirizzarsi al rifiuto e non al “diritto al lavoro”, nel secondo caso il rifiuto del lavoro ha a che fare con «un altezzoso atteggiamento individualista e nichilista, alieno alle dinamiche di classe e privo di ogni rivendicazione progressista» (p. 24). Altrettanto diverse sono le argomentazioni espresse da Giuseppe Rensi (L’irrazionale. Il lavoro. L’amore, 1923) volte a «dimostrare l’impossibilità di superare il lavoro sebbene “in una vita degna del nome di umana […] non c’è tempo e posto per esso”» da quelle espresse, ad esempio, da Guy Debord e Raoul Vaneigem che si scagliano contro il lavoro considerandolo «un valore borghese e funereo». Se nel caso di Rensi non vi è traccia di un possibile superamento del lavoro, ciò è invece centrale nel «discorso dei situazionisti, i quali ritenevano che una volta liberatisi dalla perversione del lavoro, “l’inversione della creatività”, si sarebbe infine prodotta la rivoluzione che avrebbe condotto la créativité au pouvoir» (p. 25).
Da parte nostra ricordiamo come sull’onda della conflittualità di classe dispiegatasi nel corso degli anni Sessanta e Settanta del Novecento si siano sviluppate modalità di rifiuto del lavoro a partire dal suo esplicito e strategico alludere al diritto all’ozio, derivanti dal riconoscersi della forza-lavoro come variabile indipendente dalla logica del profitto e dai meccanismi del mercato capitalistico. In quella lunga stagione conflittuale il proletariato ha saputo collocarsi ed esprimersi in opposizione al capitale esercitando un ruolo attivo e autonomo nello scontro di classe nella consapevolezza che il conflitto andava giocato attorno al lavoro, sul terreno dei rapporti sociali di produzione e riproduzione.
Il lavoro è il fine stesso (ed è il fine a se stesso) del capitale: lavoro, dunque, in quanto lavoro astratto, valore e capitale, come imposizione illimitata di lavoro e lotta contro di essa […] In quanto lavoro astratto, in quanto lavoro senza qualità e limiti, l’imposizione capitalistica di lavoro abbraccia una dimensione sincronica ed una diacronica. Nel primo caso si parla di valorizzazione del capitale, movimento senza limiti intrinseci della triade denaro-merci-più denaro e, quindi, accumulazione del proletariato ed espansione del rapporto di classe. Nel secondo caso si parla di lavoro che tende a sussumere tutti gli aspetti della vita, sia di quella produttiva che di quella riproduttiva. È chiaro che queste dimensioni prendono forma con caratteri determinati, come risultato di strategie capitalistiche particolari […] L’antagonismo può esprimersi, dunque, sia fra i salariati che fra i non salariati, fra i lavoratori e le lavoratrici delle fabbriche high-tech del Nord, come fra quelli/e dei sweatshops delle zone di esportazione del Sud, fra le lavoratrici della riproduzione della forza-lavoro in un milione di condizioni lavorative diverse, nella fabbrica globale della forza-lavoro, così come fra gli indios od i contadini del Sud del mondo, forzati alla miseria per la produzione di prodotti per l’esportazione, ecc. Checché se ne dica, il lavoro in quanto lavoro capitalistico nelle sue molteplici forme è oggi tutt’altro che marginale. Esso è invece centrale al ciclo complessivo del capitale. Il problema teorico e politico non è tanto quello di optare per una delle due ipotesi sinora delineatesi in merito ad una presunzione di attuale centralità di uno specifico comparto di classe, l’operaio-massa dell’operaismo italiano degli anni ’60 od il lavoratore immateriale degli anni ’90 […] il problema è quello della pluralità dei soggetti antagonistici, è quello della loro reciprocità, all’interno della scala gerarchica sociale, e della/e forma/e della loro generale ricomposizione politica. Lo scontro di classe si gioca a livello mondiale ed investe tutti i rami del lavoro di produzione di merci e di riproduzione della forza-lavoro («Vis-à-vis», n. 1, 1993).
In tale impostazione la categoria del lavoro risulta pertanto centrale nella comprensione del capitalismo e nella formulazione di ipotesi di suo superamento ed è in tale contesto che deve essere intesa quella particolare stagione di rifiuto del lavoro diffuso che ha indubbiamente sue peculiarità che la differenziano da altri rifiuti del lavoro.
Detto di quanto il concetto di lavoro e il suo rifiuto siano storicamente variabili, venendo al campo letterario le rappresentazioni della negazione del lavoro risultano sicuramente assai variegate. «Tuttavia, al fine di proporre una tipologia a maglia larga all’interno della quale tracciare il territorio d’indagine, si può muovere da una generica definizione del lavoro per poi, negandola, definire il suo opposto. Il lavoro, nel senso più generico, è costituito da “ogni attività, manuale o spirituale, con cui l’uomo produce un risultato utile” e quindi dall’instaurarsi di una relazione fra un soggetto e una parte di realtà – fisica o meno – che viene, per mezzo di questa relazione, trasformata. Tale trasformazione, affinché sia prodotto di lavoro e non di un semplice sforzo (come quello compiuto giocando o facendo sport), deve venire riconosciuta dal soggetto stesso e dalla comunità come il frutto della volontà di accrescere di valore il segmento di realtà coinvolto» (pp. 27-28).
A partire da tali presupposti basilari, sostiene Bellini, si possono individuare tre elementi in gioco: «una realtà che viene trasformata; una soggettività cosciente che vi interviene; un’altra soggettività collettiva che riconosce la trasformazione. Nel lavoro il soggetto si rivolge contemporaneamente in due direzioni: verso il reale su cui interviene e verso la collettività alla quale richiede il riconoscimento dell’attività medesima. Ridotto a questi minimi termini, il lavoro si dimostra simile al linguaggio: il luogo in cui l’individuo è messo in relazione contemporaneamente con il mondo e con gli altri uomini per mezzo di segni che attivano una relazione triplice fra realtà, società e soggetto. A ciascuno di questi aspetti corrisponde una funzione della significazione: quella di indicare il mondo e gli oggetti che lo costituiscono; quella di sviluppare un’interazione con gli altri soggetti; quella di permettere al soggetto di esprimersi. Ugualmente il lavoro articola l’esistenza del singolo da un lato in rapporto con il mondo che viene modificato, da un altro in rapporto alla società cui prende parte e in ultimo con se stesso. Eliminando a turno gli elementi che compongono il lavoro sarà ora possibile ottenere una tipologia del non-lavoro» (p. 28).
Interrompendo la relazione con il mondo sociale si ha un soggetto che vuole e può agire sul mondo ma che rifiuta di mettere il proprio sforzo al servizio della società. In tal caso il conflitto si esercita nei confronti della realtà sociale come nel caso dello sciopero. Se ad interrompersi è il lato del mondo condiviso, allora viene meno la necessità di intervenire sulla realtà e si entra in un modello di non lavoro proprio di una supposta “Età dell’Oro” ove si vive senza necessità di faticare. Quando invece è il soggetto a sottrarsi dalla relazione col mondo e la società, continua Bellini, «questo rimane come sospeso al di sopra dei flussi delle forze sociali e materiali» (p. 29). Ed è proprio di questa modalità che si occupa La saggezza dei pigri, dunque di «forme di rifiuto del lavoro che hanno la loro origine non in una protesta nei confronti della società o in una negazione del bisogno di trasformare la realtà, ma nel gesto di un soggetto che si sottrae a entrambe queste dimensioni» (p. 29).
Bartleby di Melville, Il Negro del “Narciso” di Conrad e Murphy di Beckett ruotano attorno a figure che, seppure in modi diversi, rifiutano il lavoro in un momento storico ben preciso, il secondo Ottocento, in cui «come reazione all’affermarsi del lavoro come valore e alle trasformazioni prodotte dalla seconda rivoluzione industriale, le rappresentazioni letterarie di rifiuto del lavoro si moltiplicano e assumono un ruolo sempre più importante e non più limitato a esempio morale negativo o macchietta comica». Ed allora Bartleby di Melville diviene lo specchio di quel mondo caratterizzato dalle grandi e repentine trasformazioni che conducono all’inurbamento e al diffondersi del lavoro burocratico impiegatizio, trasformazioni che «catalizzano l’evoluzione di un ethos nel quale si combinano laboriosità e parsimonia con un atteggiamento di compiaciuto sentimentalismo caritatevole» (p. 30). Nell’opera di Conrad, invece, si ritrovano «le ansie di un’epoca nella quale le rivendicazioni dei lavoratori, l’affermarsi di stili di vita considerati decadenti e i primi segni della crisi del discorso imperialista producono da un lato il vagheggiamento per un ipotetico passato in cui la società era unita nella comunione del lavoro, dall’altro il tentativo di rilanciare per una nuova epoca l’etica vittoriana» (p. 30). In Murphy di Beckett si rintraccia «la moderna scissione della soggettività, lacerata fra un’ingiunzione alla socialità e alla produttività e l’attrazione per gli abissi dell’interiorità» (p. 30). Le tre opere prese in esame da Bellini presentano al contempo «un punto di vista radicalmente individuale e la testimonianza dell’esperienza di un’epoca che, in certa misura, è la nostra» (p. 32).
Questi personaggi non lavoratori si pongono nei confronti della loro epoca come figure enigmatiche irriducibili all’ordine della grande macchina produttiva, come “oggetti inutilizzabili”, per dirla heideggerianamente, e soltanto l’abilità dei grandi scrittori permette di costruire una narrazione ruotante attorno all’inerzia dei personaggi ma, sottolinea lo studioso, occorre anche il contributo del lettore a cui è richiesto un lavoro di interpretazione, tanto che si potrebbe dire che la fatica evitata dal protagonista dell’opera finisce per essere addossata al lettore.
Le figure del rifiuto del lavoro si contrappongono alla moderna visione del mondo per la quale il lavoro, o in senso più essenziale l’azione […], è alla radice del senso dell’esistenza. Contro tale visione esse presentano realtà umane ricondotte per mezzo della negazione dell’agire alla loro dimensione minimale, al loro grado zero […] Lo stato elementare che si annuncia nella passività del non lavoratore è una riduzione della soggettività moderna ai suoi minimi termini, in cui contemporaneamente si manifesta la forma essenziale di tale soggetto e un’istanza di resistenza a esso. Allontanandosi dal lavoro si crea una distanza da cui valutarlo e questo arretrare non è un’opposizione, ma l’apertura di uno spazio di possibilità, di un diverso modo di relazionarsi col mondo. Nel non lavoratore emerge una dimensione primitiva dell’essere umano che è la sua dimensione infantile, nella quale si coniugano strettamente l’essere “in potenza” e l’essere “im-potenza”, la più ampia possibilità e la più radicale fragilità: a partire da questo nodo paradossale si può valutare in che senso i nostri eroi realizzino il loro essere “soggetti rotti” (p. 167).
Con la passività di Bartleby saltano le certezze in favore di una “logica della preferenza” che si presenta come apertura a un indistinto possibile e che finisce col rovesciarsi in una statica impossibilità. «Così, il non preferire di Bartleby, puro conato di una possibilità che mai si realizza, si rovescia e finisce per coincidere con il suo contrario, con la possibilità consumata, col tentativo fallito, con l’occasione sprecata» (p. 168).
In Murphy il «silenzio della potenzialità corrisponde al rinchiudersi nello spazio autistico e mortifero dell’impossibilità, dell’incapacità, dell’inattività del corpo morto» (p. 168). In Wait «è l’impotenza esibita del marinaio la fonte del suo potere di seduzione nei confronti del resto della ciurma e il catalizzatore delle potenzialità di rivolta e messa in discussione dei rapporti di potere. Allo stesso tempo, questa esibizione di impotenza viene attratta in un doppio meccanismo di simulazione, di finzione della simulazione o di finzione al quadrato, nel quale la potenzialità inganna se stessa in un gioco di specchi» (pp. 168-169).
Pertanto, alle diverse modalità con cui questi personaggi del non lavoro «attraversano la dimensione del possibile, dunque – la logica della preferenza di Bartleby, la chiusura nel piccolo mondo di Murphy, la finzione al quadrato di Wait – corrispondono tre modi del suo decadere in impotenza: l’irrigidimento minerale, la dispersione magmatica, la dissoluzione in simulacri» (p. 169).
Dalle rappresentazioni di individui caratterizzati dal calo o dalla perdita delle loro funzionalità sembra emergere una dimensione dell’umano solitamente repressa nella cultura moderna «fondata sull’utilizzabilità e sull’utile», sulla «razionalità funzionale». Questi esseri umani non lavoratori, non funzionali, finiscono per essere trascinati all’interno di quel magma di oggetti dismessi nella letteratura moderna di cui si è occupato Francesco Orlando (Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura: Rovine, reliquie, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, 1993).
Se questo represso “antifunzionale” viene a galla attraverso l’infittirsi di riferimenti alle molteplici forme del decadimento e del disuso nella letteratura, altrettanto potrà dirsi delle rappresentazioni del non lavoro. Il non lavoratore infatti assorbe e soggettivizza quanto nell’oggetto desueto si dà in forma oggettiva e oggettuale; il gesto con il quale schiva il lavoro rende non funzionale tutto quanto lo circonda, spogliando ogni cosa del suo essere mezzo in vista di un fine e considerandola, per tornare al gergo heideggeriano, nella sua “semplice-presenza”. Lasciando così che gli oggetti si svuotino della loro funzionalità e si perdano in un’universale decrepitezza, il rifiuto del lavoro trascina fra essi il soggetto, che rinuncia a ravvivarli con la propria attività: è quindi il non lavoratore stesso che si configura come “oggetto desueto”, uomo che ha cessato di servire la grande macchina del lavoro e della sua ideologia (pp. 169-170).
Bellini si sofferma anche sul rapporto tra scrittura e non lavoro a partire dalle possibili analogie tra le modalità con cui gli scrittori si specchiano nei loro personaggi e la tendenza romantica di cui parla Jean Starobinski (Portrait de l’artiste en saltimbanque, 2004) di vedere l’artista come un saltimbanco. Seguendo la linea tracciata da Georges Bataille, che vuole lo scrivere come opposto del lavorare, emergerebbe fra scrittori e non lavoratori «un’affinità profonda, una solidarietà radicale, che consiste in uno stesso modo di venerare e celebrare la vita in ciò che ha di più umile e prezioso, nel suo esporsi come esistenza nuda al di fuori di ogni produzione e produttività» (p. 189).



