di Franco Pezzini
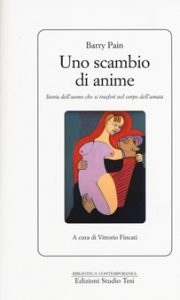 Barry Pain (1864-1928) gode ai suoi tempi di una certa notorietà, grazie a una ricca produzione narrativa all’insegna dell’ironia e talvolta del fantastico – una sessantina di opere tra il 1889 e il 1927, un paio delle quali a monte di recenti trasposizioni BBC –, alla stabile collaborazione a una rivista letteraria d’eccellenza quale ‘Granta’ e comunque a un’attività di giornalista per varie testate (redattore di ‘Daily Chronicle’ e ‘Black and White’, contributore di ‘Punch’ e ‘The Speaker’). A scoprirlo è Stevenson, che lo paragona nientemeno che a Maupassant, e caro amico di Pain è il poeta, narratore e drammaturgo Alfred Noyes. Ottima cosa quindi che la romana Studio Tesi abbia proposto nel 2015 a cura di Vittorio Fincati il gioiellino fantastico “Uno scambio di anime” (“An Exchange of Souls”, 1911): una storia la cui ricchezza guarda ben oltre la suggestione occultista alla base.
Barry Pain (1864-1928) gode ai suoi tempi di una certa notorietà, grazie a una ricca produzione narrativa all’insegna dell’ironia e talvolta del fantastico – una sessantina di opere tra il 1889 e il 1927, un paio delle quali a monte di recenti trasposizioni BBC –, alla stabile collaborazione a una rivista letteraria d’eccellenza quale ‘Granta’ e comunque a un’attività di giornalista per varie testate (redattore di ‘Daily Chronicle’ e ‘Black and White’, contributore di ‘Punch’ e ‘The Speaker’). A scoprirlo è Stevenson, che lo paragona nientemeno che a Maupassant, e caro amico di Pain è il poeta, narratore e drammaturgo Alfred Noyes. Ottima cosa quindi che la romana Studio Tesi abbia proposto nel 2015 a cura di Vittorio Fincati il gioiellino fantastico “Uno scambio di anime” (“An Exchange of Souls”, 1911): una storia la cui ricchezza guarda ben oltre la suggestione occultista alla base.
Non è incongrua l’ipotesi che l’opera possa ispirare una ventina d’anni dopo un racconto celebre come “The Thing on the Doorstep” (1933/1937) di quel Lovecraft che tanto ama i giochi d’atmosfera e gli spunti fantastici autenticamente fertili (qui può coglierne uno brillante e un po’ disturbante) quanto invece è infastidito dai tecnicismi esoterici. Ma l’ombra di un ricordo potrebbe ravvisarsi anche nella mostruosa compenetrazione identitaria del finale di un altro testo lovecraftiano un po’ precedente, “The Mound” (1929-30/1940): ed è interessante notare che si tratta di due tra i pochissimi casi di opere di Lovecraft con ruoli femminili di qualche rilievo.
Comunque spoileriamo pure, perché la sorpresa del testo di Pain non sta neppure nella trama – denunciata fin dal sottotitolo, “Storia dell’uomo che si trasferì nel corpo dell’amata” – ma nella godibilità del registro narrativo, nei siparietti anche ironici e nella sottile inquietudine che a un tratto monta, a far trascolorare la commedia bizzarra in un crepuscolo spettrale. Oltre che nella libera rilettura di suggestioni fantastiche e maschere d’epoca, e che pare macchinata apposta a spingere il lettore alla ricerca di proprie chiavi interpretative. Se ne azzarda qualcuna, con la coscienza che si tratta di spunti apertissimi anche al di là di precise “intenzioni” dall’autore.
A partire da quelli legati ai personaggi. Così al britannicissimo e prosaico io narrante Compton, che lo incontra a Parigi nel 1905, il dottor Daniel Myas appare all’inizio un provocatore decadente a metà tra Oscar Wilde (morto a Parigi, rammentiamo, nel 1900) e Aleister Crowley (al tempo invece attivissimo, e che a Parigi è stato a più riprese nei primi anni del secolo): un genio raffinato e supponente, spregiudicato e amante dei paradossi, avversatissimo dall’establishment scientifico per le sue tesi poco ortodosse, e che in effetti si rivelerà in prosieguo una sorta di Jekyll riveduto e corretto (il racconto di Stevenson – morto per inciso nel 1894 – era del 1886, idealmente un altro mondo). Certo, rispetto allo “Strange Case” che forse omaggia, il meccanismo qui sembra un po’ diverso: l’alterità della mutazione non sta nell’emersione imprevista di un groppo di Male rimosso dal perbenismo vittoriano, ma nella preparatissima trasmigrazione dell’identità di Myas in un corpo femminile, quello della devota moglie/vittima Alice Lade (il riferimento all’amata nel sottotitolo va letto in termini un po’ elastici). Inevitabile ricordare uno dei film più iconoclasti della casa Hammer, quel “Dr. Jekyll and Sister Hyde” di Roy Ward Baker (in Italia “Barbara, il mostro di Londra”, 1971), dove il dottore si muta appunto in donna pericolosa, un Jack the Ripper al femminile come la Jill talora ipotizzata per Whitechapel: ma la soluzione di Pain risulta insieme più morbida e più disturbante.
In effetti il gioco onomastico Hyde/Lade (“nascondere”/“caricare”?) finisce col provocare a tutto campo: sia sul ruolo della donna negli anni che vedono farsi più accanita in Inghilterra la battaglia sul suffragio femminile, con le aspiranti pari all’uomo (ecco la compenetrazione?) in sciopero della fame forzate all’alimentazione attraverso metodi non meno orrendi  di quelli sperimentali qui in scena; sia su una dinamica sociale di identità che impone angosciosi, continui nascondimenti. Si pensi alla falsa Alice costretta a fingersi uomo, diventando in qualche modo una terza persona cangiante, in un trascolorare progressivo d’identità (perché il corpo con le sue facoltà sembra piegarsi nell’osmosi tra l’una e l’altra identità, trattenere qualcosa di ciascuna, mixarle orribilmente): una condizione che soltanto post mortem sembrerà alla fine risolversi, gradualmente e forse solo con l’avvicinarsi della morte anche del testimone/interfaccia Compton. Ma si pensi anche ai dubbi su una qualche ambiguità dello stesso Myas, a quelle sue mani “un po’ troppo bianche e curate” e alla sua unione di convenienza/copertura con la pur graziosa Alice, quasi a nascondere identità/orientamenti e magari (orrore) pratiche sanzionabili come nel caso Wilde. Se poi flirta con l’enigmistica il gioco tetragrammatico dei due nomi (Myas come Lade, quattro lettere con due vocali) ci si può chiedere se un indizio di ambiguità identitaria non riposi già nel nome dell’(anti)eroe, a reclamarne una propria (“My”) e insieme a suggerirla condizionata relazionalmente (“as”).
di quelli sperimentali qui in scena; sia su una dinamica sociale di identità che impone angosciosi, continui nascondimenti. Si pensi alla falsa Alice costretta a fingersi uomo, diventando in qualche modo una terza persona cangiante, in un trascolorare progressivo d’identità (perché il corpo con le sue facoltà sembra piegarsi nell’osmosi tra l’una e l’altra identità, trattenere qualcosa di ciascuna, mixarle orribilmente): una condizione che soltanto post mortem sembrerà alla fine risolversi, gradualmente e forse solo con l’avvicinarsi della morte anche del testimone/interfaccia Compton. Ma si pensi anche ai dubbi su una qualche ambiguità dello stesso Myas, a quelle sue mani “un po’ troppo bianche e curate” e alla sua unione di convenienza/copertura con la pur graziosa Alice, quasi a nascondere identità/orientamenti e magari (orrore) pratiche sanzionabili come nel caso Wilde. Se poi flirta con l’enigmistica il gioco tetragrammatico dei due nomi (Myas come Lade, quattro lettere con due vocali) ci si può chiedere se un indizio di ambiguità identitaria non riposi già nel nome dell’(anti)eroe, a reclamarne una propria (“My”) e insieme a suggerirla condizionata relazionalmente (“as”).
Fincati è molto interessato ai retroscena esoterici, e opportunamente cita tecniche e opere (precedenti e successive) in tema di magia trasmigratoria: la disamina offerta è ricca, erudita e suggestiva. Non è però per pedanteria che sembra opportuno aggiungere a quell’elenco un testo che riconduce alla stessa Inghilterra del primo Novecento e a un clima d’ambiente almeno simile, cioè il racconto “The Subletting of the Mansion” della narratrice-occultista Dion Fortune (di quella saga del dottor Taverner articolata nel 1922, e più tardi raccolta in “The Secrets of Dr. Taverner”, 1926). In entrambi i testi troviamo in scena un po’ di goffaggine, una dinamica chimica (in Pain esperimenti pericolosi col cloridrato di etile, in Fortune overdosi da droga), un marito che si cura poco della moglie (ma in Fortune non è lo sperimentatore, bensì il tossicodipendente che trova il proprio corpo occupato dall’altro), una situazione penosa che si protrae dopo la morte, nonché il solito testimone frastornato (Rhodes l’assistente di Taverner, come Compton estraneo all’orizzonte esoterico).
Ora, se il tema dell’identità costituisce una sorta di ossessione letteraria lungo tutto l’arco dell’epoca vittoriana (pensiamo solo alla sensation novel), in forme sempre più clamorose, in queste testimonianze ne cogliamo le trasformazioni ultime, già imbevute dei dubbi del Novecento; e del resto proprio Dion Fortune, coi suoi studi di psicologia e psicanalisi e i tentativi di sposare la tradizione ermetica alle moderne scienze umane (Freud, Jung) testimonia che il quadro sta cambiando.
Compton stesso argomenta del resto che una persona può conoscere per vie ordinarie una profonda modifica di personalità (a proposito di un impagabile personaggio, il dottor Vulsame, che da alcolista diventa militante dell’Esercito della Salvezza, sia pure senza perdere spiacevolezza); e lui stesso al termine dell’avventura si ritrova mutato parecchio rispetto all’uomo dell’incontro parigino del 1905. A fronte poi dell’ipotesi razionalista della doppia identità avanzatagli dall’amico dottor Habaden – Alice Lade crederebbe di ospitare in sé quella dell’ammiratissimo coniuge morto – e guardata da Compton con una certa avversione, resta da chiedersi se questo sia un narratore affidabile. Pirandello, potremmo dire, non è lontano. Ma la fecondità del linguaggio fantastico sta nell’imbarazzo che ci resta, nell’impossibilità di una risposta certa, e nel fatto che in fondo quel dubbio dal caso del singolo, sulla sua vera identità sessuale, dilaga a interpellare ansie e insicurezze, pregiudizi e nervi scoperti di un’intera società. Allora come oggi, fino – potremmo dire – agli sbarellamenti reazionari di certi dibattiti su gender & dintorni.



