di Franco Pezzini
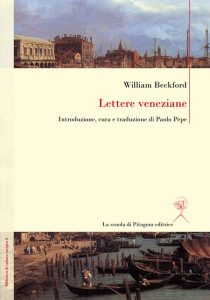 Quello della narrativa di viaggio è un filone illustre, che continua nei secoli a regalare piaceri e a volte veri gioielli: e, a dispetto di ogni banalizzazione sul rapporto con la realtà (colta autopticamente, esperita magati con disagi – pensiamo a quanta polvere e fatica macinassero i viaggiatori nell’età delle carrozze), si tratta di un filone prezioso anche per gli studiosi di immaginario. Se il fantastico non è tanto un contenuto quanto un modo di narrare, un tipo di sguardo, la forma del travelogue offre infiniti spunti: tanto più considerando le prassi epistolari e diaristiche idealmente alla base della scrittura di parecchi maestri del fantastico. Non è tardi dunque per riprendere in mano le “Lettere veneziane” di William Beckford (1760-1844) – autore di quel “Vathek” seminale per tanto immaginario ottocentesco sull’Oriente – raccolte in un prezioso libretto a cura di Paolo Pepe nel 2012 per i tipi dall’editrice napoletana La scuola di Pitagora (pp. 98, € 13): una lettura che a prescindere dall’interesse storico-letterario presenta pagine di pura bellezza e di immaginifica godibilità. Una spigolatura limitata appunto a Venezia, in quel caso tappa iniziale del viaggio in Italia, dalla versione definitiva dell’ampio travelogue beckfordiano in fittizia forma epistolare “Italy; with Sketches of Spain and Portugal”, 1834, con memorie dal Grand Tour 1780-81, già apparse come “Dreams, Waking Thoughts, and Incidents”, 1783, ma qui profondamente rivedute: una lettura cui il controcanto del testo originale – un inglese visionario ma limpidissimo, godibile anche da chi non lo mastichi d’abitudine – offre maggior respiro.
Quello della narrativa di viaggio è un filone illustre, che continua nei secoli a regalare piaceri e a volte veri gioielli: e, a dispetto di ogni banalizzazione sul rapporto con la realtà (colta autopticamente, esperita magati con disagi – pensiamo a quanta polvere e fatica macinassero i viaggiatori nell’età delle carrozze), si tratta di un filone prezioso anche per gli studiosi di immaginario. Se il fantastico non è tanto un contenuto quanto un modo di narrare, un tipo di sguardo, la forma del travelogue offre infiniti spunti: tanto più considerando le prassi epistolari e diaristiche idealmente alla base della scrittura di parecchi maestri del fantastico. Non è tardi dunque per riprendere in mano le “Lettere veneziane” di William Beckford (1760-1844) – autore di quel “Vathek” seminale per tanto immaginario ottocentesco sull’Oriente – raccolte in un prezioso libretto a cura di Paolo Pepe nel 2012 per i tipi dall’editrice napoletana La scuola di Pitagora (pp. 98, € 13): una lettura che a prescindere dall’interesse storico-letterario presenta pagine di pura bellezza e di immaginifica godibilità. Una spigolatura limitata appunto a Venezia, in quel caso tappa iniziale del viaggio in Italia, dalla versione definitiva dell’ampio travelogue beckfordiano in fittizia forma epistolare “Italy; with Sketches of Spain and Portugal”, 1834, con memorie dal Grand Tour 1780-81, già apparse come “Dreams, Waking Thoughts, and Incidents”, 1783, ma qui profondamente rivedute: una lettura cui il controcanto del testo originale – un inglese visionario ma limpidissimo, godibile anche da chi non lo mastichi d’abitudine – offre maggior respiro.
Pagine che ci comunicano la freschezza di emozioni di questo ventenne geniale e straricco, eccitato e coltissimo, recuperate e rivisitate mezzo secolo dopo da lui stesso ormai vecchio (e confinato nelle sue proprietà da scandali ed eccentricità) ma con gli occhi che sanno ancora brillare. Emozioni come all’arrivo finalmente in vista delle colline dello stato di Venezia, su strade acciottolate, tutto un saltello per la carrozza (31 luglio, Lettera I). William scende, osserva con gli occhi sgranati dalla meraviglia lo sfarfallio colorato degli insetti. Ma risalito a bordo, poco dopo quegli occhi si sbarrano al fascino del Sublime dei “tremendous” passi montani all’ingresso in Italia; e un paio di pagine più tardi li troviamo illuminarsi all’idillio del Bassanese, con la locanda per riposare e le tavolate di viaggiatori festanti da dipinto d’epoca. La varietà di toni è scintillante, e l’emozione di quegli sguardi che ha retto cinquant’anni – e più – tra esili e prigionie dorati, sa varcare i secoli fino a noi.
Del resto le emozioni non interpellano solo gli occhi. Beckford ha un’appassionata sensibilità musicale, e fin da questo arrivo nel territorio della Serenissima, ospite in una villa – possiamo immaginare la scena, il ciangottio, i ventagli – fa conoscenza di gentiluomini fan come lui del “divino castrato” Pacchierotti, uno dei divi del bel canto d’epoca. Che, gli riferiscono (e lui riporta in italiano nel testo) “ha fatto veramente un fanatismo a Padua”: nel senso che (qui invece nella traduzione di Pepe) “una gentildonna, agli struggenti accenti della sua voce, si sentì mancare e quasi morì: martire di tanta melodiosa bellezza”… E anche in prosieguo il tema della musica tornerà con frequenza.
Certo è con l’arrivo a Venezia (2 agosto, Lettera II) che la narrazione s’impenna: la Venezia delle mille finestre illuminate e delle gondole scivolanti sui canali nella musica della sera colta dal balcone della locanda, quella che lo lascia senza parole di fronte alla “varietà di colonnati, cornici, modanature e timpani, alcuni di ispirazione classica, altri di tratto saraceno”, quella sgranata tra cupole, scalinate monumentali, calli e cortili. Leggendo queste pagine è inevitabile cogliere rimandi al folle, geniale “Vathek”: la Venezia qui descritta è in effetti una città fortemente orientale, che non solo brulica di “Asiatics” perfettamente a proprio agio, ma appare una sorta di incredibile caravanserraglio lagunare, con San Marco come “grande moschea” (3 agosto, Lettera III). Ci sono ovviamente le storie nere, e Beckford freme d’indignazione verso le crudeltà della giustizia veneziana che lo richiamano alle fantasie di Piranesi; ma le visioni e gli incontri si susseguono rapidi, in una Grande Bellezza che flirta col sogno. Ora gli pare di dover vedere qualche imperatore di Bisanzio a passeggio col seguito, ora si incuriosisce dell’apatico lappone al servizio dell’erudito signor de Villoison, ora visita le isole, ora registra perplesso nei casini le eccitazioni dei gentiluomini indotte a base di caffeina. Il tutto tra continui richiami a letteratura ed arti ma, senza perdere il sapore originario di travel book settecentesco, ormai sfrondati dell’erudizione libresca della prima versione giovanile, e dispensati con freschezza e sobria trasparenza stilistica.
Poi, come in altri travelogue o in vari romanzi del tempo, ecco il Nostro abbandonare la città per le ville del Brenta e il prosieguo del viaggio. Si congeda dalla Serenissima con versi struggenti di Petrarca, “O giorno, o ora, o ultimo momento…”: e nel segno di questa malinconia cinquant’anni dopo può ben ricordare quella “fatale intimità” con un giovane nobile (non sappiamo se di casato Vendramin o Corner) che a Venezia lo farà tornare. Qualcosa che di quegli scintillii di un’età lontana, sul Canal Grande trasognato di musica, gli resta ora come sul fondo dello sguardo.



