di Giovanni Iozzoli
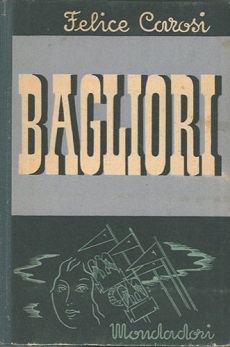 Leggere Bagliori di Felice Carosi (Mondadori, 1941) dà l’effetto straniante di certi racconti di fantascienza, in cui ci si ritrova catapultati in un universo parallelo nel quale persone, eventi e ambientazioni sono identici alla realtà, ma ogni cosa risulta completamente rovesciata di senso. Una sensazione vertiginosa, per il lettore odierno. Questo perché il libro è stato pubblicato nel 1941 ed è una specie di “romanzo di formazione” dedicato all’educazione del giovane fascista, nell’Italia appena entrata dentro la seconda guerra mondiale, piena di criminali illusioni.
Leggere Bagliori di Felice Carosi (Mondadori, 1941) dà l’effetto straniante di certi racconti di fantascienza, in cui ci si ritrova catapultati in un universo parallelo nel quale persone, eventi e ambientazioni sono identici alla realtà, ma ogni cosa risulta completamente rovesciata di senso. Una sensazione vertiginosa, per il lettore odierno. Questo perché il libro è stato pubblicato nel 1941 ed è una specie di “romanzo di formazione” dedicato all’educazione del giovane fascista, nell’Italia appena entrata dentro la seconda guerra mondiale, piena di criminali illusioni.
Potremmo definirlo romanzo ideologico-sentimentale, in cui ogni parte della narrazione è verosimile e racconta scenari storici reali ma il giudizio di valore che offre su di essi è perfettamente sovvertito. I “rivoluzionari” sono i fascisti, gli infami assassini sono i rossi, la rivoluzione fascista è la vera emancipazione dei poveri e degli oppressi. Sì, perché il libro, probabilmente destinato alle diverse agenzie di formazione dei giovani (la collana Mondadori è: “Bibliotechina della G.I.L. – Gioventù Italiana Littorio), puntava a un preciso target di lettore: la gioventù proletaria di recente alfabetizzazione. I ragazzi piccolo borghesi non avrebbero mai potuto identificarsi con il protagonista, un giovane miserabile che fa la fame, figlio di un proletariato rurale che vive di stenti e umiliazioni nelle campagne laziali degli anni ’20. È povero il protagonista, sono poverissimi i suoi amici e il suo ambiente. È ferocemente antipopolare il contesto dell’Italia liberale pre-fascista.
Nell’adolescenza il giovanotto entra in contatto in modo spontaneo con l’attivismo rurale socialista e ne subisce i perfidi inganni: i socialisti sono descritti come ammaliatori dei poveri e degli ignoranti, guidati da intellettuali avidi che non hanno voglia di lavorare e strumentalizzano la miseria per i loro loschi interessi. I rossi sono tutti vigliacchi, attaccano in gruppo, devastano, minacciano – sventrano anche a coltellate un povero somaro, così tanto per ridere. E alla fine organizzano pure un attentato dinamitardo che ammazza per sbaglio la povera madre del protagonista (stragisti turatiani!).
Chiaro che se gli ammazzi la mamma, la fede del giovanotto nel socialismo comincia a vacillare. Appena possibile entra in fabbrica e diventa tornitore provetto. «Da due mesi lavoravo al tornio… non so dire la gioia che mi prese quando il sor Mario, il padrone, mi disse: tu, Berto, domani passi al tornio, se sei bravo non ti muovo più… E ora da una settimana il mio tornio era fermo. Mi attendeva lì ed io non potevo andare da lui. Sciopero generale? E perché… per mangiare a sbafo le giuggiole e lo zucchero nelle botteghe svaligiate?». E lì, davanti alla protervia e all’insensatezza degli scioperi, il protagonista ha la conferma definitiva che i socialisti sono in realtà i veri nemici del popolo (e mangiatori a sbafo di giuggiole). Il ragazzo, pieno di disillusioni, fa la valigia e si trasferisce quindi a Roma.
Il biennio rosso è alle spalle, la marcia su Roma ormai imminente, l’intensità e la violenza dello scontro di classe non vengono taciuti dall’autore. Sul crinale di quegli anni sembrano confrontarsi tre mondi: ferrotranvieri e spazzini scioperati che vogliono la distruzione d’Italia, un manipolo di arditi e coraggiosi, di cui il protagonista aveva solo sentito parlare e che impara a conoscere proprio a Roma come “fascisti”, e poi la gran massa degli ignavi che aspettano solo di capire da che parte buttarsi. Boicottare gli scioperi, sostituire gli scioperanti, tenere aperte le officine e i servizi pubblici, diventa azione politica eminente. «Altri nostri compagni guidavano treni, conducevano trams, adoperavano con santa pazienza il santissimo manganello a rinsavire i traviati e la triplice oncia di olio di ricino per purgare il passato».
L’assalto al quartiere rosso San Lorenzo viene descritto con pathos e crudezza, ma anche qui il giudizio storico è rovesciato: non sono i fascisti ad attaccare il bastione nemico, ma è la gentaglia del quartiere ad attirare in trappola le valorose forze nazionaliste che vogliono solo celebrare la tumulazione di Enrico Toti, facendone sfilare le riverite spoglie in tutta Roma. Dopo i primi scontri, i «vili agguati» dalle finestre di San Lorenzo, le «megere che rovesciano olio bollente e ogni suppellettile sui manifestanti», questi ultimi con eroismo marziale e sprezzo del pericolo espugnano il campo nemico, cioè il Rione.
Qui l’autore non nasconde niente: i giovani devono percepire, attraverso le pagine, la crudezza della lotta. La “battaglia per il riscatto nazionale” è roba di pistolettate e morti ammazzati (e anche qualche megera lancia-olio virilmente defenestrata) .
Per la cronaca, la “battaglia di San Lorenzo” che l’autore celebra, viene invece raccontata in tutt’altro modo dalle fonti opposte dell’epoca: i fascisti si squagliarono, le violenze contro il quartiere vennero perpetrate principalmente dalla Guardia Regia e dai Carabinieri. Comunque, al di là dei miti e delle versioni, quello che l’autore vuole evocare nei giovani lettori di allora è il “sapore acre” della Guerra: l’irriducibile nemicità, la necessità della distruzione dell’avversario disumanizzato – nel ’21 nemico “interno”, venti anni dopo nemico “mondiale”.
Curiosa la storiella sentimentale che si intreccia alla vicenda storico-politica: il poverissimo contadino inurbato è da sempre innamorato della figlia di un ricco proprietario e insegue questo amore impossibile, fortemente idealizzato, fino all’età adulta. Però essendo un romanzo di formazione fascista, questa storia di amore di classe non può contrapporre i ricchi ai poveri, come ci si potrebbe aspettare: il proprietario è un buon borghese, generoso e sensibile, che appoggerà la “rivoluzione nazionale” e prenderà il ragazzo sotto la sua ala protettiva. En passant, la ragazza oggetto di cotanto amore morirà di malattia in quei giorni convulsi – ma intanto s’avanza la Rivoluzione Fascista e (che vuoi mai?) la vita va avanti.
Qualche annotazione, sorge spontanea, per provare a capire bene i dispositivi narrativi del Regime e come ci si aspettava che essi funzionassero nella testa dei ragazzi. Innanzitutto la retorica pauperista, quasi di classe, che ricordavamo all’inizio, indirizza il racconto verso una certa platea, ma funge anche da promemoria sulle ragioni storiche del Fascismo, il suo presentarsi come “raddrizzatore di torti” per i figli negletti della Grande Proletaria.
La storia è lineare, i personaggi espliciti (come si conviene a un libro “educativo”) e nonostante lo stile ampolloso e retorico, naturale in un paese totalmente soggiogato dalla estetica letteraria dannunziana, tutto sommato accurato, leggibile, buono per quell’esercito di “mediatori culturali” (insegnanti, quadri di partito, dirigenti delle organizzazioni giovanili) che dovevano invitare e accompagnare alla lettura i giovanotti in camicia nera, poco avvezzi alla carta stampata.
Altro elemento che salta agli occhi: il libro è stato scritto per ragazzi che sono cresciuti dentro il fascismo-regime, che quindi non hanno memoria del fascismo-movimento, in un paese già imborghesito da quindici anni di potere assoluto di Mussolini – quel potere che sta per spedire al massacro, in Russia o in Africa Orientale, proprio quegli stessi giovani. La narrazione assume quindi una funzione evocativa e ri-evocativa, deve stimolare la memoria “rivoluzionaria” del fascismo (che i giovani non conoscono) e risvegliare il clima di battaglia che inevitabilmente dovranno affrontare. È come se l’autore volesse dire ai giovani del 1940: “attenti, giovanotti, occhio che veniamo da moschetti, squadracce e coltelli, questa è la nostra storia e lì tra un po’ bisognerà tornare, sui teatri di battaglia della Storia. Che sia San Lorenzo o la steppa russa, poco cambia. La vita è Guerra, ragazzi”.
Curiosamente nel libro i “comunisti” praticamente non vengono mai citati e un ragazzo del ’41 che leggesse queste pagine, potrebbe pensare che in Italia non siano mai esistiti. La polemica e l’odio sono tutti riservati al Partito Socialista, dipinto (ancora venti anni dopo!) come una masnada di assatanati bolscevichi, forsennatamente impegnati nella distruzione d’Italia.
Quando il sig. Carosi scrive questo libro – a cavallo tra gli anni ’30-’40 – sono ormai divampate le fiamme della grande tragedia europea. I fascismi stanno rovesciando sull’Europa un fiume di sangue inarrestabile. La macchina della propaganda doveva girare in modo massiccio e questo romanzetto, come migliaia di altri prodotti editoriali, teatrali, filmici, fu uno dei tanti piccoli ingranaggi che fecero girare quella macchina implacabile.
Il libro, insieme ad altri pezzi simili, è l’eredità di un mio parente che raccattò questi esemplari editoriali dentro qualche scuola bombardata o in qualche sede ex-Gil abbandonata. Lui era un esponente storico della dinastia di bidelli-invalidi che accompagnarono gloriosamente il passaggio dalle scuole del Regno a quelle della Repubblica; un lignaggio di bidelli semiparalitici – troneggianti nei corridoi come numi tutelati eternamente seduti, che collezionavano ogni detrito della storia educativa: vecchie lavagne, vecchi registri, vecchi libri destinati all’edificazione della gioventù. Monumenti nullafacenti e un po’ cleptomani, che con la loro sola presenza, provvedevano a smussare ogni marzialità fascista – o autorevolezza democratica – delle nostre istituzioni scolastiche, nell’arco di un secolo.
Dell’autore, non ho trovato grandi notizie biografiche, scrisse qualche altro libro per Mondadori, catalogato come letteratura per ragazzi. Provò col cinema, ma un film bellico alla cui sceneggiatura aveva collaborato, si arenò nel ’43 per le note vicende politiche italiane. Quel nome – Felice Carosi – tornerà a galla nel ’67, quando viene insignito del titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica. Niente di più normale che un intellettuale fascista si riciclasse in qualche commissione Rai o chissà quale altro ente parastatale di cultura e comunicazione. Non scavo ulteriormente per capire se si sta parlando della stessa persona. Pace all’anima sua e amen.



