di Gioacchino Toni
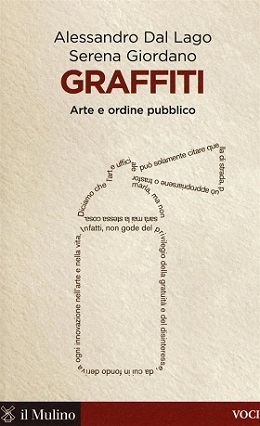 Alessandro Dal Lago e Serena Giordano, Graffiti. Arte e ordine pubblico, Il Mulino, Bologna, 2016, 182 pagine, € 14,00.
Alessandro Dal Lago e Serena Giordano, Graffiti. Arte e ordine pubblico, Il Mulino, Bologna, 2016, 182 pagine, € 14,00.
Le polemiche sorte a proposito della mostra bolognese “Street Art. Banksy & Co. – L’arte allo stato urbano” [sulla vicenda: Wu Ming su Giap e Mauro Baldrati su Carmilla], hanno ormai perso i riflettori e le prime pagine dei media locali e nazionali. Tutto sommato la missione dei media può dirsi compiuta: lo spazio concesso alle polemiche ha avuto i suoi effetti promozionali ed al pubblico, come agli sponsor ed ai “creatori di eventi”, un po’ di polemica piace sempre. Ora i media torneranno a parlare di graffiti solo per celebrare qualche associazione impegnata a ripristinare il candido decoro urbano prevandalico, per promuovere qualche nuova mostra dispensatrice di aura ufficiale o per motivi di ordine pubblico. Difficilmente la questione graffiti urbani potrà uscire da questa trattazione schematica.
Al di là della semplificata e rigida partizione con cui se ne occupano i media, sono davvero così impermeabili l’uno all’altro questi diversi fronti? A ricostruire il quadro della situazione viene in aiuto il saggio di Alessandro Dal Lago e Serena Giordano, Graffiti. Arte e ordine pubblico. In tale volume il fenomeno del graffitismo viene trattato dal punto di vista estetico, sociale e culturale a partire dall’analisi tanto delle motivazioni che muovono i giovani writer ad intervenire sulle mura urbane, sfruttando il buio della notte e giocando a guardie e ladri con l’autorità, quanto quelle del fronte antigraffiti. Da un lato gli autori del testo si preoccupano di palesare le contraddizioni che attraversano i diversi schieramenti che non possono essere ricondotti a soli due soggetti, writer e antiwriter. Dall’altro lato il saggio evidenzia come alcune “categorie di pensiero” tendano a travalicare i diversi fronti in campo. Davvero, come evidenziano i due studiosi, parlare «sui graffiti significa anche e sempre parlare di qualcos’altro che sta a cuore ai parlanti» (p. 19) e se c’è «un fenomeno culturale che illustra a meraviglia il funzionamento tautologico e circolare dei meccanismi sociali in un mondo complesso, si tratta proprio dei graffiti e delle campagne per cancellarli» (p. 153).
Nel Primo capitolo il writing contemporaneo viene collocato all’interno di una lunga tradizione di scrittura ed arte murale. Se la prima è un tipo di espressione che risale ad antiche culture, come quella egizia, le forme di rappresentazione parietale si trovano già nel Paleolitico superiore. Gli autori non intendono proporre improbabili paragoni tra le pitture rupestri preistoriche e le forme contemporanee, ma sottolineare come il gesto di quei lontani antenati costituisca una sorta di universale antropologico. Nelle decorazioni rupestri, in un ambiente collettivo, viene rappresentato il mondo nei suoi aspetti considerati significativi; attraverso quelle pratiche il mondo viene dunque condiviso. Da quando, attorno al XV secolo, l’arte inizia ad essere intesa come espressione individuale, si è via via persa l’idea «dell’attività artistica come opera collettiva, nel doppio senso di qualcosa creato in comune e rivolto a un uso collettivo» (p. 47). Secondo Dal Lago e Giordano, al di là di improbabili altri paragoni, come detto, il writing contemporaneo ha in comune con il graffito rupestre l’idea di dar vita ad una forma di comunicazione pubblica.
Il saggio si sofferma anche sul muralismo messicano che, riprendendo la tradizione figurativa preispanica, palesa forti intenti pedagogici. Tale movimento presenta diverse contraddizioni a proposito del rapporto arte/potere, tanto che dal ruolo sovversivo rivestito nella prima fase della rivoluzione, passa ben presto ad avere un mero ruolo celebrativo una volta che le istituzioni rivoluzionarie si sono stabilizzate. Gli autori mettono in luce come l’ambiguità dei muralisti messicani derivi anche dall’adesione ad un’ideologia progressiva positivistica e questo è proprio uno dei motivi per cui tali artisti esercitano una certa attrazione anche nel capitalismo statunitense. A tal proposito gli autori ricordano come lo stesso Diego Rivera, nel 1931, venga chiamato dall’industriale Ford per illustrare il Detroit Insitute of Art con l’opera Detroit Industry or the Man and the Machine. «L’ambiguità si rivela nella celebrazione del matrimonio tra uomini e macchine proprio nel momento in cui la società americana era attraversata da aspri conflitti tra operai e industriali (si dice che tra i lavoratori che protestavano ci fossero anche i malpagati assistenti di Rivera)» (p. 53).
Nel volume viene ricordato anche come agli albori della pubblicità di massa, le scritte tracciate con la vernice sui muri vengano preferite ai manifesti cartacei, tanto che su diversi edifici statunitensi ed europei risultano ancora visibili le tracce sbiadite di vecchi messaggi commerciali. Ancora oggi nell’Africa, soprattutto sub-shariana, le pubblicità sono spesso dipinte direttamente sulle pareti. Alle pitture murali ha fatto ricorso anche il regime fascista al fine di riportarvi i motti mussoliniani o l’effige stessa del dittatore. Dunque, fino ad epoca recente, “scrivere sui muri” è stato un sistema di comunicazione diffuso e legittimo. In Occidente, le cose sembrano cambiare negli Stati Uniti dei primi anni Settanta, quando nei ghetti arfoamericani e latinos i graffiti murali iniziano ad essere utilizzati come reazione alle discriminazioni delle minoranze ed all’omologazione dello spazio urbano.
Secondo gli autori del saggio, al di là dei significati originari, il writing rappresenta «un impulso a lasciare il proprio segno sul palcoscenico urbano» (p. 34). I muri finiscono con l’ospitare «i punti di vista di mondi privi di accesso legittimo alla parola in pubblico» (p. 34). Dunque la prima e “pericolosa” novità introdotta dal fenomeno del writing degli anni Settanta, non è tanto il comunicare sui muri urbani, ma il fatto che a farlo non siano più soltanto gli apparati di propaganda commerciale e politico-statale. Si tratta in primo luogo di una “presa di parola” da parte dei ceti meno abbienti: «tracciare i segni sui muri significa […] contrapporsi all’immagine della povertà, dell’emarginazione e dell’ingiustizia sociale che la società ufficiale o legale produce in nome dell’ordine pubblico» (p. 35). Oggi le cose sono ovviamente cambiate ed a ricorrere a comunicazioni murali non sono soltanto gli ambienti marginali ed antagonisti; i muri oggi sembrano rappresentare spazi fisici in cui l’irrequietezza esistenziale e politica si può manifestare liberamente e ciò non è per forza prerogativa dell’antagonismo sociale.
Nel saggio viene sottolineato come l’ostilità di molti cittadini nei confronti dei graffiti che ricoprono le mura del quartiere in cui vivono derivi anche da un senso di impotenza nei confronti di una scelta che altri, nottetempo, hanno fatto per tutti. Il cittadino che si ritrova le mura del palazzo “esteticamente modificate”, non ha avuto voce in capitolo. Tale frustrazione si scarica facilmente sui writer ma, a ben guardare, suggeriscono gli autori del testo, il cittadino è impotente anche di fronte alle modificazioni estetiche della città, siano esse temporanee o permanenti, imposte dalle politiche urbane comunali e dal mondo del commercio. Gli spazi urbani in cui i cittadini si trovano a vivere costituiscono pertanto «l’arena dei conflitti (di interessi e visioni del mondo) che si esprimono anche nelle dimensioni semiotiche ed estetiche. Ciò che gli abitanti vedono intorno a loro è, a seconda dei punti di vista, una scena collettiva squallida o invitante, degradata o scintillante, rilassante o inquietante, piacevole per alcuni, sgradevole per altri…. In ogni caso, è il risultato dell’azione di poteri e interessi spesso invisibili, a cui nessuno pensa quando passeggia per le strade e giudica ciò che lo circonda» (pp. 41-42). Dal Lago e Giordano individuano nei graffiti contemporanei l’indicazione di un punto di vista altro, diverso, rispetto ad una scena urbana che intende proporsi/imporsi come necessaria/obbligatoria ma che in realtà è contingente, derivata da un’evoluzione storica che avrebbe potuto dirigersi verso tante altre direzioni.
Nel Secondo capitolo viene passata in rassegna l’evoluzione del writing e le sue connessioni con l’arte contemporanea. Questa sezione del volume prende il via con l’articolo comparso nel luglio del 1971 sul “New York Times” ove viene riportata la fotografia di una porta della 183a strada ricoperta da sigle. Tale pubblicazione rappresenta per certi versi un momento significativo per il writing perché apre un discorso pubblico su di esso.
È soprattutto nell’ambito della cultura Hip Hop che «le tag, che nascono come sigle o firme e quindi come un tipo di scrittura, diventano vere e proprie forme artisticamente autonome, composizioni complesse, progettate e poi realizzate (pieces). Le lettere si dilatano nello spazio, si riempiono di colore creando immagini di grandi dimensioni (masterpieces). I caratteri (blockletters) si gonfiano (bubble style), oppure acquistano una dimensione in più (3d style) e, infine, perdono la loro funzione, diventando forme volutamente illeggibili (wild style)» (pp. 78-79). La risposta delle istituzioni newyorkesi non tarda ad arrivare; all’epoca del sindaco John Lindsay sono ben 1500 i writer arrestati. Lo stesso mondo dei graffiti si rinnova; la bomboletta spray sostituisce il pennello e s’impone il lavoro di gruppo, dunque le stesse tag non di rado si trasformano da firma individuale ad espressione dell’intera crew.
La stagione d’oro della Street art coincide con gli anni Ottanta, quando il «graffitismo si emancipa come linguaggio autonomo e l’attenzione si sposta dal gesto in sé al risultato» (p. 82) e ciò, sottolineano gli autori del saggio, attira l’attenzione del mondo dell’arte ufficiale provocando così l’apertura di un fronte interno al mondo dei writer che vede contrapporsi “puri” e “venduti”. «Dal momento in cui l’idea di Street art ha libera circolazione all’interno dei confini dell’arte riconosciuta, diviene oggetto di un discorso fondamentale per confezionare gli oggetti artistici. Un discorso a cui i graffitisti “perbene” aderiscono pienamente. Spesso, le dichiarazioni di guerra al sistema dell’arte e al suo mercato da parte loro sono in netta contraddizione con fruttuose frequentazioni di galleristi e collezionisti. Una contraddizione che non disturba affatto questi ultimi che, al contrario, si industriano per trovare formule spericolate, capaci di conciliare la natura anarchica della Street art con il suo sfruttamento commerciale» (p. 84).
Al fine di consentire ai graffiti di entrare a far parte del circuito artistico ufficiale, occorre togliere loro l’etichetta criminale e così gli “addetti alla trasformazione” si appellano all’idea che i graffitisti sono criminali per necessità (mancanza di spazi su cui lavorare) e non per scelta. A questo punto, sostengono gli autori, i writer indipendenti che non si concedono, o che tentano di resistere per quanto è loro possibile – visto che il sistema-arte non manca di speculare su produzioni indipendenti anche senza il consenso degli autori -, sanno benissimo che la Street art è divenuta una moda tra le altre all’interno del circuito ufficiale. «Sanno anche che il loro lavoro anonimo potrebbe essere fotografato e inserito in un catalogo, con tanto di prefazione di un critico alla moda: un’eventualità a cui non possono opporsi, ma della quale non intendono approfittare» (p. 87). Altri writer accettano di entrare a far parte del mercato dell’arte e non mancano di estendere l’ambito d’azione commerciale a sneakers, cappellini, t-shirt e felpe dei grandi marchi. In un modo o nell’altro il luccicante e remunerativo mondo dell’arte (e del commercio più in generale) ha modificato le regole del gioco e nulla può più essere come prima.
«I writer, quando sposano il mercato, portano in dote l’aura di trasgressione della loro vita precedente, ma non basta. Sono necessarie le giuste parole dei critici per trasformare in arte ciò che fino a qualche anno prima era deliberatamente fuori dal sistema […] Occorre rompere con il passato, mantenendo vivo quanto basta il mito degli anni ruggenti, ridotto a una scena di sfondo. Occorre soprattutto inventare qualcosa di nuovo per garantire la bontà del prodotto, dimostrando che non tutti i graffiti sono arte. Ciò significa mettere ordine in un repertorio sterminato e, come sempre accade, stabilire criteri estetici, canoni tecnici, limiti e regole» (pp. 90-91).
La questione dei canoni estetici che creano gerarchie ed indicano cosa è arte e cosa non lo è, risulta centrale nel discorso di Dal Lago e Giordano. Gli autori citano esempi di writer “convertiti al mercato” che imputano l’ostilità dei cittadini nei confronti dei lavori di tanti “colleghi” alle loro scarse capacità professionali. Chi ha scelto di “contaminarsi col mercato” è costretto, come abbiamo visto, a mantenere i piedi su due staffe e nell’argomentare circa i difficili rapporti del writing con la cittadinanza, può giungere ad indicare nella mancanza di abilità tecnica di tanti colleghi la principale causa di astio. Se tutti fossero “bravi” come coloro che il mercato ha saputo scegliere, verrebbero meno molti motivi di ostilità. «Riemerge il fantasma della tecnica, grande cavallo di battaglia di qualsiasi posizione reazionaria nell’arte» (p. 92), sostengono gli autori che, a tal proposito, portano alcuni esempi di motivazioni addotte dalle associazioni ostili al writing in cui si sostiene che i graffiti “non possono” essere considerati un fenomeno artistico o perché “l’arte è un’altra cosa” o perché, derivando da un’azione illegale, “non possono” essere considerati “arte”. Lo stesso Museo d’arte moderna di Bologna (Mambo) nel luglio del 2009 giunge a proporsi di “periziare” i murales in città al fine di evitare che, “malauguratamente”, vengano cancellate “opere d’arte” nel corso delle operazioni di ripristino del “decoro urbano” promosse dal Comune. Insomma, da più latitudini si avverte la necessità di distinguere ciò che è arte da ciò che non lo è.
Negli anni Novanta ormai il mondo dei writer è cambiato radicalmente rispetto alle origini del fenomeno; è cambiata la composizione sociale, ora molto meno connotata, sono mutate le tecniche di realizzazione e si è di fronte ad un contesto molto più globalizzato. Se in passato l’idea era quella di coprire la città, ora l’intervento tende piuttosto a scoprirla, svelarla e, spesso a deriderla. Negli ultimi tempi diversi writer hanno messo in campo notevoli abilità manageriali nella gestione della propria immagine, nel saggio viene fatto esplicitamente riferimento al caso forse più noto: «Banksy incarna perfettamente il modello dell’artista capace di fondere la sua arte e la sua capacità imprenditoriale in un’unica grande opera: se stesso» (p. 101). C’è chi ha voluto vedere analogie tra la figura di Banksy e quella di Andy Wharol. A tal proposito, nel saggio, viene evidenziato come mentre il primo si è più volte espresso con opere di esplicita contestazione nei confronti del sistema capitalistico e consumista, Wharol ne ha invece tessuto acriticamente le lodi. Resta il fatto che l’anonimo fustigatore della società dei consumi ha finito col generare un business impressionante attraverso le sue opere e le riproduzioni delle stesse. Lo stesso attacco del celebre writer ai brand delle grandi multinazionali è stato portato attraverso tecniche pubblicitarie che hanno contribuito a creare il “brand Banksy”.
Anche l’arte mainstream non ha mancato di fare i conti con il fenomeno del graffitismo ma, puntualizzano gli autori, «l’interesse degli artisti “ufficiali” nei confronti della strada è un’estensione del territorio della galleria e non una reale fuoriuscita dalla gabbia dorata in cui operano. Diciamo che l’arte ufficiale può solo citare quella di strada, può appropriarsene o trasformarla, ma non sarà mai la stessa cosa. Infatti non gode del privilegio della gratuità e del disinteresse, da cui in fondo deriva ogni innovazione nell’arte e nella vita» (p. 163).
Nel Terzo capitolo vengono analizzate le ragioni dell’ostilità nei confronti del writing. Come presupposto alle questioni che verranno affrontate, gli autori sottolineano come l’attività artistica, indipendentemente da cosa essa sia in origine, divenga socialmente tale solo nel momento in cui viene riconosciuta da chi dispone, storicamente, della legittimità per farlo. Sappiamo che tale soggetto, tale istituzione, viene ad avere diritto di vita e di morte circa il riconoscimento dell’artisticità o meno di un’opera ed in questo discorso non si tratta di accettare o mettere in discussione tale autorità, si tratta di prendere atto del ruolo che certe cariche hanno nell’ambito del conferimento di artisticità qui ed ora. Premesso ciò, Alessandro Dal Lago e Serena Giordano sottolineano come nelle motivazioni delle associazioni antigraffiti non ci si appella tanto al diritto decisionale degli abitanti circa gli interventi sulle superfici delle pareti di casa, ma piuttosto, spesso, si entra nel merito artistico dei graffiti sostenendo che questi non sono opere d’arte. Così facendo tali associazioni si inoltrano su un terreno scivoloso perché sappiamo come sia variabile il concetto d’arte nel tempo. Se i graffiti, o alcuni di essi, fossero ritenuti opera d’arte dalla maggioranza dei cittadini e/o dalle “autorità in materia”? In linea di principio, ricordano gli autori, qualsiasi graffito può “divenire” (essere indicato come) opera d’arte.
In alcuni casi gli abitanti del quartiere hanno difeso i graffiti (e gli autori) in quanto ritenuti una valorizzazione del contesto urbano e tutto ciò indipendentemente dal fatto che fossero stati realizzati illegalmente e che nessun critico d’arte od altra autorità in materia si fosse espresso a riguardo. La mera questione estetica risulta scivolosa, pertanto il fronte antigraffiti, non di rado, si sposta sul versante pedagogico indirizzando i potenziali vandali verso spazi consentiti, non rendendosi conto che una componente fondamentale del writing ha a che fare con il fascino dell’illegalità.
In conclusione, abbiamo visto come, ancora una volta, un fenomeno controculturale, di strada, finisca con l’essere in buona parte riassorbito da un sistema che non esita a ricavare profitto anche da chi lo contesta. Qualche writer si adegua, preferendo mettere a profitto le sue abilità creative a costo magari di trasformare quello che era stato un linguaggio di ribellione donato alla collettività in un testo vuoto che deve essere riempito da critici e dispensatori d’aura. Qualcun altro decide di resistere e di non farsi coinvolgere dal mercato, magari vendendo la propria forza lavoro altrimenti per campare. È una vecchia storia che ha attraversato – e sempre lo farà – le cosiddette sottoculture quando queste diventano appetibili al circuito economico; lo abbiamo visto nell’ambito musicale e nella gestione degli spazi sociali così come tante volte abbiamo assistito a contrapposizioni frontali tra più o meno “puri” contro più o meno “venduti”. Resta il fatto che i graffiti sono «sia un aspetto rilevante della convivenza urbana, sia l’occasione per i cittadini di esprimersi su un buon numero di questioni di interesse generale. In breve, hanno una grande capacità di aggregazione concettuale. Parlare sui graffiti significa anche e sempre parlare di qualcos’altro che sta a cuore ai parlanti» (pp. 18-19).





