di Gianfranco Marelli
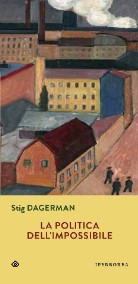 Stig Dagerman, La politica dell’impossibile, Iperborea 2016, pp. 135, € 15
Stig Dagerman, La politica dell’impossibile, Iperborea 2016, pp. 135, € 15
Leggere Stig Dagerman è un ritornare a pensare a ciò che siamo stati, prima di diventare ciò che ora ci hanno imposto di essere e di pensare. Lo si percepisce immediatamente non tanto perché – fin dalle prime righe di questa raccolta di articoli pubblicati dal 1943 al 1952 su varie testate scandinave – immerge il lettore in un’atmosfera passata, segnata dal clima bellico dove qualsiasi riforma sociale e qualsiasi utopia risultano fragili «in un sistema mondiale in cui la catastrofe è l’unica previsione certa»; piuttosto perché lo spinge a riflettere su di un passato che non è mai passato, visto che «il principio divide et impera non è stato abbandonato, ma l’angoscia creata dalla fame, dalla sete, dall’inquisizione sociale è stata, almeno in linea di principio, sostituita come strumento di dominio nello stato del benessere dall’angoscia dovuta all’incertezza, all’impossibilità dell’individuo di decidere il proprio destino nelle questioni essenziali».
Un simile ritorno al passato proiettato su una realtà presente assai prossima all’angoscia esistenziale descritta da Stig Dagerman in una Svezia neutrale e democratica, ci conduce a riflettere in maniera speculare, ancora oggi, sul ruolo dello scrittore impegnato nel mostrare con le sue opere il significato della libertà «nel modo più giocoso possibile contro ogni genere di chiesa, non da ultimo, com’è naturale, contro le chiese letterarie». Una “promessa” che Stig Dagerman pubblica sul giornale anarchico Arbetaren [“Il lavoratore”] il 7 febbraio 1950 quando riassunse il ruolo di caporedattore culturale del quotidiano, rivendicando il suo carattere eretico sia in campo letterario sia sociale in quanto «il dovere dell’eresia si è fatto più che mai urgente in questo momento in cui i fronti di combattimento si stanno formando e l’anatema della nuova inquisizione colpisce tutti coloro che si ritrovano nella terra di nessuno. Giocare al partigiano è l’unica possibilità per chi alla lunga trova un po’ monotono giocare con le bombe atomiche dell’Est e dell’Ovest, e la terra di nessuno è sempre stata l’unica patria del partigiano. Il gioco del partigiano consiste nel diffondere un po’ della confusione della vita tra i soldatini di stagno pronti alla morte e, da un punto esterno alle idee fisse della politica e alle disumane lotte di potere, difendere l’essere umano dagli esseri umani».
È questa, a nostro avviso, la figura a tutto tondo dello scrittore svedese, nato nel 1923 a Älvkarleby nella contea di Uppsala, affermatosi giovanissimo come uno dei più grandi talenti letterari in grado di conquistare il pubblico e la critica proprio grazie al suo carattere intransigente, radicale e risoluto, portavoce della purezza adolescenziale contro la saggezza degli adulti e la loro presunta “ragion pratica” che mal si concilia con la vera vita poiché volta a giustificare l’invivibile attraverso il raggiungimento di prestazioni imposte da un sistema economico e da leggi morali fondate sull’individualismo e sul carrierismo più esasperato. Un leit motiv che ha contraddistinto tutte le sue opere a partire dal primo romanzo “Il serpente” del 1945, e che assieme al suo impegno di militante anarcosindacalista presso il giornale della federazione giovanile Storm [“L’assalto”] e il già menzionato quotidiano anarchico Arbetaren, sono stati il faro di un comportamento conforme all’etica socialista e libertaria, incompatibile con i valori dominanti della società capitalista, quanto del sistema comunista imperante.
Stig Dagerman riteneva infatti che il compito dello scrittore fosse quello di descrivere l’uomo nella lotta continua per liberarsi dal bisogno, dalla paura, dalla miseria materiale e dall’esasperata competizione fonte di angoscia e di solitudine. Queste forti convinzioni sociali e letterarie seppe esprimerle compiutamente in un saggio del 1946 pubblicato sulla rivista 40 tal, asserendo quanto il suo impegno di anarchico coincidesse con la sua attività di romanziere tanto da rappresentare “il mio punto di vista sull’anarchismo” e che, nella presente pubblicazione curata da Fulvio Ferrari con la postfazione di Goffredo Fofi, ha dato il titolo alla raccolta dei diciassette articoli pubblicati dall’editrice Iperborea.
Scrive per l’appunto Dagerman: «In quanto anarchico (e in quanto pessimista, nella misura in cui è consapevole che il suo contributo potrà forse avere solo un significato simbolico) lo scrittore può intanto attribuirsi in buona coscienza il modesto ruolo di lombrico nel terriccio della cultura che altrimenti si dissecherebbe nell’aridità delle convenzioni. Essere il politico dell’impossibile in un mondo dove sono troppi i politici del possibile è, nonostante tutto, un ruolo che personalmente mi può soddisfare come essere sociale, come individuo, e come autore del Serpente».
Certo, il suo sentirsi “analista dell’angoscia”, lo condurrà a sviluppare tematiche esistenzialiste che ricalcano momenti duri della vita, soprattutto il periodo dell’infanzia, quando verrà abbandonato dalla madre e il padre, operaio anarchico, lo affiderà ai nonni per trasferirsi a Stoccolma in cerca di un’occupazione in grado di mantenere entrambi. E in effetti, nonostante la notorietà e la relativa tranquillità economica raggiunta in età giovanissima (aveva solo 22 anni quando scrisse “Il serpente”), i temi dell’angoscia e dell’assurdo furono sempre pregnanti nei suoi romanzi, al punto che – al contrario di Camus – i personaggi lì descritti erano parte di sé e del suo mondo; cosicché se per l’esistenzialista francese il dramma di Mersault ne “Lo straniero” (1942) – con il suo tragico e al contempo assurdo incipit «Oggi la mamma è morta. Ma forse ieri. Non so» – è tutto sommato un espediente letterario, per Dagerman il dramma di Bengt ne “Il bambino bruciato” (1948) – con il suo attacco straziante «È una moglie che dev’essere seppellita oggi alle due … Ma è anche una madre che dev’essere seppellita» – diviene il dramma reale del suo abbandono e della solitudine di chi è consapevole di aver ormai perso, e per sempre, l’illusione di un mondo puro, onesto e integerrimo.
 Tuttavia, sebbene comprensibile vista la tragica fine dell’autore morto suicida a 31 anni, ci sembra impoverire e ridurre lo spessore e il valore contenutistico dell’intera sua opera (romanzi, saggi, pièce teatrali, reportage, articoli) un’attribuzione esclusivamente esistenziale, peraltro per una vita affatto triste dal momento che l’amore, i soldi, la fama non furono certo assenti nella pur breve esistenza di Stig Dagerman. Al contrario, ciò che forse condusse lo scrittore al gesto estremo fu proprio un’esistenza possibile dalla culla alla tomba entro un “minimo pensabile” in cui il rischio, il sogno, la speranza sono anestetizzati e indotti ad una ricerca della felicità programmata dalla produzione e dal consumo della merce, all’interno della più ovattata socialdemocrazia svedese. Ed è proprio Dargerman a suggerircelo, quando sulla rivista culturale “Prisma” pubblica nel 1949 un proprio intervento in cui appunta: «Nel mondo del possibile l’essere umano non è che un prigioniero, incatenato alla galera della paura e dell’indifferenza. Di fronte al possibile l’essere umano è impotente come di fronte alla morte. […] E non dobbiamo pensare che, per questo motivo, sia tutto senza senso, perché non è mai senza senso scegliere l’impossibile invece del possibile. L’unica cosa insensata è accettare il possibile».
Tuttavia, sebbene comprensibile vista la tragica fine dell’autore morto suicida a 31 anni, ci sembra impoverire e ridurre lo spessore e il valore contenutistico dell’intera sua opera (romanzi, saggi, pièce teatrali, reportage, articoli) un’attribuzione esclusivamente esistenziale, peraltro per una vita affatto triste dal momento che l’amore, i soldi, la fama non furono certo assenti nella pur breve esistenza di Stig Dagerman. Al contrario, ciò che forse condusse lo scrittore al gesto estremo fu proprio un’esistenza possibile dalla culla alla tomba entro un “minimo pensabile” in cui il rischio, il sogno, la speranza sono anestetizzati e indotti ad una ricerca della felicità programmata dalla produzione e dal consumo della merce, all’interno della più ovattata socialdemocrazia svedese. Ed è proprio Dargerman a suggerircelo, quando sulla rivista culturale “Prisma” pubblica nel 1949 un proprio intervento in cui appunta: «Nel mondo del possibile l’essere umano non è che un prigioniero, incatenato alla galera della paura e dell’indifferenza. Di fronte al possibile l’essere umano è impotente come di fronte alla morte. […] E non dobbiamo pensare che, per questo motivo, sia tutto senza senso, perché non è mai senza senso scegliere l’impossibile invece del possibile. L’unica cosa insensata è accettare il possibile».
Ecco perché crediamo che ancor oggi la lettura di Stig Dagerman sia un buon antidoto contro il pensiero possibilista che ci ammorba l’esistente per ritornare a praticare la politica dell’impossibile, ricordandoci di come eravamo quando nelle piazze si giocava da partigiani a prendere i nostri desideri per la realtà, perché credevamo nella realtà dei nostri desideri.



