di Armando Lancellotti
 Angelica A. Montanari, Il fiero pasto. Antropofagie medievali, il Mulino, Bologna, 2015, 238 pagine, € 22,00
Angelica A. Montanari, Il fiero pasto. Antropofagie medievali, il Mulino, Bologna, 2015, 238 pagine, € 22,00
La storica medievalista e ricercatrice Angelica Aurora Montanari affronta nel suo ultimo libro, Il fiero pasto, un argomento che già per la sua originalità e scarsa trattazione rende il saggio qui presentato meritorio e stimolante: l’antropofagia nel corso dell’età medievale.
Nonostante le fonti trabocchino di riferimenti a casi di antropofagia o di banchetti cannibalici, pochi sono ad oggi gli studi sulla più estrema forma di tanatoprassi: il cannibalismo. Probabilmente perché – osserva la studiosa – le testimonianze o i racconti che si incontrano nei documenti medievali incuriosiscono, attraggono il semplice lettore o lo studioso, ma solo momentaneamente, dopodiché l’attenzione si sposta rapidamente su cose ritenute più serie e si dà scarsa importanza al fenomeno del cannibalismo, che finisce presto relegato nell’ambito dell’aneddotica e forse anche poiché spesso non è facile capire la veridicità degli eventi raccontati e non è sempre semplice cogliere il discrimine tra realtà ed immaginazione, tra resoconto dei fatti e fantasia.
Ma di certo – sostiene Angelica Montanari – i nostri antenati medievali, in certe circostanze, hanno praticato il cannibalismo e i “mangiatori di uomini” non sono solo individui mostruosi o malvagi, simili agli orchi delle leggende o delle fiabe, ma «anche buoni cristiani, sono cavalieri e re, giovani donzelle, cittadini e ammalati. Il viandante, l’eremita, il pargolo, il guerriero: tutte potenziali vittime, tutti potenziali carnefici». (p. 8).
A ciò si aggiunga che, affrontando un argomento come questo, alla studiosa interessa non solo la ricostruzione evenemenziale dei fatti, la verifica della loro effettiva occorrenza, ma altrettanto il «mirabolante immaginario che ha perpetuato la memoria antropofaga» (p. 9), che ci permette di ricostruire uno spaccato estremamente interessante del cosmo mentale medievale, connesso ad una delle esperienze più estreme ed inumane che uomo passa conoscere.
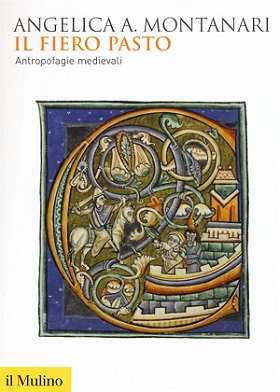 Il libro si struttura in otto capitoli, ognuno dei quali affronta un aspetto o una modalità o un significato particolare dell’atto antropofagico attraverso una ricchissima varietà di fonti che vanno dalle cronache ai memoriali di viaggio, dai trattati medici e dalle farmacopee ai testi normativi e legislativi, dalle fonti cartografiche ed etnografiche alle raccolte di exempla, dai testi letterari alle immagini e alle miniature, tutte esaminate con rigorosa attenzione che si traduce in sistematica categorizzazione fenomenologica dell’antropofagia durante l’intero arco del Medioevo, con qualche incursione a ritroso nel mondo antico ed in avanti verso la prima età moderna e con un’attenzione particolare per l’area geografica italiana centro-settentrionale e franco-normanna.
Il libro si struttura in otto capitoli, ognuno dei quali affronta un aspetto o una modalità o un significato particolare dell’atto antropofagico attraverso una ricchissima varietà di fonti che vanno dalle cronache ai memoriali di viaggio, dai trattati medici e dalle farmacopee ai testi normativi e legislativi, dalle fonti cartografiche ed etnografiche alle raccolte di exempla, dai testi letterari alle immagini e alle miniature, tutte esaminate con rigorosa attenzione che si traduce in sistematica categorizzazione fenomenologica dell’antropofagia durante l’intero arco del Medioevo, con qualche incursione a ritroso nel mondo antico ed in avanti verso la prima età moderna e con un’attenzione particolare per l’area geografica italiana centro-settentrionale e franco-normanna.
L’indagine parte nel primo capitolo (I morsi della fame) con la più immediata delle osservazioni eziologiche: lo stomaco vuoto ed attanagliato da una disperazione famelica può indurre in situazioni estreme al cannibalismo. Se si considerano l’altissima frequenza e la grave incidenza dei periodi di carestia durante l’età medievale, è facile comprendere come una delle premesse o delle condizioni principali dei casi di cannibalismo sia stata la fame. Quando i morsi della fame si fanno insopportabili – osserva l’autrice – il confine tra mundus e immundus tende a scomparire; si mangiano anche gli immundia animalia fino ad arrivare all’atto immondo per eccellenza: il cibarsi di carne umana. Non solo le carestie, conseguenza di inclementi fenomeni naturali, ma spesso anche i lunghi assedi creavano le condizioni affinché quel limite, normalmente considerato aberrante, fosse valicato. È il caso dell’assedio e conseguente sacco di Roma compiuto da Alarico nel 408-410, che causò «pasti antropofagici consumatisi all’interno dell’urbe assediata». (p. 12)
Come è noto, per la mentalità medievale il legame tra naturale e sovrannaturale è così stretto da indurre l’uomo dell’età di mezzo a riportare spesso fatti ed accadimenti mondani a cause e ragioni trascendenti, a spiegare l’incomprensibile di questo mondo con il comprensibile per fede di un altro mondo, quello divino. Le calamità naturali e quindi anche le carestie e la fame sono segni o flagelli divini, che mettono in guardia o puniscono gli uomini per i loro peccati. Non sfugge a questo paradigma esplicativo il cannibalismo: «l’antropofagia può essere uno dei profetici signa che annunciano disastri cosmici, oppure la somma conseguenza dell’ira celeste che invia siccità, piogge diluviali, sciami di locuste, guerre, devastazioni cataclismi e carestie, costringendo gli uomini a immonde pratiche necrofagiche e cannibaliche». (p. 15)
Nelle cronache e nelle testimonianze ricorre frequentemente questo genere di rielaborazione e spiegazione degli episodi di “cannibalismo nutrizionale”, un atto così immondo da poter essere compreso solo se lo si riconduce ad un sovvertimento dell’ordine naturale (quindi divino) delle cose, che solo Dio stesso può volere per colpire con la sua infallibile giustizia i mali degli uomini. È il caos che si impossessa del mondo e ne conseguono effetti apocalittici, come racconta Rodolfo il Glabro circa la grande carestia del 1032-1033, che colpì molte parti d’Europa ed anche la Borgogna: «Come se ormai stesse diventando un fatto abituale il mangiare carni umane, un tale ne portò di cotte per metterle in vendita al mercato di Tournus, quasi si trattasse di comune carne animale. Arrestato, l’uomo non negò quella colpa; fu allora immobilizzato e bruciato sul rogo. La carne venne seppellita; ma un altro la dissotterrò di notte e la mangiò, finendo egli pure bruciato». (p. 17)
Dall’analisi dei penitenziali poi la studiosa desume la fermezza dei divieti riguardanti l’ingestione indiretta di carne o altri resti umani, interdetto già auspicato in passato da Tertulliano riguardo all’abitudine di consumare le fiere dell’arena che avevano divorato carne umana: il pericolo è quello della antropofagia di “seconda mano”, che induce per esempio il re di Francia Giovanni II il Buono nel 1363 a vietare di «macellare animali che si fossero nutriti nelle residenze dei barbieri, dove avrebbero potuto ingerire sangue, capelli o unghie recise. La normativa si estendeva poi a proibire a diverse categorie professionali, tra cui gli stessi barbieri e i chirurghi, l’allevamento del bestiame destinato a uso alimentare nel dubbio che potesse essersi cibato di residui piliferi, fluidi umani o carni amputate». (p. 20)
Ma qual è l’identità del divoratore per fame di carne umana, che nella maggior parte dei casi – cioè esclusi quelli di necrofagia – è prima omicida e poi cannibale? Angelica Montanari ci dice che non è affatto facile tracciarne un profilo, disegnarne un identikit, che rimangono pertanto alquanto imprecisi ed indefiniti; molto più semplice, invece, è raccogliere dai documenti gli indizi riguardo alle vittime del “fiero pasto”, che nei più frequenti casi di “esocannibalismo” sono uomini o donne esterni alla comunità, per esempio malcapitati stranieri o pellegrini o viandanti, oppure bambini attirati con l’offerta di un frutto o di un dono. Questa – osserva l’autrice – è «ritenuta la forma meno grave di antropofagia poiché non lede i componenti del nucleo sociale (come nel caso di assassinio di viandanti e pellegrini)» (p. 53); certamente meno grave dell’“endocannibalismo”, fenomeno che si verifica quando la vittima è parte integrante della comunità, che rischia di sfaldare i legami comunitari e sociali. Ma il caso più grave di tutti è l’”omicidio cannibalico intrafamiliare”, che se «commesso dalla madre verso i figli, mina dall’interno il nucleo fondamentale dell’organizzazione sociale». (p. 53)
E proprio delle “madri antropofaghe” si occupa l’interessantissimo secondo capitolo del libro che individua l’archetipo medievale dell’antropofagia materna (o intrafamiliare) nel testo biblico e in particolare nel secondo Libro dei Re, nel quale si narra dell’assedio di Samaria, quando due donne stremate dalla fame si accordano di uccidere, cucinare e mangiare i corpi dei loro figli; ma mentre la prima tiene fede al patto omicida, la seconda, dopo aver mangiato del figlio dell’altra, si rifiuta di uccidere suo figlio e lo nasconde. In altri passi del testo sacro l’antropofagia intrafamiliare viene invece minacciata come tremenda punizione e necessaria tragedia nel caso di infrazione della legge di Dio da parte del popolo di Israele e così i padri sbraneranno i figli o i figli divoreranno i padri.
 Ma accanto al testo biblico, vi è un’altra auctoritas fondamentale per i medievali riguardo al cannibalismo materno: è il Bellum Judaicum di Giuseppe Flavio, che racconta l’assedio di Gerusalemme ai tempi dell’imperatore Vespasiano (70 d.C.) e di una donna, Maria, che si ciba del proprio figlio. Disperata per la fame, che attanaglia l’intera popolazione della città assediata e per il deperimento del figlio, che non potrà in alcun modo sfuggire ad una tremenda morte per inedia, a maggior ragione se lei stessa morirà e non potrà più accudirlo, Maria prende la decisione di ucciderlo e di utilizzarlo come cibo. Ma i ribelli, che tengono il controllo di Gerusalemme e la cui rivolta contro Roma ha condotto all’assedio, attratti dall’odore della carne cucinata, fanno irruzione nella casa di Maria per avere una porzione di quel cibo, ma quando vengono a sapere dalla donna stessa di che cosa si tratta, lo rifiutano disgustati e sconvolti. Ma proprio loro, per Giuseppe Flavio, sono ancor più colpevoli della madre cannibale, avendo creato le condizioni perché l’esecrando atto di Maria fosse possibile. La notizia presto si diffonde sia dentro alla città sia al di fuori di essa e giunge fino alle orecchie dei romani e di Tito, figlio di Vespasiano, che dinanzi ad un tale accadimento prende la decisione irrevocabile che Gerusalemme andrà distrutta.
Ma accanto al testo biblico, vi è un’altra auctoritas fondamentale per i medievali riguardo al cannibalismo materno: è il Bellum Judaicum di Giuseppe Flavio, che racconta l’assedio di Gerusalemme ai tempi dell’imperatore Vespasiano (70 d.C.) e di una donna, Maria, che si ciba del proprio figlio. Disperata per la fame, che attanaglia l’intera popolazione della città assediata e per il deperimento del figlio, che non potrà in alcun modo sfuggire ad una tremenda morte per inedia, a maggior ragione se lei stessa morirà e non potrà più accudirlo, Maria prende la decisione di ucciderlo e di utilizzarlo come cibo. Ma i ribelli, che tengono il controllo di Gerusalemme e la cui rivolta contro Roma ha condotto all’assedio, attratti dall’odore della carne cucinata, fanno irruzione nella casa di Maria per avere una porzione di quel cibo, ma quando vengono a sapere dalla donna stessa di che cosa si tratta, lo rifiutano disgustati e sconvolti. Ma proprio loro, per Giuseppe Flavio, sono ancor più colpevoli della madre cannibale, avendo creato le condizioni perché l’esecrando atto di Maria fosse possibile. La notizia presto si diffonde sia dentro alla città sia al di fuori di essa e giunge fino alle orecchie dei romani e di Tito, figlio di Vespasiano, che dinanzi ad un tale accadimento prende la decisione irrevocabile che Gerusalemme andrà distrutta.
Al di là dei fatti – osserva l’autrice – ciò che più interessa è l’analisi che ne fa Giuseppe Flavio, il quale estende all’intero popolo giudaico, che ha violato la legge di Roma, il crimine di Maria, causato non solo e non principalmente dalla fame, ma anche da una forma estrema e paradossale di pietà per il figlio e soprattutto dall’ira verso i ribelli che hanno provocato la situazione che l’intera Gerusalemme sta vivendo e quindi anche il suo estremo gesto. La «deresponsabilizzazione di Maria è finalizzata ad additare gli insorti come unici veri colpevoli dell’accaduto». (p. 33)
Nel Medioevo il racconto di Giuseppe Flavio si associa alla teoria, desunta dalla Bibbia, dell’antropofagia materna come maledizione punitiva di Dio e il risultato è un acrobatico capovolgimento di senso che porta a corroborare il tremendo pregiudizio cristiano antigiudaico del deicidio. «Il casus belli antropofagico, che dal punto di vista di Flavio (e delle sue prime epitomi latine) motiva la distruzione di Gerusalemme, è diventato progressivamente inutile nella nuova ottica cristiana: sui giudei, colpevoli del massimo peccato, […] ricade sempre e comunque l’infamia più grave e terribile, il deicidio». (p. 35)
L’atto cannibalico, che per l’ebreo e romano Giuseppe Flavio era la “causa” della distruzione di Gerusalemme, negli autori cristiani si capovolge e si trasforma in “conseguenza” inevitabile e tremenda della colpa di tutte le colpe, il deicidio e della sua necessaria punizione.
Come quelle qui sommariamente riproposte riguardo all’antropofagia materna, altrettanto interessanti sono le considerazioni sulla possibilità di un’antropofagia “paterna”, che l’autrice sostiene non essere di fatto contemplata dagli autori cristiani, a meno che l’atto del sacrifico della vita innocente del figlio da parte del padre non costituisca l’esecuzione votiva di un volere divino. In tal caso è proprio l’uomo, è solo il padre che può compiere il gesto estremo infanticida, di cui l’archetipo è Abramo pronto a sacrificare Isacco per ordine di Dio. E il “lieto fine” della vicenda e di altre analoghe confermerebbe come solo all’uomo sia riservato il rapporto sacrificale con Dio e con i valori positivi ad esso connessi, mentre «una madre assassina non agisce mai secondo nobili propositi, ma sempre per follia o per vendetta […]. Ella viene così inevitabilmente relegata nella categoria degli antropofagi bestiali e contro natura». (p. 52)
 Per rimanere nell’ambito dell’antropofagia sacrale o sacrificale e non rispettando la successione dei capitoli di un libro che per abbondanza e diversità di argomenti e punti di vista considerati può essere letto anche scombinandone la struttura, passiamo al sesto capitolo (Il pasto rituale), in cui Angelica Montanari affronta sia il caso di quella pratica di “antropofagia simbolica” che è il rito eucaristico, sia le accuse di cannibalismo e connessi riti immondi, innanzi tutto imputate dai pagani proprio ai primi cristiani, poi traslate e trasferite da questi ultimi contro i pagani stessi (già dai primi apologisti e padri della Chiesa), ma anche e soprattutto contro eretici ed ebrei nel corso del Medioevo.
Per rimanere nell’ambito dell’antropofagia sacrale o sacrificale e non rispettando la successione dei capitoli di un libro che per abbondanza e diversità di argomenti e punti di vista considerati può essere letto anche scombinandone la struttura, passiamo al sesto capitolo (Il pasto rituale), in cui Angelica Montanari affronta sia il caso di quella pratica di “antropofagia simbolica” che è il rito eucaristico, sia le accuse di cannibalismo e connessi riti immondi, innanzi tutto imputate dai pagani proprio ai primi cristiani, poi traslate e trasferite da questi ultimi contro i pagani stessi (già dai primi apologisti e padri della Chiesa), ma anche e soprattutto contro eretici ed ebrei nel corso del Medioevo.
Se è vero che né «la teofagia né il cannibalismo sacrale […] nascono con il cristianesimo, essendo presenti in una grande varietà di miti e di culti precedenti» (p. 119) è pure vero che quello di Cristo è un corpo «incarnato, risorto, transustanziato, esposto, venerato, ingerito, assimilato». (p. 119)
I nemici della nuova religione cristiana ebbero quindi gioco facile ad accusare i cristiani di cannibalismo rituale, di cibarsi di carne e sangue umani e di compiere omicidi di bambini per inzuppare nel loro sangue il pane eucaristico.
Gli apologisti e i padri della Chiesa si impegnarono a fondo nel confutare le infamanti accuse e nel rispedirle al mittente in una «tappa fondamentale nel processo di autodefinizione identitaria del nuovo credo» (p. 125), fino ad arrivare a capovolgere i ruoli di accusatori ed accusati.
Nel Medioevo poi, a partire dall’XI secolo in avanti, quando numerose eresie nascono, attecchiscono e si diffondono rapidamente, l’accusa di cannibalismo rituale, nella forma di un plagio demoniaco ed immondo del sacro rito eucaristico, viene imputata proprio agli eretici, i nemici interni, perciò ancor più pericolosi, della cristianità. Gli eretici celebrano «eucaristie sacrileghe con ostie impastate con il sangue o le ceneri dei figli uccisi» oppure preparano «polveri o pozioni a base di residui di bambini in un composto capace – se ingerito – di trasmettere l’errore anche ai fedeli più devoti». (p. 127) Ma – osserva l’autrice – se nella lotta senza quartiere contro catari ed altri eretici è comprensibile che la Chiesa ricorra alle forme peggiori di diffamazione pensabili, risulta invece più complesso comprendere il percorso che porta all’imputazione del plagio sacrilego del rito eucaristico a religioni storicamente precedenti quella cristiana: le correnti misteriche antiche e, ovviamente, l’ebraismo, il più infallibile e sempre pronto all’uso dei parafulmini di buona parte della storia della cristianità.
La verità ontologicamente e logicamente precede l’errore anche quando nell’ordine umano del tempo e della storia le cose si susseguono diversamente, pertanto «con buona pace della sequenza temporale, […] pagani ed ebrei hanno imitato i culti cristiani incentrati sul pasto rituale prima ancora che il cristianesimo si presentasse sul palcoscenico della storia, contraffacendoli diabolicamente in macabri rituali cannibalici». (p. 128)
Già l’antigiudaismo della cultura ellenistica aveva avanzato accuse in tal senso, come testimoniato dal Contro Apione di Giuseppe Flavio, ma è il cristianesimo medievale e basso medievale in particolare che amplifica a dismisura il fenomeno e così la “cronaca nera” dell’Europa cristiana si affolla di casi come quello di Simonino di Trento a cui si aggiunge l’ennesima acrobatica piroetta logica per cui non solo il sacrifico rituale di bambini cristiani è un continuum della violenza contro Cristo crocifisso, ma l’assunzione di «sangue di infanti battezzati da parte di ebrei sarebbe stata motivata dalla volontà di accedere ai benefici redentivi del sangue di Cristo, desiderio che sottintenderebbe paradossalmente la piena accettazione delle verità cristiane». (p. 130)
Retrocedendo al capitolo terzo (Mangiare il nemico), veniamo a conoscenza di un significato e di una forma tanto trascurati quanto interessanti di antropofagia: il divoramento del nemico politico o del tiranno. Si tratta in sostanza di atti di cannibalismo con significati politici e scopi simbolici: il caso più frequente è quello del cuore del nemico strappato dal petto e addentato o sbranato. Circa una quindicina sarebbero secondo le cronache – dice Angelica Montanari – i casi di cannibalismo di questo genere avvenuti tra il XIV e il XVI secolo prevalentemente nell’Italia centrosettentrionale.
La campionatura del fenomeno che il libro riporta parte però dal caso messinese del 1168 durante il regno del normanno Guglielmo II d’Altavilla, quando il popolo, esasperato per le eccessive tasse imposte dagli uomini della regina madre e reggente Margherita di Navarra, uccide Oddone Quarrel, ritenuto il principale responsabile ed un insorto gli trafigge il cranio con un coltello per poi lambire ed ingerire il sangue direttamente dalla lama, per arrivare fino ai fatti del 1585 nel viceregno spagnolo di Napoli, quando l’eletto del popolo Giovan Vincenzo Starace, accusato di privare la popolazione del pane necessario, viene ucciso e squartato dalla folla e le sue carni cotte e crude vengono divorate, passando attraverso le cruente vicende della Marca Trevigiana nel 1313, di Brescia nel 1311, di Firenze nel 1343, oppure ancora di Milano nel 1476 e di Forlì nel 1488 e così via. Non manca neppure un caso francese, che coinvolge però il toscano Concino Concini, uomo di fiducia di Maria de’ Medici, ucciso per volere di Luigi XIII, «il cui cuore sarà strappato e cucinato sui carboni ardenti» nel 1617. (p. 60)
In tutti i casi – che la studiosa cataloga come «tirannicidi, congiure o rivolte, punizioni dell’attentatore del signore, scontri tra fazioni, lotte contro nemici esterni alla città, vendette private» (p. 61) – l’atto di cannibalismo ha il fine di fare scempio del corpo del nemico, spregiarlo e oltraggiarlo; infatti, mentre altre forme di violenza brutale e sanguinaria come l’amputazione, il trascinamento, l’impiccagione per i piedi, fino ad arrivare allo squartamento erano variamente previste da codici penali di molto precedenti il ripensamento e la ridefinizione di delitti e pene dell’illuminismo di un Beccaria, «l’antropofagia, culmine simbolico del rituale infamante» (p. 63), non era contemplata.
Le vittime della violenza cannibalica sono solitamente nobili colpevoli di crimini politici (malgoverno o cospirazione contro un governo giusto); il carnefice è genericamente individuato nel popolo, nella folla, nella moltitudine che si solleva ed insorge; la «pena, quindi, deve essere esemplare e pubblica» (p. 65) e soprattutto infamante, a tal punto che chi ne è colpito viene disumanizzato, animalizzato, ridotto e degradato a semplice carne commestibile.
 Per l’autrice, internamente al rituale di vendetta collettiva che comporta smembramento e divoramento del nemico, diverso valore simbolico assumono le modalità di trattamento del corpo straziato. Come ci dice il capitolo quarto (Cuore morso, cuore mangiato), la «crudità della carne […] enfatizza la feritas degli aggressori e pone contemporaneamente l’accento sull’animalizzazione della vittima […]. Al contrario la cottura della carne umana ne sottolinea la novella veste alimentare: è il caso dei bambini cotti che figurano nelle testimonianze delle carestie e nella tradizione testuale e iconografica dell’episodio di Maria, dove il pargolo è immortalato mentre rosola sul fuoco oppure pronto ad essere gettato in un calderone». (p. 77-78)
Per l’autrice, internamente al rituale di vendetta collettiva che comporta smembramento e divoramento del nemico, diverso valore simbolico assumono le modalità di trattamento del corpo straziato. Come ci dice il capitolo quarto (Cuore morso, cuore mangiato), la «crudità della carne […] enfatizza la feritas degli aggressori e pone contemporaneamente l’accento sull’animalizzazione della vittima […]. Al contrario la cottura della carne umana ne sottolinea la novella veste alimentare: è il caso dei bambini cotti che figurano nelle testimonianze delle carestie e nella tradizione testuale e iconografica dell’episodio di Maria, dove il pargolo è immortalato mentre rosola sul fuoco oppure pronto ad essere gettato in un calderone». (p. 77-78)
Non potendo in alcun modo restituire la straordinaria nonché avvincente ricchezza del libro di Angelica Montanari, né intendendo sostituire una semplice presentazione alla sua diretta lettura, completiamo queste considerazioni annotando che molti altri sono gli aspetti dell’antropofagia che la storica affronta nei restanti capitoli del suo lavoro: per esempio la “vendetta cortese” che ricorre nella letteratura medievale, nella quale «un marito geloso, dopo aver trucidato l’amante della moglie, le propina subdolamente a tavola il cuore dell’amato ucciso, celato sotto forma di torta o di altra vivanda» (p. 83); oppure (capitolo quinto, Curare col corpo) l’uso di parti del corpo umano o di membra ricavate da salme per confezionare farmaci, considerati così efficaci da essere quasi miracolosi, analogamente alle reliquie dei santi. Infatti «mentre i monaci erano impegnati a raccogliere i preziosi succhi emersi dalle salme dei santi e a filtrare le reliquie con acqua e vino, in ambito profano si diffondeva una farmacopea ancor più antropofaga». (p. 99) È il caso della cosiddetta “mumia”, «vera e propria carne umana essiccata» (p. 99) considerata un farmaco potentissimo ed efficacissimo.
E per finire riportiamo una “ricetta” – ebbene sì, anche questa non manca – per chi intenda cimentarsi con una tipologia un po’ eccentrica di arte culinaria! È tratta da un testo stampato a Venezia a fine ‘600 da Carlo Lancillotti, medico e chimico modenese, che riporta questa ricetta per la preparazione e la conservazione della carne umana:
«Ingredienti: cadavere umano (a piacimento), mirra, aloe, “spirito di vino ottimo”. Norme per la preparazione: – lasciare il cadavere “un giorno intiero e una notte in tempo sereno all’aria dove li dii il sole e la luna”; – tagliare la carne “in fette”; – aspergere le fette con mirra e un quarto di aloe e polverizzare finemente; – lasciar riposare il tutto quattro o sei ore; – intingere le fette in “spirito di vino” e porre “all’aria in loco secco e ombroso come sarebbe la stufa di un forno, dove si cuoce il pane […] sino che dette fette sieno benissimo secche, che paia carne seccata al fumo”». (p. 117)



