di Mauro Baldrati
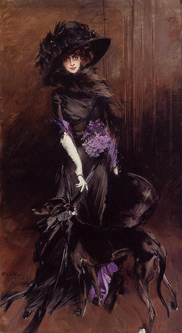 Due stranieri a Parigi: potrebbe essere questa la definizione comune di due mostre d’arte, una di pittura e una di fotografia, in atto in questi giorni. Gli stili sono diversi, post impressionista il pittore, espressionista il fotografo. Eppure, ciascuno a modo suo, il pittore e il fotografo hanno ritratto un ambiente, il segmento di un’epoca, soprattutto attraverso le figure umane, e i segni che da esse si sprigionano.
Due stranieri a Parigi: potrebbe essere questa la definizione comune di due mostre d’arte, una di pittura e una di fotografia, in atto in questi giorni. Gli stili sono diversi, post impressionista il pittore, espressionista il fotografo. Eppure, ciascuno a modo suo, il pittore e il fotografo hanno ritratto un ambiente, il segmento di un’epoca, soprattutto attraverso le figure umane, e i segni che da esse si sprigionano.
Giovanni Boldini, a Forlì, Museo San Domenico, Piazza da Montefeltro 12, fino a 14 giugno.
Boldini, nato a Ferrara nel 1842, si trasferisce a Parigi nell’ottobre del 1871, vale a dire cinque mesi dopo la feroce repressione della Comune. La restaurazione è già in fiore, i salotti del bel mondo riaprono più sfavillanti che mai, duchesse, principesse, banchieri e bellimbusti riprendono le loro feste in maschera, i loro ricevimenti e le loro chiacchiere vuote. Come dimenticare la confusione del giovane Narratore della Récherche quando finalmente, dopo mesi e anni di appostamenti, viene ammesso nel leggendario salotto dei Guermantes? E’ sconvolto dalla fatuità delle discussioni, non riesce a credere che loro, i semidei, parlino di cose tanto meschine, e soprattutto che lei, la duchessa della quale è perdutamente innamorato, sia così superficiale. Sono i segni della mondanità, naturalmente, i segni “maggioritari” e futili di cui parlò Deleuze nel suo piccolo saggio su Proust, segni effimeri, vuoti e bugiardi, che si dissolvono nel nulla e non lasciano traccia.
Boldini in breve tempo diventa un pittore d’élite richiestissimo e il ritrattista ufficiale di tutte queste duchesse e principesse. Ora, noi che siamo dei pronipoti di Lenin, potremmo esaltare l’aristocrazia reazionaria e l’alta borghesia predatrice della Belle Époque? I suoi quadri, i suoi ritratti sono ambientati quasi esclusivamente in questo mondo. Signore magnifiche, illuminate da una luce che le rende semidivine, si offrono leggiadre all’occhio del pittore, che le fissa sulla tela. Sarebbe contro natura, no? Eppure, c’è anche altro. C’è la bellezza, lo stile, una ricerca che sembra andare oltre una certa musicalità dell’impressionismo, che viene per così dire fissato nei segni dell’apparenza, che diventano come ossessivi, monomaniaci, nel loro splendore autistico. Non c’è critica esplicita in Boldini, e neanche camuffata; però di fronte all’interminabile galleria di ritratti sontuosi e perfetti, lo spettatore non può non ricordare gli appunti di Marguerite Yourcenar in contemplazione dei mosaici di Ravenna, la corte d’Occidente immobile nella sua fissità, un’immobilità che ricorda la morte e il Grande Nulla. Tutte le duchesse di Boldini hanno questa fissità, questo manierismo che le rende delle maschere meravigliose e inarrivabili. La sua opera lascia irrisolto il mistero dello stile, che supera il contenuto ed esplode di fronte allo spettatore, che in barba a tutte le teorie e agli idealismi non può esimersi dall’ammirarlo, lasciandosi andare dolcemente alla contemplazione e al sogno.
Brassaï, a Milano, Museo Morando, Via Sant’Andrea 6, fino al 28 giugno.
 Se in Boldini c’è Proust, coi suoi segni e le sue idealizzazioni, in Brassaï c’è Henry Miller. C’è tutto Miller, il Tropico del Cancro, le sue notti folli e miserabili, i suoi bordelli, i tipi assurdi, il “vizio”, i bistrot, la velocità, lo straniamento, l’esaltazione, il voyeurismo. Brassaï (lo pseudonimo deriva dalla regione della Transilvania della quale era originario Gyula Halász – nome impronunciabile che venne cambiato, proprio come il suo quasi contemporaneo Endre Ernő che diventò Robert Capa), arrivò a Parigi nel 1924. Non era uno specialista della fotografia, ma un grande eclettico: dipingeva, scriveva, usava gli strumenti e gli stili per le sue ricerche. La macchina fotografica, come una chiave di ingresso, proprio come la definì Susan Sontag, gli servì per entrare negli ambienti, per conoscere e catalogare tipi umani, per frugare tra le pieghe nascoste del mondo notturno. Percorreva la città di notte, con la massiccia fotocamera sul cavalletto, immortalava marciapiedi lucidi di pioggia, le prostitute, tutta la vita di strada che, proprio come scrisse Henry Miller, che presto diventò suo amico (e come avrebbero potuto non fraternizzare?), “significa accidente e incidente, dramma, movimento. Soprattutto significa sogno”. C’è il sogno, in Brassaï. Il sogno parigino degli anni Trenta, quando il tempo sembrava bruciare come un furioso fuoco fatuo, dopo la fine di un orrore e l’approssimarsi di un altro, e tutti correvano, gridavano, combattevano, si amavano. Il tutto ritratto in un bianco e nero energico, sfrontato, che sembra anticipare quello cannibalesco e ultravoyeuristico del grande Weegee, o quello disperante della tormentata Diane Arbus, coi suoi freaks, le sue creature della notte che sembrano gridare senza che un solo suono umano esca dalle loro bocche. Brassaï, il non-specialista, il catalogatore delle notti parigine, uno dei maestri del bianco e nero e del ritratto, col suo eclettismo ha creato alcune immagini che hanno viaggiato per decenni, come Lovers, i due innamorati che, riprodotti su milioni di poster, sono diventati una delle fotografie più famose del mondo.
Se in Boldini c’è Proust, coi suoi segni e le sue idealizzazioni, in Brassaï c’è Henry Miller. C’è tutto Miller, il Tropico del Cancro, le sue notti folli e miserabili, i suoi bordelli, i tipi assurdi, il “vizio”, i bistrot, la velocità, lo straniamento, l’esaltazione, il voyeurismo. Brassaï (lo pseudonimo deriva dalla regione della Transilvania della quale era originario Gyula Halász – nome impronunciabile che venne cambiato, proprio come il suo quasi contemporaneo Endre Ernő che diventò Robert Capa), arrivò a Parigi nel 1924. Non era uno specialista della fotografia, ma un grande eclettico: dipingeva, scriveva, usava gli strumenti e gli stili per le sue ricerche. La macchina fotografica, come una chiave di ingresso, proprio come la definì Susan Sontag, gli servì per entrare negli ambienti, per conoscere e catalogare tipi umani, per frugare tra le pieghe nascoste del mondo notturno. Percorreva la città di notte, con la massiccia fotocamera sul cavalletto, immortalava marciapiedi lucidi di pioggia, le prostitute, tutta la vita di strada che, proprio come scrisse Henry Miller, che presto diventò suo amico (e come avrebbero potuto non fraternizzare?), “significa accidente e incidente, dramma, movimento. Soprattutto significa sogno”. C’è il sogno, in Brassaï. Il sogno parigino degli anni Trenta, quando il tempo sembrava bruciare come un furioso fuoco fatuo, dopo la fine di un orrore e l’approssimarsi di un altro, e tutti correvano, gridavano, combattevano, si amavano. Il tutto ritratto in un bianco e nero energico, sfrontato, che sembra anticipare quello cannibalesco e ultravoyeuristico del grande Weegee, o quello disperante della tormentata Diane Arbus, coi suoi freaks, le sue creature della notte che sembrano gridare senza che un solo suono umano esca dalle loro bocche. Brassaï, il non-specialista, il catalogatore delle notti parigine, uno dei maestri del bianco e nero e del ritratto, col suo eclettismo ha creato alcune immagini che hanno viaggiato per decenni, come Lovers, i due innamorati che, riprodotti su milioni di poster, sono diventati una delle fotografie più famose del mondo.
[In apertura: la marchesa Luisa Casati Stampa, opera d’arte vivente e musa dissipatrice dell’époque boldiniana; all’interno, Lovers, di Brassaï]



