di Daniele Orlandi
 Anche quest’anno, in occasione della giornata della memoria, l’industria dell’Olocausto – secondo la definizione di Norman Finkelstein, vale a dire lo sfruttamento commerciale della tragedia ebraica – proporrà i suoi modelli avveniristici con l’aiuto di registi e sceneggiatori, romanzieri e “annafrankisti” dell’ultim’ora, a uso e consumo di morbosi, fornendo nuove sponde ai revisionisti vecchi e nuovi. Primo Levi, d’altra parte, lo aveva capito anzitempo che “il racconto del reduce è un genere letterario”[1] e temeva che da quel ramo geminassero sottoprodotti grotteschi e falsi .
Anche quest’anno, in occasione della giornata della memoria, l’industria dell’Olocausto – secondo la definizione di Norman Finkelstein, vale a dire lo sfruttamento commerciale della tragedia ebraica – proporrà i suoi modelli avveniristici con l’aiuto di registi e sceneggiatori, romanzieri e “annafrankisti” dell’ultim’ora, a uso e consumo di morbosi, fornendo nuove sponde ai revisionisti vecchi e nuovi. Primo Levi, d’altra parte, lo aveva capito anzitempo che “il racconto del reduce è un genere letterario”[1] e temeva che da quel ramo geminassero sottoprodotti grotteschi e falsi .
A partire dal termine ormai comunemente ma impropriamente scelto di Olocausto che, stando per “tutto bruciato”, connota lo sterminio in senso esclusivamente religioso, sacrificale. Eppure i maggiori testimoni della strage razzistico-industriale nazista confessano di aver sperimentato l’ ”obbligo e impossibilità di essere ebreo”[2] proprio in Lager. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale è, questa, una caratteristica comune a molti ebrei occidentali, integrati da secoli nei paesi europei. Obbligo, poiché non è dato cancellare un’origine nemmeno davanti al pericolo della deportazione né di non riconoscersi come appartenente a un popolo martoriato davanti una camera a gas. Impossibilità, poiché non ci si può imporre una fede o la condivisione di una determinata cultura. Figli laici di un universo familiare e culturale laico, tali sono rimasti. Di formazione umanistica, illuminista, positivista, hanno fatto del dramma tutto umano del campo di concentramento, la base dei propri racconti. Più che “la morte di Dio”, per questi reduci il Lager è stata la conferma di un ateismo preesistente (“C’è Auschwitz”, rifletteva Levi, “dunque non può esserci Dio”). A guerra finita non si sono trasferiti a Gerusalemme, preferendo tornare alle proprie case ed affrontare l’irrisolvibile trauma del reinserimento oppure hanno vagato per il Vecchio Continente alla ricerca di uno spazio, fisico e interiore, da poter chiamare Heimat. Sono stati difensori del diritto all’esistenza dello Stato ebraico ma spesso critici sulla politica estera israeliana e ne hanno scontato duri anatemi e profondi isolamenti.
È accaduto – e accade ancora – anche al filosofo austriaco Hans Mayer, che dal 1945 aveva iniziato a firmarsi Jean Améry, anagrammando il suo nome. Il più complesso e urticante sopravvissuto, autore, nel 1966, di un libro capitale della littérature de temoignage, nato dalla fusione dei due lunghi saggi Jenseits von Schuld und Sühne (Aldilà della colpa e dell’espiazione) e Bewältigungsversuche eines Überwältigten (Tentativo di superamento di un sopraffatto) tradotto in italiano con il titolo programmatico di Intellettuale a Auschwitz. L’accademia non lo studia, i giovani laureati in filosofia non ne conoscono l’esistenza, le comunità ebraiche non lo ricordano, i librai non lo consigliano e la storiografia non gli ha ancora dedicato una monografia che ne tenti un ritratto a figura intera. Améry è morto suicida nel 1978 e nessuno ne parla più. La stessa penetrazione in Italia dei suoi libri dà la misura di questa lunga incuranza. Fu Primo Levi – col quale Améry era sceso in polemica definendo il chimico torinese un “perdonatore” dopo aver letto Se questo è un uomo – a proporsi come traduttore ma nell’aprile del 1987 Levi moriva nel modo che sappiamo e Giulio Bollati mandava in stampa la versione italiana tradotta da Enrico Ganni, in omaggio all’amico scomparso. Da allora, i libri di Améry pubblicati in Italia saranno quattro, scelti come i più rappresentativi, in un corpus di nove volumi raccolti nei Werke.
Complesso, dicevamo, poiché Améry è e resta un filosofo. I suoi temi sono la tortura che incrina il “mondo interno” dell’essere umano, la vecchiaia che lo offende senza scampo e lo fa estraneo a se stesso (vedi Rivolta e rassegnazione. Sull’invecchiare, 1968), la morte come scelta o fortunoso scampo, l’ipocrisia della cultura borghese dominante in ogni epoca (vedi il saggio del 1978, Charles Bovary, medico di campagna) ed egli svolge le sue riflessioni intorno al Lager, presente ma sottilissimo fil rouge di tutta la sua produzione, a partire da questa irrinunciabile forma mentis. Urticante, poiché inconsolabile e non consolatore. Perché uomo di sinistra radicale (venne arrestato dalla Gestapo in quanto partigiano di una formazione comunista) sempre contro la sinistra del suo tempo, scomodo nella DDR come nella BRD; perché contro gli storici e la loro pretesa di accostarsi allo sterminio con obiettività e distacco; contro i revisionisti e i moderati costruttori di dubbie identità politiche e di facili assoluzioni. Infine, scostante. Poiché esterno collaboratore della testimonianza, estremamente soggettivo, “senza pace e senza ricerca della pace”[3], portatore sano di contagiosa disperazione. In tutti i suoi libri egli analizza un dramma culturale prima ancora che fisico, prima ancora che storico. Il Lager è stata la tomba dell’uomo di lettere, dell’uomo dello spirito (non dell’uomo di fede) come egli intendeva l’intellettuale. Un reduce scrittore e insieme muto. Una monade leibniziana chiusa nel suo universo, che non comunica con altre monadi vicine – un “testimonade”, se è consentito coniare un vocabolo ad hoc – che percorre il desolato, quasi autistico tragitto dei versi ungarettiani: “Da quella solitudine di stella/ A quella solitudine di stella”.
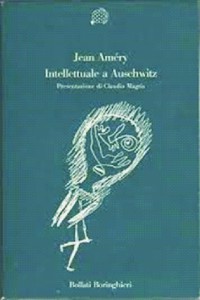 Fu erroneamente definito “teorico del suicidio” per via del suo ultimo libro, Levar la mano su di sé (1976, ma in Italia dal 1990), dove non teorizza affatto il sui ceadere come forma di coercizione assoluta ma la Freitod, la libera morte, quando “il mondo di chi è felice è altro da quello di chi è infelice”, senza rimedio alcuno, seguendo il suo amato Wittgenstein del Tractatus logico-philosophicus. In Intellettuale a Auschwitz, con argomentare calmo e spietata requisitoria, ci racconta la condizione del letterato in un KZ hitleriano: un’etica senza estetica dove la filosofia falliva l’incontro con la realtà e la poesia celebrava le proprie esequie: “Nel Lager era più facile rendersi conto che l’Ente e la luce dell’Essere erano del tutto inservibili”, scriveva come a ridimensionare Heidegger, “si poteva essere affamati, essere stanchi, essere ammalati. Affermare semplicemente che si era, non aveva senso” (pp. 52-53). E ancora, “nessun ponte conduceva dalla morte ad Auschwitz alla Morte a Venezia” (p. 50), perché in Lager qualsiasi forma di arte, di manifestazione dello spirito e dell’intelletto era inservibile, anzi dannosa. La morte in Auschwitz non aveva nulla di eroico, di poetico o anche di decadente: era una morte nuda, ignominiosa e immonda. Nel suo romanzo-saggio del 1974, Lefeu oder der Abbruch (Lefeu o della demolizione), non disponibile in italiano, Améry sembra rovesciare definitivamente i termini della terzina dantesca dedicata a Brunetto Latini, “m’insegnavate come l’uom s’etterna” (Inf. XV, 67). Il Novecento di Améry ha insegnato come l’uomo si demolisce e come si demolisce un uomo.
Fu erroneamente definito “teorico del suicidio” per via del suo ultimo libro, Levar la mano su di sé (1976, ma in Italia dal 1990), dove non teorizza affatto il sui ceadere come forma di coercizione assoluta ma la Freitod, la libera morte, quando “il mondo di chi è felice è altro da quello di chi è infelice”, senza rimedio alcuno, seguendo il suo amato Wittgenstein del Tractatus logico-philosophicus. In Intellettuale a Auschwitz, con argomentare calmo e spietata requisitoria, ci racconta la condizione del letterato in un KZ hitleriano: un’etica senza estetica dove la filosofia falliva l’incontro con la realtà e la poesia celebrava le proprie esequie: “Nel Lager era più facile rendersi conto che l’Ente e la luce dell’Essere erano del tutto inservibili”, scriveva come a ridimensionare Heidegger, “si poteva essere affamati, essere stanchi, essere ammalati. Affermare semplicemente che si era, non aveva senso” (pp. 52-53). E ancora, “nessun ponte conduceva dalla morte ad Auschwitz alla Morte a Venezia” (p. 50), perché in Lager qualsiasi forma di arte, di manifestazione dello spirito e dell’intelletto era inservibile, anzi dannosa. La morte in Auschwitz non aveva nulla di eroico, di poetico o anche di decadente: era una morte nuda, ignominiosa e immonda. Nel suo romanzo-saggio del 1974, Lefeu oder der Abbruch (Lefeu o della demolizione), non disponibile in italiano, Améry sembra rovesciare definitivamente i termini della terzina dantesca dedicata a Brunetto Latini, “m’insegnavate come l’uom s’etterna” (Inf. XV, 67). Il Novecento di Améry ha insegnato come l’uomo si demolisce e come si demolisce un uomo.
Tra presentimento della tragedia e sentimento della testimonianza (come nel caso di Primo Levi o di Elie Wiesel o di Jorge Semprún), Améry chiama in causa il concetto di risentimento e ne fa una sorta di morale. Il reduce deve risentirsi fino alla fine, consapevole, certo, che nessuno ascolterà quel grido, ma suvvia: cos’altro gli resta? Non ha nostalgia del passato, oscurato dall’ombra retroattiva del Lager; si nega il senso del futuro – a chi gli chiedeva perché non mettesse in pratica le sue teorie suicidarie rispondeva: “Un po’ di pazienza, caro amico”; la sua è una continua guerra intellettuale. Contro la Kultur che ha prodotto il mostro che lo ha masticato e rigettato (Germania), contro i collaborazionisti di Vichy, e spesso anche contro gli araldi della memoria (Israele), vale a dire contro carnefici e vittime, quando queste raccolgono, puntandola altrove, la spada dell’intolleranza. Lo scorso anno, la pellicola Anita B., di Roberto Faenza, citava Améry all’interno di un contesto che rendeva quel passo fuorviante: “Dio ha dato gli uomini la dimenticanza”. Solo per chi ne legge, evidentemente. Chi è stato in Lager ha perduto per sempre la benedizione dell’oblio. Nel caso di Améry, tra vivere e morire, scrivere è stato dal 1945 al 1978, un pretesto per rimandare il più possibile la decisione. Sono passati trentasette anni dal suo ultimo pasto a base di barbiturici in un hotel di Strasburgo. È tempo di ricordarlo leggendolo o rileggendolo, e magari scrivendoci su.
[1] P. Levi, Prefazione a A. Bravo – D. Jalla, La vita offesa, in P. Levi, L’asimmetria e la vita, a cura di M. Belpoliti, Einaudi, 2002, p. 138.
[2] J. Améry, Intellettuale a Auschwitz, trad. it., Bollati Boringhieri, 1987, p. 137.
[3] P. Levi, I sommersi e i salvati, (1986), Einaudi, 1991, p. 102.



