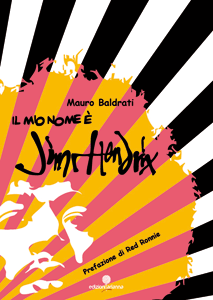 [Pubblichiamo il quarto capitolo del nuovo romanzo di Mauro Baldrati, “Il mio nome è Jimi Hendrix“, in uscita per le edizioni Arianna, Geraci Siculo (PA) 2014, pag. 208 € 13.
[Pubblichiamo il quarto capitolo del nuovo romanzo di Mauro Baldrati, “Il mio nome è Jimi Hendrix“, in uscita per le edizioni Arianna, Geraci Siculo (PA) 2014, pag. 208 € 13.
Mezzaluna (RA), terra di frontiera, dicembre 1969: Toni Rinaldi, detto Jimi Hendrix, ci racconta la sua vita abbacinante “nel paese più infelice del mondo”, tra avventure nebbiose, fantasticherie, balere, discoteche, e tanta, tanta musica]
LA VESTIZIONE
Apro il doppio sportello dell’armadio e guardo le camicie appese. Stasera ho voglia di vestirmi bene, di mettermi le cose giuste. Non potevo certo farlo prima di scendere a cena, avrei regalato a mio padre la soddisfazione di fare i suoi commenti malevoli, mi avrebbe rovinato la cena. Per la verità me la sono rovinata lo stesso con quello scatto contro mio fratello mostro. Ho lo stomaco sottosopra, vengono su dei liquidi acidi che mi bruciano la gola. Mi esce questa violenza cieca contro mio fratello, ma alla fine mi si ritorce contro e sto male più di lui.
Ho bisogno di musica, voglio sentire la sua carezza sui miei centri nervosi che pulsano impazziti. Metto Volunteers, un pezzo potente dei Jefferson Airplane, con la voce di Martin Balin che incendia tutto ciò che tocca. Il suo ritmo veloce e la sua grinta entrano in me e mi irrobustiscono, mi fanno sentire quel guerriero che devo essere se voglio uscire da questa trappola.
Prendo la camicia bianca che ha confezionato zia Alfonsina su mio disegno. Ha un colletto alto fino ai lobi delle orecchie con le punte che scendono lungo il petto come vele triangolari, e maniche a sbuffo che si chiudono con polsini larghi fino a metà avambraccio. Non è proprio perfetta, avrei voluto una stoffa molto colorata con dei disegni particolari, ma nei nostri negozi non si trova niente di niente all’infuori dei soliti tessuti dai colori spenti. E delle camicie già confezionate meglio non parlarne. E lo stesso vale per i pantaloni, le giacche, le cinture, le scarpe: non sono altro che tanti capi di uniformi camuffate, tutti uguali, verdognoli, azzurrastri, marroncini, grigi. Io vorrei delle camicie come quelle di Jimi, sgargianti, originali, ma devo accontentarmi di quello che può fare zia Alfonsina con le poche stoffe che riesco a trovare. E i panciotti di Jimi, stupendi, e i suoi foulard: ho cercato in tutti i negozi dei paesi vicini, ho cercato a Ravenna, ma è impossibile non indossare le giacche marroni e i pantaloni con la piega e le camiciole azzurro smorto. Non c’è altro nei loro empori da soldatini.
Prendo i pantaloni a campana con la frangia, quelli che ho ottenuto facendo tagliare e allargare un paio di jeans da mia zia, e la cintura nera con le borchie gialle costruita da un nostro amico che lavora il cuoio. Dai cassetti dei maglioni tiro fuori la giacca di lana nera senza maniche col collo a V, lunga quasi fino al ginocchio. Questi vestiti sono confezionati abbastanza bene, eppure non sono completamente soddisfatto. Le finiture sono troppo artigianali, le cuciture sempre un po’ storte, i particolari non curati. E poi è tutto in tinta unita, la maledetta pidocchiosa tinta unita!
Il problema più grave è costituito dalle scarpe. Io, Dennis e Rambò abbiamo cercato per mesi un paio di stivali. Avevo già commissionato a zia Alfonsina dei pantaloni aderentissimi da infilare negli stivali, e già mi vedevo camminare a grandi passi con un favoloso paio di stivaloni come quelli che calzava Jack Bruce durante un concerto dei Cream. Niente, non esistono stivali da uomo. Non volevamo crederci, abbiamo visitato tutti i negozi della provincia, ma abbiamo dovuto rassegnarci. In commercio ci sono solo scarpe e scarponi in stile con le divise degli inconsapevoli soldatini. Nient’altro. Sicché siamo costretti ad andare in giro con le loro scarpe anormali, o scarpe da ginnastica. Tutto quello che ho potuto fare è verniciare con smalto rosso il filo esterno della suola e del tacco di un paio di scarponi neri. Però devo fare attenzione, devo camminare flettendo il piede il meno possibile perché la vernice non attacca bene sulla gomma e tende a saltare via. Fosse facile camminare senza flettere il piede. Mi sembra di avere le racchette da neve ai piedi.
Scendo le scale e guardo il giaccone da marinaio appeso all’attaccapanni vicino al portone. Ma prima di indossarlo socchiudo la porta del laboratorio e chiamo mia madre fuori. Ci sono tre donne che mi lanciano sguardi a metà tra il curioso e l’ammirato. Se aprissi completamente la porta le tre clienti ripeterebbero le frasi che ormai ho sentito centinaia di volte: “Oh-oh Lucia come si è fatto grande vostro figlio! Che bel ragazzo che è diventato!” E mia madre farebbe uno dei suoi sorrisi a metà tra il soddisfatto e l’imbarazzato. Probabilmente se i loro figli vestissero come me, se portassero i capelli lunghi come li porto io non li accetterebbero in casa, e i loro mariti direbbero quello che, per fortuna, mio padre non ha mai detto e so che non dirà mai: “Con quei capelli lì non mangi alla mia tavola.” Invece io, il figlio della parrucchiera, sono estraneo al loro ambiente; rappresento uno spettacolo gratuito che possono godersi senza problemi. Non sono obbligate a confrontarsi con me, a mettere in discussione le leggi rigide che governano le loro case.
Mia madre esce dal laboratorio e andiamo in soggiorno. Apre il cassetto del mobile con la vetrina e prende cinque biglietti da mille lire. “Torni tardi?” domanda.
“Boh, non lo so” rispondo con tono vago.
Mia madre ha fretta, deve tornare in laboratorio, ma trova il tempo di lanciarmi un’occhiata e colgo un lampo d’ammirazione nel suo sguardo. “Guarda come ti sta bene la giacca della Wanda” dice. Mia madre ha accettato subito il mio stile, che considera una specie di moda eccentrica. D’altro canto lei stessa mi vestiva in maniera eccentrica: ero l’unico bambino del paese che indossava i calzoni corti anche in inverno, scomodi tubi blu con bottoni bianchi sui risvolti che lei definiva all’inglese, e calzettoni bianchi con la riga blu e scarpe di vernice dure e fredde. Mia madre dice “che bella la camicia dell’Alfonsina” e tocca le lunghissime punte del colletto. Ma poi si rannuvola, mi guarda fisso e dice: “Cos’erano quelle urla di là in cucina?”
Alzo le spalle. “Ma niente.”
“Ogni sera si urla, in questa famiglia. Mi vergogno con le clienti, lo sai?” Sospira. “Ascolta Toni… ecco, la Gigina l’altro giorno mi ha detto: Lucia, che brutto sguardo che ha vostro figlio! Be’ io ci sono rimasta, sai. Perché è vero che hai un brutto sguardo. Come mai sei sempre così serio? Cosa c’è che non va?”
Le sue parole mi colgono di sorpresa. Rimango lì in piedi e sento l’asse della schiena che si incurva. “Che cosa vuol dire un brutto sguardo?” chiedo a muso duro. Sento gli occhi indagatori di mia madre che mi frugano. Cerco di alzare uno schermo per proteggermi da quei lampi di curiosità ansiosa.
“Insomma i tuoi occhi sono… ecco, sembri sempre immerso in pensieri cattivi. Io vorrei sapere perché. Che cosa ti manca dunque? C’è qualcosa che ti neghiamo? Hai qualcosa contro di noi?”
Stringo i pugni e soffio aria dal naso. Vorrei gridarle contro, con tutta l’acrimonia di cui sono capace: “Ma come? Avermi generato ti sembra poco? Avermi fatto uscire in questo mondo falso lurido?” Ma riesco a controllarmi. Voglio solo andare via, togliermi di qua, uscire in strada e vedere i miei amici. E poi gliel’ho già gridato una volta, durante una lite furiosa, e lei ha pianto per tutto il giorno. E l’ha detto a mio padre, che non è riuscito a ribattere niente, è diventato serio e se n’è andato senza dire una parola. Ho imparato sulla mia pelle che devo fare il possibile per evitare queste scenate. Tutto torna indietro, è come sferrare pugni contro un’immagine specchiata e sentire il dolore come se fosse un altro me stesso.
Scuoto la testa, dico “ma va’, che brutto sguardo? Se quella stronza là si facesse gli affari suoi sarebbe meglio!” Ma mia madre continua a fissarmi coi suoi occhi ansiosi, con quella faccia deformata che assume quando lo spavento e la preoccupazione le induriscono i lineamenti.
“Ascolta, voglio parlarti di una cosa” dice, e fa una pausa. Io tengo lo sguardo sulla punta delle scarpe, aspetto nervosamente che riprenda a parlare col suo tono grave-ansioso. “Perché non provi di andare da quel professore che ha detto il dottor Pieroni?”
Scatto subito, dico “no-no” scuotendo la testa con rabbia. Il professore? Secondo il superdottor Pieroni, cui mia madre ha parlato più volte del mio carattere difficile, dovrei consultare un certo specialista delle malattie nervose. Ma io non ho intenzione di andare da nessun dottore o professore, non sono malato, lo vogliono capire? Se uno non è come loro, se non accetta le loro regole dicono che è malato. Lo mandano dai dottori che affondano nel suo corpo aghi, introducono supposte e pillole.
Mi rendo conto all’improvviso che mia madre è lì in piedi di fronte a me e mi vede come un malato. Scuoto la testa e dico “no-no” mentre mia madre insiste, cerca di convincermi che tanto non può farmi niente di male, che è un grande professore che insegna all’università. Lo dice con tono ampolloso, dice “professore” allungando le o, dice “il professooore ti fa una bella visita, non potresti provare, solo provare?” Io sbraito “no! no!”, apro lo porta, esco in corridoio, strappo il giaccone dall’attaccapanni.
Si apre la porta della cucina e fa capolino mio fratello mostro. I suoi occhi sepolti lanciano dardi verso me e mia madre.
Spalanco il portone col giaccone ancora sbottonato, mi butto fuori nella nebbia e lascio loro il colpo violento del portone che si richiude alle mie spalle.



