[Riceviamo dal traduttore un brano di Ultima rumba all’Avana, appena pubblicato da Il Canneto (Genova, 2014, pp. 212, euro 15, traduzione di Marino Magliani)]
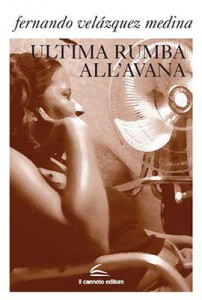 Cinque o sei isolati più all’interno, in quello che una volta era un animato centro, fra Concordia e Galiano, svoltiamo di nuovo verso Águila e parcheggiamo, seguendo le indicazioni di Fermín, su un lato del cinema America. La libreria è in una casa privata e fin da quando ci mettiamo piede possiamo constatare che la maggior parte dei clienti sono stranieri: anziani con un aspetto prospero, da coloniali, accompagnati da fidanzate (o fidanzati, come preferite), giovani con la pelle tersa e i capelli brillanti, occhi verdi che denunciano l’incrocio delle razze, negre lucide, meticci gigolò che accompagnano mature europee, bambine sorvegliate da mammà, affettuosamente unite al padrino di turno. Un uomo snello dai capelli bianchi e dai gesti affettati chiacchiera con un ragazzo robusto dai capelli ricci: una furtiva lacrima… ascolto fra educati bisbigli. Sugli scaffali ci sono stampe di pittori antillani, Zaida del Río, Chocolate, una foto di Silvio Rodríguez, fatta da Gori, coglie il cantante mentre volta il viso verso il fotografo che sta alle sue spalle e intanto, di fronte, un pubblico di giovani ruggisce. Il nano e la Monca si sono uniti al signore distinto che parla di opera e salutano il giovane dai capelli lisci. Fermín e io guardiamo libri dai prezzi utopici: Nadja di Breton, nell’edizione di Joaquín Mortiz; José Trigo di Fernando del Paso, edito da Siglo XXI così come Poesía en movimiento, classica antologia di don Octavio e Alí Chumacero.
Cinque o sei isolati più all’interno, in quello che una volta era un animato centro, fra Concordia e Galiano, svoltiamo di nuovo verso Águila e parcheggiamo, seguendo le indicazioni di Fermín, su un lato del cinema America. La libreria è in una casa privata e fin da quando ci mettiamo piede possiamo constatare che la maggior parte dei clienti sono stranieri: anziani con un aspetto prospero, da coloniali, accompagnati da fidanzate (o fidanzati, come preferite), giovani con la pelle tersa e i capelli brillanti, occhi verdi che denunciano l’incrocio delle razze, negre lucide, meticci gigolò che accompagnano mature europee, bambine sorvegliate da mammà, affettuosamente unite al padrino di turno. Un uomo snello dai capelli bianchi e dai gesti affettati chiacchiera con un ragazzo robusto dai capelli ricci: una furtiva lacrima… ascolto fra educati bisbigli. Sugli scaffali ci sono stampe di pittori antillani, Zaida del Río, Chocolate, una foto di Silvio Rodríguez, fatta da Gori, coglie il cantante mentre volta il viso verso il fotografo che sta alle sue spalle e intanto, di fronte, un pubblico di giovani ruggisce. Il nano e la Monca si sono uniti al signore distinto che parla di opera e salutano il giovane dai capelli lisci. Fermín e io guardiamo libri dai prezzi utopici: Nadja di Breton, nell’edizione di Joaquín Mortiz; José Trigo di Fernando del Paso, edito da Siglo XXI così come Poesía en movimiento, classica antologia di don Octavio e Alí Chumacero.
In un angolo, rosicchiata dai topi, la Balada del barrio dorme il sonno dei dimenticati, anche se mastica perfettamente il linguaggio popolare. Vedo un’edizione italiana di Tres tristes tigres, con foto in prima e quarta di copertina di Jessie Fernandez, anche se Chino Lope giura e spergiura, mentre si fa invitare a pranzo o fuma le tue sigarette, che sono così poco sue come quelle di Lezama, Cortázar e Roque Dalton, del quale si racconta che una volta, vedendosi arrivare in casa il Chino a notte fonda, lo invitò a cena. Impressionato, Lope chiese un sigaro e poi di fare un bagno. Uscendo dal bagno, Chino gli chiese dieci pesos e quando già era sulla porta, sazio, lavato e arricchito, quel figlio di mignotta di Roque gli chiese se non gradiva salire a farsi anche sua moglie, in modo da andarsene con il servizio completo.
C’è un grosso tomo che mi interessa. Si intitola Fin de siglo en la Habana e racconta, a quanto vedo, gli anni duri cominciati con la morte di Ochoa e il gemello di Tony de la Guardia. I ritornelli l’hanno cantato mille volte: uccidere gemelli porta sventura. Rimetto a posto il libro e spio cosa sta sfogliando Fermín: un libro rilegato, piccolo, come una Bibbia, con pagine finissime. Mi affaccio al di sopra delle sue spalle, lui se ne accorge e chiude il librino. Lo guardo senza capire e lui mi spiattella che il Profeta, la pace sia con lui, ha proibito che le donne leggano il libro sacro, la madre di tutti i libri. Tante storie per il Corano, che ho già letto mille e una volta nella biblioteca dell’ambasciatore!
Fermín continua a raffinarsi con il Libro, e io faccio scorrere lo sguardo su ben noti in folio: Cimarrón di Miguel Barnet, Il palazzo delle bianchissime puzzole, di Arenas, pubblicato a Caracas da Monte Ávila, l’edizione commentata e annotata di Paradiso fatta da Aguilar, un libricino di poesie di Alfonso Reyes dedicato a Labrador Ruiz, l’edizione principale di La sangre hambrienta, squinternata e fragile.
“Questa edizione, curata da Félix Ayón II, consta di novecento copie su carta antica e cento, numerate e fuori commercio, in carta di lino. Finito di stampare il 30 marzo 1950 nelle officine di Ayón, stampatore in L’Avana, Cuba”. È quanto sta scritto nel colofone.
La prima pagina, tenuta su da uno scotch, porta scritto in inchiostro blu ancora leggibile: “A Edo Abela Con grande stima Labrador Ruiz”. Lo decifro facendo un po’ di fatica: A Edo. Abela Con grande stima. Labrador Ruiz. Mi dà fastidio che due parole comincino con la minuscola, ma ognuno scrive come gli pare, e se non siete d’accordo guardate Juan Ramón Jiménez.
Lì vicino ci sono i racconti di Virgilio Piñeira, nella collezione Bolsilibros Unión, 1964 e, dorso contro dorso, la settima edizione corretta e aumentata di CUBA, Dittatura o Democrazia, Siglo XXI Editori. La copertina è di Ricardo Harte, forse un eteronimo di Armando Hart: due contadini sudati e sporchi di grasso inerpicati su un trattore. Fra loro sta seduto un piccolo campagnolo, magari è Reinaldo Arenas quando era borsista del governo. Dunque la ben nota democratica cilena Maria Harnecker ha diretto la produzione dell’originale. Grazie alla geniale supervisione di suo marito, l’egregio liberale Manuel Piñeiro Losada, il comandante Barba Rossa, coordinatore di tutte le guerriglie dell’America Latina, la democrazia cubana è arrivata fino in Nicaragua e Mozambico, Angola e Yemen. Disgraziatamente, quegli slealissimi popoli hanno adottato i vizi del capitalismo: mangiare tre volte al giorno, comperare i vestiti che preferiscono e fare a meno dei discorsi che durano dieci ore. Manica di lacchè!
Nascosto in uno scaffale trovo un libro di John Grisham, Il rapporto Pelican; scelgo Congo di Michael Crichton e La quinta nave dei folli, di Manuel Pereira, che ha avuto il premio nazionale della critica nel ’90, mi pare. Vado a pagare trentacinque dollari quando mi cascano gli occhi su un libro di poesie che assicura che fuori sta piovendo, ma alle finestre non si vede neanche uno spruzzo di saliva. Forse l’autrice sta a Parigi sotto un acquazzone, e da qui le sue previsioni metereologiche sballate.
Mi presentano al signore con ciuffo candido e al suo interlocutore, giovane aspirante a cantante d’opera. Lo straniero parla di peste, non la puzza della città, no: la Peste di Camus. Io preferisco i Moschettieri, dico. E tutti, compresi quelli che non sanno di che cosa sto parlando, mi guardano come una chichimeca, una barbara, ignorante e zotica. Sorrido solo da un lato della bocca e un sospiro di sollievo collettivo sottolinea il mio gesto interpretandolo come una boutade, uno scherzo, una provocazione culturale. Tutti si rilassano vedendo che non insisto a mettere Dumas più in alto di Camus, Karl May (uno degli pseudonimi di Carletto Marx) più in alto di Goethe, Frankenstein sopra a Re Lear, David Bussi sopra Francisco Garzón Céspedes, Corín Tellado sopra Carmen Martín Gaite, Françoise Sagan sopra la Yourcenar.
Di dove sono i cantanti? Per un attimo mi sembra che qualcuno, in modo incongruo, l’abbia chiesto. Ah! Sta parlando di Severo Sarduy, dei suoi romanzi illeggibili, splendidi. Un signore si unisce al discorso affermando che Donoso scrisse Terra Nostra per emulare Carpentier. Immagino che un ceco sotto mentite spoglie ne concluderebbe che di questi tempi si può scrivere solo alla maniera di Kundera. García Márquez è morto, a mia insaputa, dopo aver scritto Cade la notte tropicale, ma questo non è un libro di Guillermo Cabrera Infante? Quello che più mi ha colpito è L’osceno uccello della gioventù… no, no Il dolce uccello della notte, correggersi è cosa saggia. Si discute se Alejandra Olmos dettò o compose realmente Sobre heroes y turbamultas. A proposito: Nadja divenne l’amante di Paul Eluard e in seguito visse insieme ad Aragón con lo pseudonimo di Elsa Triolet.
Tiro fuori il mio ormai frollato numero della polacca che ai tempi di Stalin mise quattro libri russi in vetrina nella libreria del paese: Tutti vogliamo essere, Lontano da Mosca, Oltrefrontiera, Sotto altre bandiere. Per la sua alzata d’ingegno ottenne un viaggio: a prendere il sole sulle spiagge della Siberia. Ridono, di gusto o non di gusto, con risate veloci, le orecchie ferme per sentire il pericolo, cercando di sniffare un potenziale poliziotto, un delatore o semplicemente un bravo cittadino desideroso di ottenere una borsa di studio all’estero per suo figlio, perché possa disertare.
In un angolo vedo dei cartoncini con disegnati dei cavalli che corrono liberi, con la criniera al vento. Sono firmati Zaida del Río. Ricordo che anch’io possiedo dei disegni suoi, li ho lasciati in casa di amici. Ritraggono vergini in diversi atteggiamenti, nude ma con il volto velato, abbozzi un po’ casuali che si srotolano fin sui bordi del cartoncino. Un pomeriggio di luglio al “Caimàn”, Zaida chiacchierava e disegnava, appoggiata alla scrivania di Peyi, e le piccole femmine venivano fissate su quella opaca superficie. Appena Zaida uscì ci lanciammo tutti all’assalto, le rapimmo, e il mio bottino si ridusse a due cartoncini con quelle figure che chiamo vergini.
La libreria è diventata un mercato arabo, il rumore di fondo, il bisbigliare educato copre le voci di ciascuno e già non riesco a capire cosa dice il giovane dai bei ricci su Saffo, Albertine e altri personaggi femminili. L’odore di pergamena polverosa si mescola con qualcosa di dolce che impregna l’ambiente, profumo da puttane che non emana dal mio corpo; questo posto non mi piace più, preferisco continuare il viaggio verso Alamar.



