di Alberto Laiseca
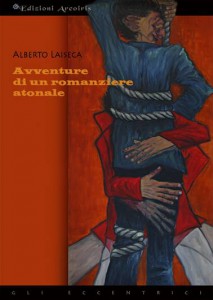 [Un estratto dal romanzo Avventure di un romanziere atonale, traduzione di Loris Tassi, Edizioni Arcoiris, 2013, pp. 116, € 10]
[Un estratto dal romanzo Avventure di un romanziere atonale, traduzione di Loris Tassi, Edizioni Arcoiris, 2013, pp. 116, € 10]
In una stanza cavernosa, quasi sferica, un romanziere scriveva. Qualcosa di molto divertente, pare.
Le pareti e il soffitto erano curvi: il pavimento aveva al centro un profondo avvallamento, un’orrenda fossa, un abisso sulla cui cresta tavolo, sedie, armadio e romanziere facevano mostra delle loro doti di alpinisti. Il soffitto invece – cosa assai curiosa – era arcuato verso l’alto, come se una violenta esplosione lo avesse trasformato in una lurida superficie concava. La sua forma stranissima deve essere attribuita, più che all’imperizia, alle singolari idee architettoniche di chi si era occupato di restaurare quell’edificio quasi centenario. Infastidito dai continui crolli, si era detto: «Il tetto è caduto più di tre volte. Più di quattro non dovrà cadere». Così gli aveva dato la forma di una cupola, poi l’aveva plastificato e aveva decorato il tutto con motivi adeguati. Per la sua Cappella Sistina aveva seguito un metodo che oscillava tra antico e moderno.
Aveva dipinto lunghe file ondulate di rombi intrecciati ai vertici, alcuni dei quali racchiudevano delle rose azzurre su un fondo lilla sfumato, mentre altri erano di un colore impossibile da descrivere che chiamerò cotoletta fritta. La lucentezza oleosa era data dalla plastificazione. La superficie della cupola era lavabile anche se in cinque anni nessuno si era mai preoccupato di pulirla; la cattiva combustione della stufa a cherosene e le nubi fosche e asfissianti che esalavano dall’immancabile stufato erano riuscite ad affumicare tutto, neanche fosse pancetta. Non vorrei che mi si accusasse di eccessiva pignoleria, ma non posso evitare, in questo caso, di essere ancora più preciso: il soffitto aveva esattamente il colore di quei manufatti che i riduttori di teste espongono per giorni interi al calore di un fuoco fumante fino a fargli raggiungere la grandezza di un pugno.
Che spettacolo! Il romanziere, distratto, non si accorgeva di niente e scriveva senza mai interrompersi in tutti i momenti liberi che il suo lavoro di uomo delle pulizie gli gettava come briciole.
In alcuni periodi lo scrittore si era visto costretto a dividere con due, tre o più compagni una mansarda sempre miserrima, fredda e umida in inverno, insopportabilmente calda in estate e con il bagno in comune con altre cinquanta persone.
La proprietaria della pensione – che, per ragioni di nobiltà, preferisco chiamare Reggente e che continuerà a essere citata con questo epiteto finché l’inesistente sovrano resterà minorenne – era come una madre per tutti loro.
Aveva due occhi di vetro, Doña Clota in pantofole. Due occhi di vetro e, ciononostante, vedeva alla perfezione. Sempre, sia in inverno sia in estate, usava variopinte vestaglie imbottite, sulla cui superficie lisa si erano formati per agglutinazione degli immondi, minuscoli pompon. Incommensurabile, la sua crocchia di regina. Di certo era venuta al mondo prima la crocchia e poi lei. Lì risiedeva la sua potenza, il segreto della sua forza. Nessuno lo sapeva, ma se un incidente l’avesse privata di quella vera e propria torre si sarebbe verificato non solo il crollo psicotico, ma anche la caduta materiale di tutta la pensione Usher. Lì, dunque, come in una specie di tavola di smeraldo, era depositato il suo segreto filosofale. Sansone e i Filistei, come si suol dire.
A volte la vecchia si comportava come se l’espansione dell’edificio di sua proprietà fosse un problema analogo a quello di aggiungere nuove camere alla Grande Piramide. E così, in veste di Faraona, con la corona dei due regni sulla testa e una barba posticcia ben attaccata al mento nel caso qualcuno dubitasse dei suoi attributi virili, impugnando l’uncino che ghermisce e manda a cuccia e la frusta che castiga – se non le piace se ne vada –, proprio come un tempo aveva fatto Cheope, ordinava ai suoi Egizi e ai suoi Nubiani di levigare e trasportare nuovi blocchi di pietra.
Ogni settimana, da circa venticinque anni, giocava al totocalcio con religiosa dedizione. Non riuscì mai a fare più di sette punti, sui tredici indispensabili per vincere. Le aveva provate tutte: mettere le crocette a occhi chiusi, compilare la schedina sempre nello stesso modo (lo aveva fatto per ben cinque anni, poi si era demoralizzata); infine aveva deciso di applicare un sistema statistico di sua invenzione. In tutti quegli anni di tentativi vani, infatti, aveva creato un enorme archivio che poteva essere utilizzato come banca dati.
Ogni società era rappresentata da una lettera, e ogni giocatore da un numero. Bisognava prendere in considerazione tutte le variabili.
Per esempio: aveva notato che il giocatore 138, della squadra J giocava meglio alla fine e all’inizio del mese (forse per la vicinanza dello stipendio). Inoltre si comportava in maniera egregia nei giorni di pioggia. Erano dati da considerare. Il 138 rimase nella J per due anni, ma a un certo punto, con grande orrore della vecchia, la squadra lo vendette a X. Come avrebbe reagito nella nuova situazione? Ecco una variabile importante di cui era impossibile prevedere il comportamento.
Il sistema dell’anziana signora era inapplicabile: era come voler risolvere un’equazione con ventottomilaquattrocentotrentadue incognite. Se ne ricavava una, gliene rimanevano altre ventottomilaquattrocentotrentuno che saltavano, vibravano, mutavano, si facevano beffe di lei.
Teneva conto di mille altre possibili alterazioni: i cam-biamenti politici e il modo in cui potevano influire sull’ani-mo dei giocatori (per ognuno dei quali, credo di averlo insinuato, possedeva un fascicolo voluminoso: la vecchia, da questo punto di vista, era peggio della Gestapo o del K.G.B.); se un atleta si era sposato, se gli era nato un figlio, se gli era morto un parente; se i giornali parlavano di lui – cosa che, senza dubbio, avrebbe influito sulla sua potenza interna e sulla sua creatività –; se si era venuto a sapere di una storia con la stellina, la modella o la vedette del momento. Particolare curioso, la vecchia pensava che l’influenza di un fatto del genere non fosse sempre benefica. A volte diceva: «Quella svergognata gli ha mangiato il cervello. Non fa che pensare a lei. Ora giocherà male». Altre volte, invece, in modo del tutto arbitrario – o forse influenzata dai pettegolezzi mondani –, assicurava: «Lei lo rende felice, gli trasmette serenità. Tutto andrà per il meglio».
Tra le variabili rientravano arbitri, allenatori, direttori tecnici, presidenti. Prestava moltissima attenzione alle interviste per scoprire, ascoltando le varie lamentele, se una determinata società sportiva stava attraversando un periodo di difficoltà finanziarie.
Quando un campione si ritirava dal calcio, la vecchia non lo dimenticava. Il suo fascicolo restava nell’archivio. «Non si può mai sapere, forse un giorno allenerà qualche squadra».
Un pomeriggio l’anziana signora modificò il suo pronostico mezz’ora prima della chiusura delle scommesse perché aveva iniziato a piovere. «Campo pesante. Sono costretta a fare un cambiamento. Il 138, nella J, gioca meglio quando piove. Quindi potrebbe vincere J, non B. L’unico problema è che si gioca nello stadio di B e non in quello di J. Meglio puntare sul pareggio».
E così via.
Teneva conto di cose impensabili, come la pressione psicologica dei tifosi. Per esempio: aveva notato che i tifosi di C erano abbastanza pigri nei giorni di pioggia, a differenza di quelli di F, che andavano allo stadio sia in casa sia fuori, venisse pure il diluvio universale. Pertanto, se in un giorno di pioggia F giocava contro C, nello stadio di C, la forza dei tifosi di C sarebbe stata superata dalla loro indolenza. E senza ombra di dubbio l’energia collettiva avrebbe indirizzato la risultante in favore di F.
Non vinse mai, l’ho già detto. Ciononostante, in certi periodi riusciva a coltivare il suo sogno più grande: espandere la sua sgangherata supercasa. In che modo? Grazie agli inquilini, naturalmente. Se non le piace se ne vada. Gli inquilini erano la sua vera scommessa, e con loro vinceva sempre.



