Oggi nel liceo “Claudio Cavalleri” di Parabiago il suono della prima campanella sarà più triste del solito. Mancherà a quel liceo e ai suoi studenti un bravo insegnante e un uomo sincero, Valter Binaghi. Per ricordarlo, a due mesi dalla sua dipartita, pubblico il testo di un mio intervento a un seminario sulla didattica dello scorso novembre.
In prima battuta vorrei spiegare il senso del titolo che ho dato a questo mio intervento. Sono convinto – e cercherò di dimostrarlo – che il sistema scolastico, e più in generale quello degli apprendimenti, non abbia bisogno tanto di un elenco di materie e argomenti, quanto di una riflessione sugli strumenti con cui si agisce e si interagisce nel capo dell’apprendimento. È chiaro che parlare di strumenti cognitivi, piuttosto che di argomenti o materie, significa focalizzare l’attenzione non sui “contenuti”, ma su quelli che l’idioletto burocratico-scolastico chiama “competenze” e “capacità”, e che io preferisco chiamare strutture logico-cognitive. Cerco di chiarire subito questo concetto con un esempio che viene da un autore – Raoul Vaneigem – che assieme a Bateson costituisce per me la stella polare di una didattica libertaria. Scrive Vaneigem, nel suo Avviso agli studenti [ qui una sintesi,
qui una sintesi,  qui il testo integrale], che «una scuola in cui la vita si annoia educa solo alla barbarie». Cosa c’è un questa affermazione? In primo luogo, la centralità della vita, del bios: non questa o quella vita, tantomeno quel fumoso concetto di vita che viene agitato in modo apodittico e selettivo dai difensori del cosiddetto “diritto alla vita sin dal concepimento”. La vita di cui qui si tratta è quella concreta, materiale, di tutti i partecipanti all’interazione educativa, quella vita che ci attraversa tutti senza essere specificamente “posseduta” da alcuno, perché di essa non si può fare oggetto di possesso. Una vita che ha dei diritti, radicati nella potenza di essere e di metamorfosi che costituisce la sua stessa essenza. Di quale barbarie parla Vaneigem? Dell’educazione all’ordine gerarchico, all’apprendimento passivo, all’obbedienza. All’accettazione dei rapporti umani fondati sulla riduzione dell’essere umano a merce, all’interno di «un angusto orizzonte giuridico che costringe a calcolare con la durezza di uno Shylock: non avrò per caso lavorato mezz’ora più di un altro, non avrò guadagnato un salario inferiore a un altro?» Di cosa ha bisogno, per contro, una vita per non cadere nella noia, e con essa nell’acritica accettazione della barbarie? In un paese civile non ci dovrebbe essere bisogno di un magistrato anti-mafia per ricordare che le scuole dovrebbero essere ampie, belle e colorate: ma se il paese ha perso il senso della civiltà che dimora nel giusto valore che pretendono la scuola, gli insegnanti e i discenti, ben venga la parola di Nicola Gratteri a ricordarcelo. Perché la dimensione, il colore e il valore estetico dell’ambiente non sono orpelli o accessori: sono parte integrante di uno scambio educativo all’interno del quale ciò che è in questione è la ricchezza, ovvero la miseria, degli stimoli cognitivi, e con essi dell’arricchimento della mente, della maturazione di una coscienza critica, di una mente educata alla pluralità delle logiche e delle strategie operative nella ricostruzione dei rapporti di causa ed effetto. Sono temi che un tempo erano relegati nelle utopie educative dei don Milani o degli Ivan Ilic, e che oggi sono al centro di quella rivoluzione epistemologica che ruota attorno alla scoperta delle intelligenze multiple, e del funzionamento dei neuroni a specchio: scoperte che non vanno mitizzate – reitrodurremmo altrimenti un oggettivismo scientifico di sapore ottocentesco –, ma che ci rafforzano nel convincimento che l’ambiente e l’interazione sono parte integrante del processo cognitivo.
qui il testo integrale], che «una scuola in cui la vita si annoia educa solo alla barbarie». Cosa c’è un questa affermazione? In primo luogo, la centralità della vita, del bios: non questa o quella vita, tantomeno quel fumoso concetto di vita che viene agitato in modo apodittico e selettivo dai difensori del cosiddetto “diritto alla vita sin dal concepimento”. La vita di cui qui si tratta è quella concreta, materiale, di tutti i partecipanti all’interazione educativa, quella vita che ci attraversa tutti senza essere specificamente “posseduta” da alcuno, perché di essa non si può fare oggetto di possesso. Una vita che ha dei diritti, radicati nella potenza di essere e di metamorfosi che costituisce la sua stessa essenza. Di quale barbarie parla Vaneigem? Dell’educazione all’ordine gerarchico, all’apprendimento passivo, all’obbedienza. All’accettazione dei rapporti umani fondati sulla riduzione dell’essere umano a merce, all’interno di «un angusto orizzonte giuridico che costringe a calcolare con la durezza di uno Shylock: non avrò per caso lavorato mezz’ora più di un altro, non avrò guadagnato un salario inferiore a un altro?» Di cosa ha bisogno, per contro, una vita per non cadere nella noia, e con essa nell’acritica accettazione della barbarie? In un paese civile non ci dovrebbe essere bisogno di un magistrato anti-mafia per ricordare che le scuole dovrebbero essere ampie, belle e colorate: ma se il paese ha perso il senso della civiltà che dimora nel giusto valore che pretendono la scuola, gli insegnanti e i discenti, ben venga la parola di Nicola Gratteri a ricordarcelo. Perché la dimensione, il colore e il valore estetico dell’ambiente non sono orpelli o accessori: sono parte integrante di uno scambio educativo all’interno del quale ciò che è in questione è la ricchezza, ovvero la miseria, degli stimoli cognitivi, e con essi dell’arricchimento della mente, della maturazione di una coscienza critica, di una mente educata alla pluralità delle logiche e delle strategie operative nella ricostruzione dei rapporti di causa ed effetto. Sono temi che un tempo erano relegati nelle utopie educative dei don Milani o degli Ivan Ilic, e che oggi sono al centro di quella rivoluzione epistemologica che ruota attorno alla scoperta delle intelligenze multiple, e del funzionamento dei neuroni a specchio: scoperte che non vanno mitizzate – reitrodurremmo altrimenti un oggettivismo scientifico di sapore ottocentesco –, ma che ci rafforzano nel convincimento che l’ambiente e l’interazione sono parte integrante del processo cognitivo.
Mi sto muovendo (credo lo si sia capito) all’interno di quell’orizzonte delineato cinque secoli or sono da Michel Eyquem, signore di Montaigne (ma potrei citare con pari dignità la mente poetica e gli universali fantastici di Giambattista Vico): «per un figlio di buona famiglia che si volga alle lettere, non per guadagno (perché uno scopo tanto abietto è indegno della grazia e del favore delle Muse, e poi riguarda gli altri e dipende dagli altri), e non tanto per i vantaggi esteriori quanto per i suoi personali, e per arricchirsene e ornarsene nell’intimo, se si desidera farne un uomo avveduto piuttosto che un dotto, vorrei che si avesse cura di scegliergli un precettore che avesse la testa ben fatta piuttosto che ben piena, e che si richiedessero in lui ambedue le cose, ma più i costumi e l’intelligenza che la scienza» (Saggi, I, 26). Questo precettore, prosegue Montaigne, dovrebbe far sì che il discepolo gusti, scelga e discerna le cose da sé; dovrebbe saper ascoltare il discepolo, e non parlare lui solo; dovrebbe sapersi adattare alle possibilità dell’allievo con giusta proporzione, piuttosto che cercare di governare una molteplicità di spiriti col una sola e medesima lezione per tutti; che sappia giudicare il profitto che l’allievo avrà tratto non dalle prove della memoria, ma da quelle della vita; che faccia esporre ciò che l’allievo ha appreso in cento guise e adattamenti diversi; che gli faccia vagliare ogni cosa e non gli metta in testa nulla con la sua sola autorità. L’insegnamento di cui scrive Montaigne necessita della libertà che è negata tanto al cortigiano, e ha luogo nel commercio con gli uomini, nell’osservazione e nella conoscenza attiva di uomini, linguaggi e contesti diversi da quello di appartenenza – compreso quello familiare: «Dal frequentare la gente si ricava una meravigliosa chiarezza per giudicare gli uomini. […] Questo gran mondo, che alcuni moltiplicano ancora come specie sotto un genere, è lo specchio in cui dobbiamo guardare per conoscerci per il verso giusto. Insomma, voglio che questo sia il libro del mio scolaro».
Ciò che Montaigne ha compreso in modo mirabile è che il perimetro dell’orizzonte educativo è la linea di un’ellisse, perché l’apprendimento è un processo che ruota attorno a non uno, ma due fuochi: il docente e il discente. E che ciascuno dei due fuochi può scambiare il proprio posto con l’altro.
La testa ben fatta di cui parla Montaigne è una testa che apprende ciò che serve a renderla più saggia e migliore, e che con questi mezzi affronta le diverse discipline e i loro contenuti, per venire a capo della scienza che tale testa sceglierà. Se teniamo ben salda come stella polare questa riflessione, dobbiamo chiederci come e cosa deve insegnare la testa ben fatta del precettore del terzo millennio, a fronte di una crisi e di un mutamento di paradigma globale la cui radicalità non è minore della crisi e dei nuovi paradigmi che Montaigne intuì sul crinale del Rinascimento.
Ma lasciamo, prima di affrontare questo passaggio, un’ultima volta la parola al 26° capitolo del primo libro dei Saggi: «Come Anassimene scriveva a Pitagora: “con che coraggio posso perdere il mio tempo a conoscere il segreto delle stelle, quando davanti agli occhi ho sempre presente o la morte o la schiavitù?”, ognuno deve dire così: “Agitato dall’ambizione, dalla cupidigia, dalla temerarietà, dalla superstizione, e avendo dentro di me altri simili nemici della vita, mi metterò a pensare al moto del mondo?”».
La metafora di un nemico alle porte è, nel testo di Montaigne, il significante per alludere a quelle che Spinoza avrebbe poi chiamato “passioni tristi”, nemiche della vita perché asservitrici e disciplinatrici della mente. Nell’epoca presente, io credo che si possa rafforzare l’immagine dei persiani per indicare dei nemici reali della vita e della mente, attraverso i quali comprendere meglio cos’è la scuola del terzo millennio, e come al suo interno si debba agire.
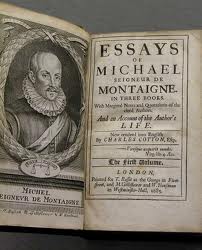 Perché abbia senso la questione di cosa insegnare a scuola, è necessario che vi sia una scuola, e che tale scuola sia, in senso ampio, “pubblica”. Quando si parla di “scuola pubblica”, si intende non solo e non tanto il suo gestore o amministratore, quanto l’insieme di valori pubblici e diritti (e correlati doveri) cui l’attributo “pubblico” allude: e cioè a quella capacità, sancita dalla Costituzione di essere cittadini attivi, ossia di esercitare in maniera autonoma e critica i correlati diritti costituzionali. Si allude, per chi parla con cognizione di causa, a una “scuola costituzionale” che non si riduce al solo articolo 3 della Costituzione. Qui possiamo solo nominare un problema che resta sullo sfondo, ma che va comunque tenuto presente: e cioè l’incapacità dello Stato di garantire, attraverso lo strumento del lavoro, la rimozione di quegli ostacoli e disuguaglianze che impediscono il pieno accesso ai diritti costituzionali e alla piena espressione della persona. Nondimeno questo tema va richiamato, perché sono proprio le trasformazioni avvenute nel campo del lavoro a rendere il lavoro non più strumento di riduzione delle disuguaglianze (posto che questa intenzione abbia avuto effettiva attuazione negli anni ormai etichettati come quelli della prima repubblica). Una scuola pubblica, in definitiva, rimanda non solo all’esistenza di beni pubblici, possibilmente gratuiti o comunque accessibili a tutti, come edifici, testi scolastici e qualsivoglia supporto materiale; e all’esistenza di un congruo numero di dipendenti retribuiti dallo Stato (o dagli enti locali), la cui esistenza, come la costruzione, gestione e manutenzione degli edifici, trae linfa dalla ricchezza prodotta con la cooperazione sociale. Una scuola pubblica ha a che fare, sia in entrata (e cioè come ciò che riceve dalla società nella quale è radicata), sia in uscita (e cioè come soggetto attraversato dalle pratiche educative in senso lato, e restituito alla società in quanto trasformato dalle pratiche di soggettivazione), con l’interazione sociale, «le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via»: ossia con la capacità di produrre e criticare questi aspetti dei processi di soggettivazione, che nel burocratese invalso nella pratica didattica (dai documenti della Commissione Europea giù giù fino ai Piani di Offerta Formativa delle singole scuole) si riassume in indeterminati elenchi di “competenze” e “capacità”. E questo diventa ancor più vero con l’ingresso nella società dell’informazione, del capitalismo cognitivo e della produzione di merci immateriali. E dunque, piuttosto che difendere una parola ormai screditata (e ormai inadeguata) come “pubblico”, sembra più utile ricorrere al concetto di “comune”, quel common del commonwealth nel quale risuona l’accezione originaria del Comune virtuoso esaltato dal Machiavelli dei Discorsi: con le parole di Negri e Hardt (Comune. Oltre il pubblico e il privato), «il comune di cui si sta parlando non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti». Un’accezione che risalta ancor di più se prendiamo come riferimento il termine antitetico, e cioè “privato”, nella sua accezione più autentica: e cioè quella di privatus. Il privatus, nel diritto romano, è colui al quale manca qualcosa, perché si priva della relazione pubblica, cioè del pubblico interesse: di quel inter hominem esse in cui, secondo Cicerone, consiste il vero significato di “interesse”.
Perché abbia senso la questione di cosa insegnare a scuola, è necessario che vi sia una scuola, e che tale scuola sia, in senso ampio, “pubblica”. Quando si parla di “scuola pubblica”, si intende non solo e non tanto il suo gestore o amministratore, quanto l’insieme di valori pubblici e diritti (e correlati doveri) cui l’attributo “pubblico” allude: e cioè a quella capacità, sancita dalla Costituzione di essere cittadini attivi, ossia di esercitare in maniera autonoma e critica i correlati diritti costituzionali. Si allude, per chi parla con cognizione di causa, a una “scuola costituzionale” che non si riduce al solo articolo 3 della Costituzione. Qui possiamo solo nominare un problema che resta sullo sfondo, ma che va comunque tenuto presente: e cioè l’incapacità dello Stato di garantire, attraverso lo strumento del lavoro, la rimozione di quegli ostacoli e disuguaglianze che impediscono il pieno accesso ai diritti costituzionali e alla piena espressione della persona. Nondimeno questo tema va richiamato, perché sono proprio le trasformazioni avvenute nel campo del lavoro a rendere il lavoro non più strumento di riduzione delle disuguaglianze (posto che questa intenzione abbia avuto effettiva attuazione negli anni ormai etichettati come quelli della prima repubblica). Una scuola pubblica, in definitiva, rimanda non solo all’esistenza di beni pubblici, possibilmente gratuiti o comunque accessibili a tutti, come edifici, testi scolastici e qualsivoglia supporto materiale; e all’esistenza di un congruo numero di dipendenti retribuiti dallo Stato (o dagli enti locali), la cui esistenza, come la costruzione, gestione e manutenzione degli edifici, trae linfa dalla ricchezza prodotta con la cooperazione sociale. Una scuola pubblica ha a che fare, sia in entrata (e cioè come ciò che riceve dalla società nella quale è radicata), sia in uscita (e cioè come soggetto attraversato dalle pratiche educative in senso lato, e restituito alla società in quanto trasformato dalle pratiche di soggettivazione), con l’interazione sociale, «le conoscenze, i linguaggi, i codici, l’informazione, gli affetti e così via»: ossia con la capacità di produrre e criticare questi aspetti dei processi di soggettivazione, che nel burocratese invalso nella pratica didattica (dai documenti della Commissione Europea giù giù fino ai Piani di Offerta Formativa delle singole scuole) si riassume in indeterminati elenchi di “competenze” e “capacità”. E questo diventa ancor più vero con l’ingresso nella società dell’informazione, del capitalismo cognitivo e della produzione di merci immateriali. E dunque, piuttosto che difendere una parola ormai screditata (e ormai inadeguata) come “pubblico”, sembra più utile ricorrere al concetto di “comune”, quel common del commonwealth nel quale risuona l’accezione originaria del Comune virtuoso esaltato dal Machiavelli dei Discorsi: con le parole di Negri e Hardt (Comune. Oltre il pubblico e il privato), «il comune di cui si sta parlando non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti». Un’accezione che risalta ancor di più se prendiamo come riferimento il termine antitetico, e cioè “privato”, nella sua accezione più autentica: e cioè quella di privatus. Il privatus, nel diritto romano, è colui al quale manca qualcosa, perché si priva della relazione pubblica, cioè del pubblico interesse: di quel inter hominem esse in cui, secondo Cicerone, consiste il vero significato di “interesse”.
In questa accezione risuona il sempre attuale argomento di Thomas Paine in favore dell’egualitarismo, che nella riformulazione di Guy Standing suona così:
«Tutti noi dobbiamo il nostro benessere sociale ed economico agli sforzi delle innumerevoli generazioni dei nostri antenati. È palesemente disonesto predicare che il reddito rifletta una distribuzione meritocratica, che coloro che diventano ricchi lo fanno grazie al loro merito e impegno. In una certa misura, qualcuno fa meglio di altri col duro lavoro e la vivacità d’ingegno. Ma l’eredità collettiva è qualcosa che nessuno di noi, individualmente, ha donato alla società. È la ricchezza che essa rappresenta a dover essere condivisa».
Ciò che vale per la ricchezza materiale, vale a più forte ragione per la ricchezza della mente, e cioè per il sapere che non è di nessuno perché è di tutti. A questa riflessione vorrei collegare le parole di un testo sugli ambienti di apprendimento alla luce delle neuroscienze: «Il cervello umano è costantemente alla ricerca di schemi e collegamenti tra aspetti diversi della realtà esterna e tutto questo viene archiviato nella propria rete neuronale che così cresce e si sviluppa. Quando si sviluppano apprendimenti totalmente nuovi, il cervello crea nuove ramificazioni e connessioni tra i neuroni; quando invece si rafforzano apprendimenti precedenti, si ritiene che le connessioni esistenti si rafforzino per mezzo della mielinizzazione dei dendriti, e questo sembra avere effetti sulla memoria e sulla velocità con cui il cervello è in grado di gestire quel dato compito o azione. Il curricolo scolastico viene sempre presentato come un insieme di discipline diverse e separate e raramente le nuove informazioni e conoscenze vengono proposte come parti di una rete di saperi e culture precedenti. In questo modo non si favorisce la crescita di connessioni cerebrali perché le connessioni del mondo esterno vengono nascoste o frammentate. Al contrario, il modo più efficace di apprendere è quello che lega l’apprendimento a reali eventi della vita scolastica e del mondo esterno, dove nuove informazioni vanno ad aggiungersi e connettersi alle esperienze e conoscenze precedenti» (Michele Capurso, Ambienti di apprendimento per lo sviluppo umano,  qui). Come si vede, non c’è nulla di veramente nuovo per chi ha praticato la sperimentazione didattica: ma adesso abbiamo ragioni più forti per fondare le nostre buone pratiche scolastiche in direzione di una didattica trasversale e modulare.
qui). Come si vede, non c’è nulla di veramente nuovo per chi ha praticato la sperimentazione didattica: ma adesso abbiamo ragioni più forti per fondare le nostre buone pratiche scolastiche in direzione di una didattica trasversale e modulare.
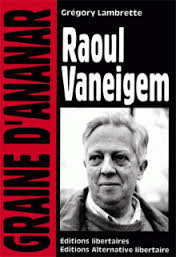 Quando, come sto facendo qui, usiamo la metafora della «testa ben fatta», non sottolineiamo a sufficienza che questa testa ben fatta è un cervello collettivo, la cui essenza è la cooperazione sia orizzontale tra soggetti docenti o discenti, sia verticale tra docenti e discenti. Non c’è forse attività umana che esprima meglio la realtà del comune che i processi di apprendimento: soprattutto nell’epoca del capitalismo cognitivo, nella quale la produzione sociale di sapere è im-mediatamente produzione di valore. Ma questa produzione biopolitica di sapere/valore è regolamentata in forma privatistica, in primo luogo dal punto di vista amministrativo: l’abolizione dell’organico funzionale (il criterio in base al quale alle scuole sarebbe stato assegnato tanto personale, quante erano le funzioni da svolgere), l’aumento dei carichi di lavoro individuali a scapito del tempo della progettazione e della condivisione, e la progressiva precarizzazione del corpo docente sono conseguenze logiche di quella privatizzazione del rapporto di lavoro che trasforma l’attività del docente in un sinallagma contrattuale, ossia in uno scambio paritario tra prestazione e salario che mette al centro la quantità di tempo lavorativo ceduto, e non il valore in sé della prestazione.
Quando, come sto facendo qui, usiamo la metafora della «testa ben fatta», non sottolineiamo a sufficienza che questa testa ben fatta è un cervello collettivo, la cui essenza è la cooperazione sia orizzontale tra soggetti docenti o discenti, sia verticale tra docenti e discenti. Non c’è forse attività umana che esprima meglio la realtà del comune che i processi di apprendimento: soprattutto nell’epoca del capitalismo cognitivo, nella quale la produzione sociale di sapere è im-mediatamente produzione di valore. Ma questa produzione biopolitica di sapere/valore è regolamentata in forma privatistica, in primo luogo dal punto di vista amministrativo: l’abolizione dell’organico funzionale (il criterio in base al quale alle scuole sarebbe stato assegnato tanto personale, quante erano le funzioni da svolgere), l’aumento dei carichi di lavoro individuali a scapito del tempo della progettazione e della condivisione, e la progressiva precarizzazione del corpo docente sono conseguenze logiche di quella privatizzazione del rapporto di lavoro che trasforma l’attività del docente in un sinallagma contrattuale, ossia in uno scambio paritario tra prestazione e salario che mette al centro la quantità di tempo lavorativo ceduto, e non il valore in sé della prestazione.
In altri termini, cospicui settori dell’istruzione “pubblica” sono oggi di fatto privatizzati. L’opposizione pubblico/privato non consente di cogliere appieno i processi di segmentazione del sistema istruzione che, frammentando e suddividendo la comunità scolastica, mirano a selezionare un’élite di cittadini in possesso di quei livelli di capacità e competenze che rendono possibili operazioni mentali complesse. Al contrario, l’opposizione di una scuola del comune alla scuola del privatus ha quindi, per noi, non una mera valenza terminologica, ma un significato politico radicale, nel quale risuona il potenziale di ricchezza umana e sociale – in una parola: la ricchezza generica, intesa come essenza costitutiva del genere umano – degli esseri umani.
Il comune, dicevo poc’anzi, è costituito dagli esseri umani, dalle relazioni che si intrecciano fra loro, dall’ambiente entro cui questi scambi avvengono. Una scuola intesa non solo come “bene comune”, ma come “bene del comune” – cioè di tutti, e perciò stesso di nessuno, non mercificabile né privatizzabile – è una scuola che mette al proprio centro quelle relazioni immateriali, ma nondimeno concretissime, che definiscono l’individuo all’interno dell’insieme, così come l’insieme a partire dalle relazioni tra individui. È qui che la riflessione si incontra con i contributi delle neuroscienze: la predisposizione all’interazione, il valore cognitivo dell’osservazione, la costruzione dello spazio esterno a partire dalla proiezione del proprio spazio interno sono processi mentali che, radicandosi nella dimensione neuronale, antecedono il soggetto, ne costituiscono le condizioni del suo manifestarsi, del suo agire, del suo inter hominem esse. Queste – chiamiamole così – “competenze” sono, in tutta evidenza, trasversali rispetto allo statuto dei saperi e delle discipline: non si tratta quindi di insegnarle attraverso nuove materie che dovrebbero soppiantare le vecchie, quanto di riformulare – o, nei casi migliori, di approfondire un processo di rinnovamento della didattica che è stato già intrapreso nelle buone pratiche scolastiche – le modalità di insegnamento di questa o quella disciplina, mettendone al centro non i contenuti, ma ciò a cui i contenuti alludono. Si insegna l’interazione attraverso una didattica orizzontale, dialogante, interattiva; si insegna ad imparare osservando, secondo quel processo di deutero-apprendimento che Bateson considerava, a giusta ragione, una risposta alla crisi ecologica della nostra epoca, in ambienti (classi, laboratori, spazi comuni) predisposti per metratura, arredo e numero degli abitanti all’osservazione reciproca tra docente e allievi. Si insegna l’interazione – e con essa si stimola lo sviluppo psico-fisico della mente – attraverso l’interazione dei docenti nei moduli scolastici, che invece di essere rimossi dalla scuola di base dovrebbero essere estesi alla scuola secondaria tutta; e attraverso le compresenze, che invece di essere considerate un costo da tagliare dovrebbero essere valutate in ragione del prezioso contributo che esse danno allo sviluppo mentale degli allievi.
Vorrei fare qui un esempio concreto, che riguarda le competenze più strettamente logiche. A lungo ho pensato che la logica, quantomeno quella di base, e cioè quella aristotelica, dovesse assumere dignità di materia a sé stante, e tutt’ora non mi spiacerebbe insegnare questa materia, come mi è capitato di fare per alcuni anni alle matricole di giurisprudenza, a Ferrara. Ma, più ancora che i contenuti della logica, credo che sia importante favorire lo sviluppo di una mente predisposta ad operare giudizi logicamente coerenti tanto nei processi quanto nella motivazione dei giudizi, mettendo in rete, attraverso una didattica interdisciplinare, quelle discipline che sono strutturalmente predisposte a sviluppare queste competenze: e parlo non solo, com’è ovvio, della matematica e della filosofia, ma anche delle lingue (col loro correlato strumento dell’analisi logica), e tra queste in primo luogo di quel latino tanto bistrattato, e che oggi non sappiamo, e spesso non vogliamo più insegnare, perché non ne capiamo il valore. Dimenticando che nella storia, recente e lontana, non c’è popolo che non abbia attinto ai classici latini per trovare esempi atti a rafforzare la volontà di ribellione contro la tirannide.
Un secondo esempio è la cosiddetta “Cittadinanza e Costituzione”, un aborto di materia nato a partire da un’idea errata e retrograda della didattica – occorre dirlo, a dispetto del fatto che tra i suoi sostenitori ci sia stato il presidente Napolitano: che la cosiddetta “educazione civica”, definizione peraltro nobilissima, dovesse essere insegnata all’interno di uno specifico curricolo, invece di scaturire dall’interazione collegiale. Chiedo, provocatoriamente: insegna ad essere un buon cittadino l’insegnante di storia che fa la storia della Costituzione, l’insegnante di lingue straniere che fornisce gli strumenti per praticare una reale interazione, pratica e osservativa, delle vite e dei costumi altrui, o l’insegnante di educazione motoria che insegna a praticare il rispetto dell’altro all’interno di regole condivise e accettate? La risposta è, com’è naturale: tutti e tre, se ciò che fanno lo fanno di concerto. Non certo il primo, se ciò che fa lo fa da solo, e magari attraverso un apprendimento mnemonico.
 Avevo citato, accanto alle neuroscienze, il contributo della teoria delle intelligenze multiple, a partire dalle ricerche di Howard Gardner. L’individuazione di almeno nove diverse intelligenze (il cui numero potrebbe estendersi se venisse confermata l’intuizione che anche alcune emozioni hanno dignità di intelligenza) – Linguistica, Logico-Matematica, Spaziale, Corporeo-Cinestesica, Musicale, Interpersonale, Intrapersonale, Naturalistica, Esistenziale – è rilevante non solo per lo specifico di ciascun ambito, ma soprattutto per la scoperta che le diverse intelligenze si sostengono l’un l’altra come un pacchetto di mischia nel rugby: la necessità di una pluralità di discipline – e qui sottolineo l’educazione musicale, particolarmente penalizzata dalla riforma Gelmini –, e della loro reciproca interazione, trova qui un ulteriore fondamento.
Avevo citato, accanto alle neuroscienze, il contributo della teoria delle intelligenze multiple, a partire dalle ricerche di Howard Gardner. L’individuazione di almeno nove diverse intelligenze (il cui numero potrebbe estendersi se venisse confermata l’intuizione che anche alcune emozioni hanno dignità di intelligenza) – Linguistica, Logico-Matematica, Spaziale, Corporeo-Cinestesica, Musicale, Interpersonale, Intrapersonale, Naturalistica, Esistenziale – è rilevante non solo per lo specifico di ciascun ambito, ma soprattutto per la scoperta che le diverse intelligenze si sostengono l’un l’altra come un pacchetto di mischia nel rugby: la necessità di una pluralità di discipline – e qui sottolineo l’educazione musicale, particolarmente penalizzata dalla riforma Gelmini –, e della loro reciproca interazione, trova qui un ulteriore fondamento.
È altresì evidente quale negativo quadro emerge da una scuola che diriga – come sta facendo quella attuale – la propria rotta in tutt’altra direzione: quale mente, quali servitù, quali deficit cognitivi, esistenziali, quali mutilazioni nella capacità di esercizio attivo della cittadinanza sono in corso d’opera.
Torniamo al titolo di questo incontro: cosa insegnare a scuola? La risposta è: la vita, in quanto vita. Una scuola in cui la vita non si annoia è, per citare un bravo collega, Valter Binaghi, una scuola che è luogo vitale «quando i ragazzi hanno la percezione non di affettarsi giorno per giorno un diploma, ma che lì dentro si forgiano un carattere, un patrimonio irrinunciabile e un destino. Se no meglio chiuderla».
Nota al testo
Il seminario in cui fu pronunciato questo intervento si è tenuto a Candriai (TN) il 17 e 18 novembre 2012. Gli atti sono stati raccolti nel volume Cosa insegnare a scuola. Qualche idea sulle discipline umanistiche, a cura di Amedeo Savoia e Claudio Giunta, Editore Provincia Autonoma di Trento IPRASE, Trento 2013, che è disponibile all’indirizzo  http://www.iprase.eu/librocosainsegnareascuola. La citazione di Valter Binaghi era tratta del suo testo Cosa insegnare a scuola, pubblicato sul suo blog il 6 novembre 2012.
http://www.iprase.eu/librocosainsegnareascuola. La citazione di Valter Binaghi era tratta del suo testo Cosa insegnare a scuola, pubblicato sul suo blog il 6 novembre 2012.




