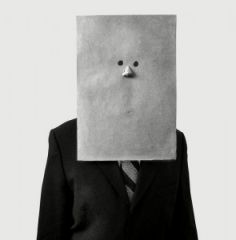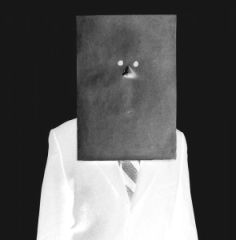di Mauro Baldrati
[Riassunto delle puntate precedenti (qui e qui). Jimi Hendrix e Dennis Hopper dopo un lungo viaggio in autostop sono arrivati nella “terra promessa”, Amsterdam, Piazza Dam , una delle capitali mondiali dell’underground. E’ il luglio 1970. Ma ciò che trovano li lascia senza parole: la piazza è deserta, occupata solo da spacciatori di eroina. Depressi e delusi, per fortuna vengono “salvati” da un pusher italiano, Gino, che li porta dove c’è “la gente”, il Vondel Park. E qui scoprono che Gino è attirato, ma anche spaventato, dal “rito”. Di che si tratta? Gino non riesce a spiegarlo. Dice che è indispensabile vedere, sentire, perché il rito è liberazione, è luce e pace. Così Jimi e Dennis lo accompagnano a una serata di iniziazione, in un barcone ormeggiato su un canale, dove incontrano il “Maestro irato”.]
Ah-oh-ah!
Andò avanti per almeno dieci minuti. Un tempo enorme, per quella intensità. Infine giacque sulla sedia, immobile, come una statua. Il ragazzo tornò sul palco.
“Il Maestro è irato! E’ irato di fronte alla perdita dell’innocenza, che tutti subiamo in questo mondo fasullo, stregato dal velo di Maya! Il Maestro è irato per lo spreco dell’esistenza, che si trascina nella sofferenza, nella paura, nella frustrazione!” Una pausa, mentre i ragazzi col turbante salmodiavano il mantra a bassa voce. “Dobbiamo ritrovare la nostra innocenza! Solo così possiamo aspirare alla pace. La vera pace, quella dell’anima!”
Giunse le mani, si inchinò. Altri due ragazzi col turbante salirono e presero posto accanto alla sedia.
“Oggi è un giorno importante!” disse il ragazzo. “Oggi un nuovo fratello è pronto. Oggi un nuovo fratello sta per riaprire la fontana dell’innocenza. Oggi è un giorno felice! E anche il Maestro è felice ora!”
Jimi sbirciò il maestro. Non sembrava più irato. Era immobile con gli occhi chiusi.
“Tutti siamo felici! Che entri fratello Jorge!”
Dal fondo della sala spuntò un ragazzo. Era vestito con lo stesso completo bianco, ma senza turbante. La testa era rapata, con un piccolo ciuffo di capelli neri al centro. Avanzava molto lentamente, con difficoltà, come se una forza contraria lo ostacolasse. Arrivò al palco, salì piano i tre gradini, uno alla volta. Restò in piedi di fronte alla sedia, con la testa bassa, le mani giunte. Il mantra aumentò di intensità. Il ragazzo col turbante si piazzò accanto a lui. Lo aiutò a sedersi. Come se da solo non fosse in grado di eseguire quei movimenti.
Il rito
Era al centro del palco ora. Solo. Il ragazzo col turbante si rivolse al pubblico. Spalancò le braccia. Parlò forte, sovrastando il mantra.
“Noi siamo con te, fratello Jorge! Ti siamo vicini, in questo giorno importante. Il giorno della tua iniziazione. Il giorno in cui la tua vita avrà una svolta. Come la nostra l’ha avuta. Sosteniamo fratello Jorge!” gridò. “Seguiamolo nel suo cammino!”
Fratello Jorge era seduto immobile, con gli occhi lievemente sbarrati. I ragazzi che gli erano al fianco gli presero le mani. Uno lo accarezzò sulla testa.
Ah-oh-ah. Il mantra era ipnotico.
D’un tratto alle spalle del ragazzo comparve un uomo. Non un ragazzo. Un uomo. Coi capelli in testa. Capelli neri. E gli occhiali. Indossava un camice bianco. Aveva una borsa a tracolla. L’aprì. Prese qualcosa. Salì su uno sgabello, o una scaletta, alzandosi di almeno mezzo metro.
Aveva un oggetto in mano. Jimi strinse gli occhi, perché non era sicuro. Ma era proprio una siringa. Grande, con un ago ricurvo.
L’uomo avvicinò l’ago alla sommità della testa rapata del ragazzo. Jimi non vedeva, perché il suo angolo visuale era ribassato, ma era evidente che l’uomo stava facendo delle piccole iniezioni, muovendo la siringa in circolo.
Poi la ripose nella borsa, si girò e fece un cenno a qualcuno.
Subito due ragazzi scostarono una tenda, scoprendo uno strano trespolo, formato da tubi di metallo che formavano due cavalletti uniti da una sbarra orizzontale. Issarono la struttura sul palco, aiutati dai due ragazzi col turbante, che lo piazzarono intorno al ragazzo seduto. Un cavalletto a sinistra e uno a destra. La sbarra orizzontale si trovava circa a venti centimetri sopra la testa del ragazzo.
Jimi seguiva i movimenti con una strana tensione, che era la stessa di tutti i presenti. Le teste del pubblico erano immobili, i colli rigidi. Anche Gino era come pietrificato, ma il volto appariva ispirato, con le bocca socchiusa.
 La sbarra orizzontale aveva una protuberanza, posta esattamente al centro della testa del ragazzo, che sembrava una scatola, o forse un attacco, un supporto. Ed era esattamente questo. Un supporto, nel quale uno dei ragazzi stava sistemando un attrezzo che subito Jimi non riuscì a riconoscere. O forse non volle riconoscere. Era un trapano. C’era la maniglia, il mandrino, il cavo elettrico. E la punta. Che non era una punta. Jimi aguzzava gli occhi, ma forse i residui dello space cake di quella mattina, forse i joint che aveva fumato qua e là, gli impedivano una gestione organizzata delle immagini e dei concetti. Non era una punta. Era un fresa. Una fresa a tazza. La conosceva, perché prima di partire per Amsterdam aveva lavorato per due settimane come apprendista nell’officina metalmeccanica dove suo padre era caposquadra. Una fresa a tazza era un cilindro cavo, coi bordi seghettati, montato su uno stelo d’acciaio che si infilava nel mandrino del trapano. Serviva per creare dei buchi perfettamente rotondi, larghi, senza usare una punta piena, che sarebbe penetrata a fatica nel materiale, creando un buco convesso.
La sbarra orizzontale aveva una protuberanza, posta esattamente al centro della testa del ragazzo, che sembrava una scatola, o forse un attacco, un supporto. Ed era esattamente questo. Un supporto, nel quale uno dei ragazzi stava sistemando un attrezzo che subito Jimi non riuscì a riconoscere. O forse non volle riconoscere. Era un trapano. C’era la maniglia, il mandrino, il cavo elettrico. E la punta. Che non era una punta. Jimi aguzzava gli occhi, ma forse i residui dello space cake di quella mattina, forse i joint che aveva fumato qua e là, gli impedivano una gestione organizzata delle immagini e dei concetti. Non era una punta. Era un fresa. Una fresa a tazza. La conosceva, perché prima di partire per Amsterdam aveva lavorato per due settimane come apprendista nell’officina metalmeccanica dove suo padre era caposquadra. Una fresa a tazza era un cilindro cavo, coi bordi seghettati, montato su uno stelo d’acciaio che si infilava nel mandrino del trapano. Serviva per creare dei buchi perfettamente rotondi, larghi, senza usare una punta piena, che sarebbe penetrata a fatica nel materiale, creando un buco convesso.
Eppure non riusciva a collegare quegli oggetti con la situazione. Con quel mantra ipnotico che aumentava di continuo di intensità. Coi gesti di quei ragazzi che, ora lo capiva, si stavano tutti togliendo il turbante, che davvero sembrava una grande pentola bianca.
Non riusciva ancora a collegare quel trapano con la fresa montata sopra la testa del ragazzo. E i gesti sicuri dell’uomo che lo sistemava, con spostamenti millimetrici. Non riusciva a collegare quel trapano con le teste dei ragazzi in bianco, che ora avevano uno strano oggetto sulla sommità. Né con gli asciugamani bianchi che reggevano i due ragazzi sul palco. Né col ronzio del trapano che partiva. Né con la testa del ragazzo, che, lo vedeva solo ora, era stata immobilizzata da una fascia di cuoio fissata a un poggiatesta. Né col trapano stesso, che l’uomo stava facendo calare, lentamente, con precisione, sulla sommità della testa. E la sfiorò. E iniziò a bucare. A scavare.
Jimi si sentiva lo stomaco bloccato da una morsa, mentre osservava il volto immobile del ragazzo, con gli occhi dilatati oltre ogni immaginazione, i pugni chiusi. Il mantra stava salendo verso frequenze insostenibili, intanto che il trapano lavorava, scavava, con un ronzio che sembrava trapanare anche il cervello di Jimi.
Poi, l’uomo fermò il lavoro. Alzò il trapano e fece un cenno ai due ragazzi, che spostarono il trespolo. Dalla borsa prese un altro attrezzo. Un bisturi, col quale iniziò a lavorare nella zona dell’intervento, avvicinando la faccia fino a mettere quasi a contatto il suo naso col cranio insanguinato del ragazzo. Ripose anche il bisturi. Si asciugò le mani con una salvietta. E si fermò, rivolto verso il pubblico. In attesa, sembrava.
Sì, in attesa. In attesa di un gesto dei ragazzi col turbante. Che prima avevano il turbante, una pentola che copriva un oggetto posto sul cocuzzolo delle loro teste. Un oggetto che ora, solo ora Jimi riconobbe. Era un tappo. Di plastica, probabilmente. Un tappo sulla cima della testa. Un tappo che ora i ragazzi, con gesti lenti, sincronizzati, si stavano togliendo. E mentre tutte le mani, all’unisono, lo sfilavano dalle teste, e il resto del pubblico esclamava un “ohhh!” estatico, e il Maestro si alzava in piedi e gettava in alto le braccia, l’uomo prese tra le dita, con cura, con attenzione, il piccolo ciuffo di capelli neri, stropicciato, scarruffato, insanguinato, e tirò.
Notte. Di ritorno al Vondel Park
Jimi, Dennis e Gino erano seduti sul prato, coi gomiti sulle ginocchia, la testa bassa. Ognuno era immerso nei propri pensieri, oppure in assenza di pensieri. Questo era lo stato di Jimi. La testa vuota. Oppure troppo piena. Sentiva anche lo stomaco chiuso. Voleva mangiare un’altra fetta di space cake, per la notte, ma la sola idea gli aveva provocato la nausea. Provava una sorta di orrore al pensiero di guardare dentro ai buchi sul cranio dei ragazzi. Eppure non riusciva ad evitare di pensarci. E più ci pensava, più rabbrividiva.
“E’ un rito americano” disse Gino, a un certo punto. Non per rompere il silenzio. Non c’era mai silenzio al Vondel. Le percussioni erano attive, anche se erano le quattro del mattino. “E’ nato nel deserto dell’Arizona tre anni fa, e ora si sta diffondendo nel mondo.”
Dennis sospirò. O forse tossì. O addirittura ringhiò.
“Gino, non farlo. Non fare una cosa simile. Non farti un buco in testa. Ti supplico.”
Nessuna risposta. Un sospiro, forse.
“Per favore. Pensaci. Come vivresti con un buco in testa?”
Gino si rianimò. Rovesciò indietro la testa, annusò l’aria.
“Ci ho pensato, e come. Non faccio che pensarci. Lo so che dall’esterno tutto si riduce a ‘un buco in testa’. Ma non è così. In quel punto c’è la fontana dell’innocenza, capisci? Quando il bambino nasce la fontana è aperta. Poi si chiude, col tempo, e l’innocenza muore, divorata dai problemi, dalla paura, dalla rabbia, dal Potere. Dalla famiglia. Dalla scuola. Da tutto. Noi vogliamo riaprirla. Vogliamo far di nuovo sgorgare la bellezza dell’innocenza.”
Dennis crollò di nuovo coi gomiti sulle ginocchia. Gino sembrava di granito. C’era come un muro tra loro. Almeno così sentiva Dennis Hopper. Jimi Hendrix, invece, non era così sicuro. Jimi si era dato la regola di rispettare qualunque idea, qualunque azione, purché non fosse conforme al Potere. Purché non fosse funzionale al Potere. E sull’idea di Gino non aveva certezze.
Dennis tornò alla carica.
“Ma cosa sarebbe di te? Hai visto come si muovono quelli? Non potrai mai più tuffarti in mare, dovrai evitare i movimenti bruschi. E poi quanto durerà? Ma che razza di intervento è?”
“C’è una risposta a tutto, Dennis. Ma bisogna essere disposti ad ascoltare. A capire. Con la fontana riaperta si ritrova la pace. Io li ho visti, li ho conosciuti bene. Sono persone in pace. Non hanno bisogno di tuffarsi in mare. La vita diventa semplice. Non serve più agitarsi, correre, farsi del male. E l’intervento è sicuro. Lo esegue un medico chirurgo. La membrana di protezione del cervello non viene toccata. Bisogna solo sottoporsi a visite di controllo periodiche e sterilizzare sempre il tappo.”
“Il tappo! Cazzo!” sbottò Dennis.
Poi, tornò il silenzio. Il silenzio delle percussioni, delle risate di chi non dormiva, di qualcuno che russava, che parlava sottovoce, che forse faceva l’amore. Che sognava.
“E quel santone! Mica ce l’ha lui il tappo sulla testa!”
Gino ridacchiò. Le intemperanze di Dennis Hopper erano buffe.
“Non ne ha bisogno. Lui la pace l’ha trovata da molto tempo. E anche l’innocenza. E poi non è un ‘santone’. E’ la guida. E’ il portatore di luce.”
“Ma quando faresti questa pazzia?” caricò Dennis. “Quanto tempo ti resta?”
“Eh. E’ questo il problema.” Gino si interruppe. Sospirò rumorosamente. “Devo solo raccogliere i soldi.”
“I soldi? Perché devi pagare, vero? E quanto?”
“Mille goulden per il corso di preparazione e tremila per l’iniziazione. Sono molti soldi. Dovrò vendere il fumo ad altri livelli. Dovrò passare dalle stecche alle decine di grammi, forse agli etti.”
Dennis imprecò. Disse quello che doveva dire. Quello che era costretto a dire. Il santone che faceva i soldi rompendo la testa ai ragazzi. Rovinandoli per sempre.
L’Oracolo
Jimi si alzò in piedi. Non era quello di cui aveva bisogno Gino. Erano parole inutili, e dannose, quelle di Dennis. Gino aveva un’esigenza. Gino doveva decidere della sua vita. Andava ascoltato. Andava capito.
 Andò vero il sadhu, che sedeva nella stessa posizione di sempre. Era di nuovo a torso nudo, nonostante la notte fresca e umida. Jimi aveva il giaccone militare sopra il maglione, e i capelli fradici.
Andò vero il sadhu, che sedeva nella stessa posizione di sempre. Era di nuovo a torso nudo, nonostante la notte fresca e umida. Jimi aveva il giaccone militare sopra il maglione, e i capelli fradici.
Si sedette di fronte a lui. Lo esaminò con cura. Era così immobile che sembrava non respirasse. D’un tratto, senza pensarci, allungò una mano e lo toccò. Voleva sincerarsi che fosse vero. Che fosse vivo. Sentì una pelle fredda. Ma faceva freddo. Comunque non sembrava morto. E soprattutto esisteva davvero. Il sadhu non si mosse. Non aprì gli occhi. Doveva essere immerso in una meditazione eccezionale. Doveva trovarsi nel nirvana.
“Amico. Fratello” disse Jimi, fissando quelle palpebre abbassate, quella faccia seria, immobile. “Credi che il mio amico lo farà? Credi che si farà bucare la testa? Che si farà mettere un tappo?”
Non stava parlando al sadhu, che neanche lo sentiva. Parlava alla notte, e a se stesso. Forse parlava all’innocenza, la sua, che aveva perduto. Come tutti.
Le percussioni viaggiavano nella notte senza sonno, i tabla crepitavano, si era aggiunto un flauto. Anche un chitarra. Forse un banjo.
“Fratello. Lo farà Gino? Sarà questa la sua decisione?”
Si coprì la faccia con le mani. Si sentiva esausto. Voleva dormire tutto il giorno, prima di rimettersi in movimento. Voleva esplorare tutta la città. Entrare in quelle case piene di musica, e di ragazze. Quelle case aperte, ospitali. Voleva essere scatenato. Voleva scendere all’inferno.
Non si accorse del movimento del sadhu. Oppure se ne accorse quando aprì gli occhi, e respirò di colpo, come se emergesse da una lunga apnea.
Lo stava fissando ora. Gli occhi, neri, perfettamente svegli, erano fissi nei suoi. Sembravano anche divertiti. Si stava sgranchendo il collo, le spalle, e la faccia, con smorfie pazzesche che probabilmente erano esercizi di yoga.
Quando il sadhu parlò stava iniziando ad albeggiare. Una luce grigia, leggera, si stava spandendo nel cielo nero. Parlò con una voce piena, per nulla roca, una voce tranquilla, che a Jimi Hendrix parve persino allegra. Una voce leggera. E soprattutto parlò in un italiano perfetto, senza ombra di accento, prima di richiudere gli occhi:
“Secondo me, no.”
[Fine]