di Mauro Baldrati
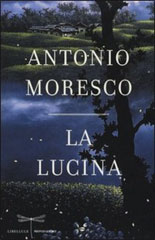 Moresco ha definito La lucina “un libricino”. Forse lo è, se paragonato ai precedenti romanzi: Gli esordi (673 pp), Canti del Caos (1092 pp), Lettere a nessuno (728 pp). Eppure, con le sue 167 pagine (foliazione sulla quale alcuni autori nostrani ci farebbero su una trilogia, giocando con le pagine di cartone, i caratteri e i margini), questo romanzo breve è tutt’altro che “ino”. Non che sia di per sé un difetto, o una minorazione. Moresco ha il gusto del piccolo, del minuscolo, lui che esplode con romanzi espansi, a tratti violenti, deflagranti. Il bambino ha le “manine”, con le quali lava i piatti, mette in ordine, fa le pulizie nella “casina” dove vive. Quella casina dove, appunto, ogni sera si accende la “lucina” che il protagonista, seduto davanti alla sua, di casina, su una sedia con le gambe di metallo che affondano nella terra, osserva con curiosità, con inquietudine. Chi abiterà in quella parte di bosco, dove la vita umana sembra bandita?
Moresco ha definito La lucina “un libricino”. Forse lo è, se paragonato ai precedenti romanzi: Gli esordi (673 pp), Canti del Caos (1092 pp), Lettere a nessuno (728 pp). Eppure, con le sue 167 pagine (foliazione sulla quale alcuni autori nostrani ci farebbero su una trilogia, giocando con le pagine di cartone, i caratteri e i margini), questo romanzo breve è tutt’altro che “ino”. Non che sia di per sé un difetto, o una minorazione. Moresco ha il gusto del piccolo, del minuscolo, lui che esplode con romanzi espansi, a tratti violenti, deflagranti. Il bambino ha le “manine”, con le quali lava i piatti, mette in ordine, fa le pulizie nella “casina” dove vive. Quella casina dove, appunto, ogni sera si accende la “lucina” che il protagonista, seduto davanti alla sua, di casina, su una sedia con le gambe di metallo che affondano nella terra, osserva con curiosità, con inquietudine. Chi abiterà in quella parte di bosco, dove la vita umana sembra bandita?
Intanto l’uomo conduce la sua esistenza, in ritiro assoluto dal mondo, una sorta di eremita che passeggia per i boschi. Osserva la complessa, intensa, “pazza” vita animale e vegetale che fiorisce intorno a lui. Una vita cruenta, con aspetti di violenza che hanno fatto parlare alcuni commentatori di natura leopardiana. Ma lo stesso Moresco ha chiarito che la sua non è la concezione di Leopardi: a prevalere non è l’aspetto crudele, predatorio, quanto il mistero, insondabile, delle varie forme di vita e del loro comportamento. Sembra di sentire la canzone di Vasco: “Voglio trovare un senso a tante cose/anche se tante cose un senso non ce l’ha”. Che senso ha la vita della “lucina”, la lucciola, che per poche notti all’anno non fa che volare con l’intestino che pulsa di luce, con l’unico scopo di accoppiarsi per poi morire? E le rondini, creature ipercinetiche che sfrecciano e gridano tutto il giorno sfiorandosi l’una con l’altra, senza mai confliggere? Possibile che non si fermino mai, un solo minuto? Perché? Si chiede. Perché questa luce, questo spazio, perché questo tempo? Perché questa vita? Sono le domande ancestrali, eterne, che si pone l’uomo di fronte al mondo e all’inconoscibile.
Ma la bravura di Moresco, la sua genialità, sta nell’economia perfetta della scrittura, né minimalista né ridondante, senza il minimo spreco di descrizioni, o di riflessioni filosofiche. Usa una tecnica collaudata ma delicata, quella di fondere la scrittura col paesaggio, quasi non esistesse il concetto di narrazione, ma di scrittura che diventa parte della realtà stessa, una sua emanazione, una sua variante. Scrittura materialistica, verrebbe da definirla, di materia solida, vegetale, organica, minerale. Sembra un paradosso, eppure alcuni scrittori riescono in questa impresa con precisione millimetrica. Un altro autore che sa gestire questa tecnica è, per esempio, il ligure Marino Magliani.
Intanto noi sappiamo. Noi lettori. Sappiamo come procede, prima di voltare pagina. Sappiamo che il narratore andrà a curiosare, si avventurerà per un sentiero impervio con la sua macchina scassata, senza tempo né marca, per scoprire chi accende la lucina.
Non crediamo di sconfinare nello spoiler se riveliamo la sua identità. Durante le presentazioni del libro Moresco si sofferma più volte sul bambino. E già a metà del racconto sappiamo che si tratta di un bambino. Morto. Un bambino morto risorto. Un sopramorto, lo definirebbe Chiara Palazzolo, anche se non divora i suoi simili. E’ un bambino che vive completamente solo nella casina. Ha la testa rapata, lava i piatti in piedi su una cassetta, per arrivare al secchiaio, e fa i compiti. Perché va a scuola, nel piccolo, sperduto paese, dove vanno anche i bambini vivi, ma in una classe a parte, notturna, riservata ai bambini morti, con un bidello morto. Tira fuori il quaderno da una “cartella”, di quelle che andavano una volta, negli anni Sessanta. Una matita, una gomma, e si applica con impegno, con lentezza, con la testa china sul foglio.
Il narratore è stupefatto. E attirato. Affascinato. Cerca di entrare in contatto, quando il bambino ha un po’ di tempo libero. Riesce a fare amicizia, a farsi raccontare la sua storia di emarginato, di bambino scarsamente abile, tonto quasi, eppure così tenace, così assolutamente ostinato, fino alla rabbia.
Noi lettori sappiamo. Perché Moresco mette i codici, i segni. Sappiamo, perché l’ha rivelato lui stesso, che è tutto vero. Ha veramente trascorso un periodo in totale isolamento in una casa tra i boschi, in montagna. Ha veramente incontrato quella sorta di hellhound con le gambe spezzate, che l’ha seguito fino a casa. Sappiamo che c’è un rapporto stretto tra l’uomo e il bambino morto. Che il confine tra la vita e la morte è più stretto di quanto non sembri. Che prima o poi troverà il punto di unione, mentre il racconto marcia spedito verso il suo finale.
Un finale che ha stupito, e spiazzato, più di un lettore. Forse perché è duro da accettare. E’ complicato. E’ ancestrale. Perché ci obbliga a prendere in considerazione che quell’esplosione di vita furiosa, sotterranea, alata, vegetale, che circonda e avvolge i due personaggi, e non cessa di stupire, e forse di spaventare l’uomo, mentre il bambino sembra farne parte, come le rondini e le lucciole, ingloba anche la morte. Proprio come la scrittura si fonde con le pietre, i rampicanti, gli insetti, le volpi, la morte si intreccia con la vita.
La morte della storia, attraverso l’uomo, il narratore.
Ammesso che un tempo, nel suo tempo perduto di bambino, sia mai stato davvero vivo.



