di Lorenza Ghinelli
 O meglio, credo che il problema degli allevamenti intensivi e della pesca industriale necessiti da diverso tempo di essere posto su un piano differente: un piano razionalista.
O meglio, credo che il problema degli allevamenti intensivi e della pesca industriale necessiti da diverso tempo di essere posto su un piano differente: un piano razionalista.
Non è possibile (purtroppo) chiedere alle persone di amare necessariamente gli animali, e nemmeno di ritenerli degni di diritti. Non è possibile, e forse non è nemmeno giusto, dire alle persone cosa possono o non possono mangiare. Per questo, prima di partire dalle differenze tra chi ha scelto di non mangiare carne prodotta in allevamenti intensivi e chi invece la mangia, penso sia più opportuno partire da quello che ci accomuna.
In questo non aiutano nemmeno le statistiche, perché le statistiche hanno a che fare coi numeri, e quando si parla di numeri diventa difficile immaginare che a quelle cifre corrispondano persone e animali, insomma, esseri viventi. Il successo degli allevamenti intensivi e della pesca industriale nasce soprattutto da questo: dalla distanza siderale tra noi e tutti quei numeri, tra quello che accade e quello che ci è dato (e non ci è dato) vedere, tra quello che amiamo immaginare e quello che invece sistematicamente si verifica.
Per tentare di cambiare le cose, temo sia necessario dare per assodati l’egoismo e l’indifferenza che ci caratterizzano: siamo l’unica specie a non avere a cuore il suo mantenimento e la preservazione del suo habitat.
Benissimo allora, diamo per scontato che non ci freghi nulla, ma proprio nulla, del mondo che lasceremo ai posteri. Diamo per scontato che l’unica cosa a interessarci sia la nostra soddisfazione edonista, sempre e comunque, e che il nostro motto sia arraffare a più non posso quel che c’è prima degli altri, e diamo anche per scontato che l’unica cosa che ci va in questo momento sia un piatto qualunque, a base di carne comprata in un qualunque supermercato (o macellaio) della nostra zona. Benissimo, sono certa che se avessimo la matematica certezza che quella carne è malata, dopata, gonfiata, e con molta probabilità veicola agenti patogeni farmaco-resistenti, preferiremmo orientare il nostro appetito su altro.
La settimana scorsa sono andata, come di consueto, al supermercato. Nella corsia della carne il mio sguardo è stato calamitato da barattoli colorati e divertenti con disegnati sopra maialini e tacchini stilizzati. Barattoli buffi che al loro interno custodiscono crocchette di carne, barattoli fatti apposta per attrarre le mani dei bambini e cacciare in cantina ogni sacrosanta domanda del tipo: “cosa sto mangiando?”. Nello stesso supermercato si vendono uova che riportano troppo spesso la scritta “natura”, supportata da immagini di galline in salute, allevate a terra, sotto un cielo da favola. Girando quelle confezioni, scritto davvero in piccolo, possiamo trovare un indizio di verità: “in gabbia”. Ma pochi girano la confezione per leggere, e pochissimi scelgono di riflettere sul significato delle parole “in gabbia”. Molti potranno pensare che in fondo, nel tenere una gallina in gabbia non ci sia nulla di male, il risultato alla fine è lo stesso. Ma cos’è davvero un allevamento intensivo? Se fosse davvero innocuo, perché è così difficile (se non impossibile) visitarlo? Cosa nascondono? Cosa mangiamo davvero? Le pubblicità ci sedano, evocandoci un mondo che non esiste più. Nel mondo odierno, galline, maiali, conigli, tacchini, non solo non vengono allevati rispettando i loro bioritmi (sarebbe impossibile accontentare le richieste ingorde dei consumatori, tutto dovrebbe procedere più lentamente, naturalmente), ma addirittura i loro bioritmi vengono totalmente stravolti, questi animali vengono modificati geneticamente e alterati farmacologicamente. Capisco che sia più semplice farsi imbambolare dalle pubblicità che ci mostrano animali felici, senzienti, che starnazzano e grufolano in fattorie da cartolina, curati da contadini felici, famiglie numerose e sorridenti, in cui c’è cibo per tutti e le risorse sono infinite, capisco che l’idea di mettere nel nostro corpo quella presunta felicità proteica ci faccia sentire bene. Ma credo che volere sapere davvero aiuti, perché essere privati della possibilità di scegliere ci rende meno umani, ma essere i primi a privarci di questa possibilità ci rende ottusi.
Facciamo un passo indietro. Molti di noi ricorderanno la psicosi collettiva scatenata dall’H5N5, dalla SARS, e recentemente dall’H1N1. Ne parlarono quotidiani e telegiornali, orientando persino i nostri consumi. Quando smisero di parlarne, cominciammo a dimenticare. Pochissimi hanno voluto capire, approfondire, porre e porsi domande. È più facile catalogare certi flagelli come eventi rari, come sfortune, piuttosto che associarli ai nostri comportamenti abituali, piuttosto che sentirci direttamente chiamati in causa. Ed è per questo che rimando a un libro che trovo scorrevole, puntuale e necessario: Se niente importa, di Jonathan Safran Foer, il quale scrive: “Oggi, il collegamento tra allevamento intensivo e pandemie non potrebbe essere più limpido.
Il progenitore del recente scoppio di influenza suina H1N1 ha avuto origine in una porcilaia industriale”.
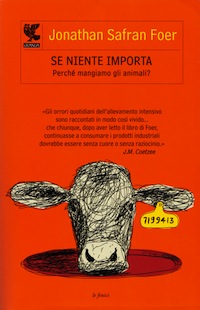 Per rispondere alla richiesta del mercato (ah, a scanso di equivoci il mercato siamo noi, siamo noi che orientiamo le scelte dell’industria) gli allevatori si sono ingegnati per produrre carne, sempre più carne per sfamare il pianeta (parti del pianeta). Per farlo hanno messo mano in modo invasivo e massivo alla farmacologia e alla genetica. I polli che mangiamo, se soltanto potessimo vederli vivi, ci farebbero ribrezzo. Sono polli deformi, mutilati, affetti da infezioni batteriche e con un sistema immunitario da buttare. Possono persino essere contaminati da Escherichia coli e Campylobacter. Noi, questi polli malati, insaporiti artificialmente e drogati, ce li mangiamo. L’industria zootecnica provvede ad alimentarli con mangimi che contengono antibiotici. Antibiotici dati non per guarire, ma per prevenire. Antibiotici che anche noi ogni giorno ingeriamo in piccole quantità mangiando gli animali e che a lungo andare possono rendere i batteri resistenti a quegli stessi farmaci. E torniamo al discorso delle pandemie. Se la pandemia vi sembra troppo lontana pensiamo a qualcosa di più vicino, alle malattie cardio-vascolari per esempio.
Per rispondere alla richiesta del mercato (ah, a scanso di equivoci il mercato siamo noi, siamo noi che orientiamo le scelte dell’industria) gli allevatori si sono ingegnati per produrre carne, sempre più carne per sfamare il pianeta (parti del pianeta). Per farlo hanno messo mano in modo invasivo e massivo alla farmacologia e alla genetica. I polli che mangiamo, se soltanto potessimo vederli vivi, ci farebbero ribrezzo. Sono polli deformi, mutilati, affetti da infezioni batteriche e con un sistema immunitario da buttare. Possono persino essere contaminati da Escherichia coli e Campylobacter. Noi, questi polli malati, insaporiti artificialmente e drogati, ce li mangiamo. L’industria zootecnica provvede ad alimentarli con mangimi che contengono antibiotici. Antibiotici dati non per guarire, ma per prevenire. Antibiotici che anche noi ogni giorno ingeriamo in piccole quantità mangiando gli animali e che a lungo andare possono rendere i batteri resistenti a quegli stessi farmaci. E torniamo al discorso delle pandemie. Se la pandemia vi sembra troppo lontana pensiamo a qualcosa di più vicino, alle malattie cardio-vascolari per esempio.
Se le cose stanno così perché non è facile per noi consumatori sapere cosa effettivamente mangiamo? Perché l’industria alimentare è legata a doppio nodo a quella farmaceutica, il cui potere è immenso. E se quello che a volte produce non è propriamente salutare per il consumatore, basta dare una ritoccatina alle normative.
Altro tema di interesse comune è l’inquinamento ambientale. È giusto sapere che gli allevamenti intensivi inquinano più di tutti i mezzi di trasporto messi assieme. Una persona potrebbe chiedersi: perché? In fondo gli animali producono merda. È vero, ma ne producono così tanta che anche se fosse sana la terra non sarebbe in grado di digerirla. Ma sana, oltretutto, non è: contiene ammoniaca, metano, cianuro, metalli pesanti, nitrati, monossido di carbonio e una quantità inquietante di microrganismi patogeni che possono ammalare seriamente gli esseri umani. I nostri escrementi passano da impianti di purificazione, quelli animali no. Contaminano il pianeta, lo infettano, ci ammalano. Il nostro pianeta blu, rapidamente, sta diventando sempre meno blu. I mari non sono esenti da queste contaminazioni, farsi il bagno d’estate comporta sempre rischi maggiori, e molti di noi lo hanno già esperito in prima persona. Ma il problema non è solo questo: noi stiamo rapinando il pianeta.
A tal proposito, il 26 aprile 2012, lessi un articolo splendido sull’Internazionale, uscito precedentemente per Le Monde, s’intitola Il saccheggio degli oceani e racconta in modo esemplare come i pescherecci europei, asiatici e sudamericani si spingano in acque internazionali eludendo ogni controllo e rapinando il mare di ogni sua risorsa. Un esempio è rappresentato dalla razzia dei sugarelli, pesci piccoli e proteici che rappresentavano uno dei principali alimenti africani. Oggi, i sugarelli, vengono trasformati prevalentemente in mangime per l’acquacoltura e per l’allevamento di maiali, o vengono dati in pasto ai pesci d’allevamento. I sugarelli costituiscono (costituivano?) un elemento portante nel delicato equilibrio del nostro ecosistema, ma negli ultimi vent’anni il loro numero si è ridotto da trenta milioni di tonnellate a meno di tre. Saccheggiato il saccheggiabile, i pescherecci, si sono diretti ai confini dell’Antartide, a contendersi quello che è rimasto.
Perché questo accade? Per l’indifferenza dei consumatori. Poi, certo, per motivi geopolitici e una pessima gestione delle risorse. Ma soprattutto per l’indifferenza dei consumatori. Ad oggi, solo sei nazioni su quattordici coinvolte hanno ratificato l’accordo che prevede una restrizione della quantità di pesce pescabile. Ma il problema, come dicevo, non è solo la quantità, ma anche la modalità.
Quest’estate ho passato un po’ di tempo a Favignana, ed è lì che ho potuto visitare a fondo l’ex stabilimento Florio in cui si lavorava il tonno e lo si inscatolava. Soprattutto, è da lì che partivano le muciare dei tonnaroti in tempo di mattanza. Tonni che pesavano fino a cinquecento chili transitavano tutte le estati al largo di Favignana, molti restavano impigliati nell’intricato sistema di reti preparato per loro e venivano pescati. La mattanza era cruenta, certo, ma etica. Era il vero sostentamento dell’isola e non rapinava il mare. L’arte della mattanza ha attraversato secoli e culture. I tonnaroti hanno sempre rispettato e amato il mare, e pure i tonni. Dal 1982 lo stabilimento è chiuso. Troppi pochi tonni. Su ottomila dipendenti dello stabilimento seimila furono costretti a emigrare ingrassando le file di aziende come la Fiat. Ma dove sono finiti i tonni? Chiedetelo alle tonnare volanti, agli europei e ai giapponesi, che li intercettano prima che possano avvicinarsi all’isola con tecniche militari ogni giorno dell’anno, impedendo loro di procreare e di perpetuare la specie, e mettendo in ginocchio un’economia locale sana. Ma non è solo questo il punto, il punto è che il pesce non viene più pescato dai pescatori, oggi provvedono le macchine, macchine giganti come due campi da calcio che risucchiano i pesci e a bordo li lavorano, ributtando a mare il pesce “sbagliato”, ossia le prede accessorie (spesso a rischio di estinzione), per cui non hanno la licenza. Oppure, se ad esempio i tubi insieme ai tonni risucchiano i delfini, nella scatoletta di tonno troverete anche loro.
Ovviamente esistono altri metodi letali di pesca, come quella a strascico che in assoluto produce più prede accessorie. Safran Foer ricorda che “l gamberetti sono solo il due per cento in peso del mercato ittico globale, ma la pesca a strascico dei gamberetti produce il trentatré per cento delle prede accessorie globali”. Centoquarantacinque sono le specie regolarmente uccise, tra queste figurano i delfini, gli squali, le mante, le tartarughe, i pesci volanti, i pescispada e cavallucci marini.
Nell’articolo dell’Internazionale troverete le specie che si possono mangiare perché non a rischio di estinzione e perché pescate con tecniche ecosostenibili, ma troverete anche quelle da evitare, come il tonno rosso. E se rinunciare al tonno sembrasse a qualcuno impossibile (ma vi assicuro che non lo è), almeno si può sapere quale comprare:
qui troverete le principali aziende che vendono il tonno nei nostri supermercati, e le loro politiche: tonnointrappola
L’importante, come sempre, è potere scegliere e avere gli strumenti per farlo.
Credo sia fondamentale ricordarci il nostro potere di consumatori. Noi, proprio come i regimi che tolgono voce a chi non ce l’ha, o a chi ce l’ha troppo debole, o a chi parla una lingua differente, la stiamo togliendo al pianeta.
Questo sistema produttivo è rappresentativo di tutti i sistemi produttivi che caratterizzano il nostro declino. Siamo specisti, e manchiamo totalmente di lungimiranza. Al supermercato diamo la caccia al prezzo più basso senza pensare se dietro a quel prezzo si possa nascondere tutto lo sfacelo del mondo. Abbiamo l’illusione di risparmiare, ma quale risparmio ci può essere nel dissipare ogni risorsa vitale sul nostro pianeta? Cosa mangeremo un domani? Cosa potremo mai fare crescere su una terra oltraggiata, abusata e resa sterile e tossica da scelte sbagliate? Come consumatori, come popolo, abbiamo un potere che sistematicamente scordiamo. Deleghiamo ad altri scelte che ci riguardano in prima persona. Abbiamo bisogno di imparare a gestire uno sguardo più ampio su tematiche che non possono attendere.
Ho iniziato quest’intervento cercando di essere razionalista, ma giunta qui mi sento di dire che anche l’empatia è importante.
Gli studi sull’intelligenza animale vengono messi a margine del mondo scientifico, non perchè non interessanti o non degni di nota, anzi. È sorprendente l’intelligenza dei suini, supera persino quella dei cani. Gli animali soffrono, e se credo sia possibile mangiarli per fame, non è giustificabile in nessun modo generare inutile sofferenza durante il corso della loro vita. Mi sento onnivora, certo, ma non sadica. I potenti della terra contro cui puntiamo il dito non uccidono “personalmente” le loro vittime, ma chiedono ad altri di farlo. Noi reiteriamo questo modello distorto e la stessa ipocrisia. Se non fossi ancora riuscita a essere chiara, non sto parlando esclusivamente di diritti delgi animali e nemmeno di vegetarianesimo, anche se lo consiglio vivamente, sto parlando di dare il via a un modello di vita più sostenibile, a un ruolo attivo del nostro essere cittadini del mondo.
Gli studi sull’intelligenza e sul comportamento degli animali sono studi pericolosi, perché sono capaci di creare quell’empatia che l’industria sistematicamente uccide, negandola. La nostra è una società machista, che si ostina a vedere i vegetariani come “malati” e non come socialmente responsabili e portatori di una memoria che i sistemi produttivi hanno l’interesse di occultare.
Il nostro non volere vedere, non volere sapere, il nostro comodo volere credere alle pubblicità che ci mostrano carni e formaggi allevati in fattorie idilliache dove tutti sorridono e sono felici, è il nostro crimine più grande. Siamo complici di un meccanismo che è lo stesso che tentò di sopprimere le rivolte operaie, è lo stesso che ancora oggi fa sì che gli operai scendano disperati in piazza chiedendo allo stato di non chiudere le aziende per cui lavorano anche se lì dentro si ammalano di cancro. È il meccanismo di chi calpesta chi non ha voce, è lo stesso meccanismo che ha permesso l’olocausto e ogni altro tipo di genocidio. Il nostro male è l’indifferenza, non l’ignoranza. L’ignoranza si può colmare con la conoscenza e con la curiosità. Ma siamo diventati docili, ci piace credere a quello che vediamo scritto sulle etichette degli alimenti che compriamo. Il solo pensiero che un acquisto inconsapevole ci renda criminali è per noi insostenibile, ma è quanto di più prossimo alla verità.
La nostra etica fa acqua da tutte le parti, siamo i signori dell’incoerenza. Gli animali negli allevamenti non hanno nemmeno la forza di reggersi sui propri arti frantumati e storpi, le scrofe vengono ingravidate tramite fecondazione artificiale e costrette a un parto dopo l’altro, fino alla morte. Eppure la nostra società è contraria alla fecondazione assistita. È contraria a rendere genitori persone responsabili che altrimenti non potrebbero avere figli, ma è favorevole quando si tratta di produrre migliaia di quintali di carne malata di cui vediamo, e vedremo, l’effetto sui nostri corpi e su quello dei nostri figli. Si sa ancora così poco dei farmaci che vengono somministrati agli animali.
Inoltre, ed è necessario ricordarlo, negli allevamenti intensivi lavorano anche gli esseri umani. E il turn over è superiore al cento per cento. Una carissima amica psicoterapeuta mi ha raccontato di una sua paziente che per un periodo brevissimo della sua vita si è vista costretta ad accettare un posto in un allevamento intensivo di galline ovaiole, il ruolo che le diedero all’interno di quella barbara catena di montaggio consisteva nell’afferrare ogni pulcino maschio e gettarlo nel trita-pulcini. Questa ragazza vomitava ogni mattina prima di andare al lavoro e ogni sera si svegliava colta da attacchi di panico. Anche questo va detto, va detto che le persone che occupano quei posti di lavoro spesso non hanno alternative, non possono lamentarsi, non possono pretendere e nemmeno denunciare. E l’annientamento dei senza-voce continua.
Siamo veramente l’unica razza che non provvede con lungimiranza alla difesa e alla tutela delle risorse che ne consentono la sopravvivenza. In questo siamo pazzi. E ci destiniamo alla catastrofe.
Il mio non vuole essere un inno a una vita salutista, che ognuno si distrugga come vuole, se vuole. Ma credo che a tutti faccia piacere pensare a galline che ancora sanno volare e non a palloni di antibiotici e batteri su zampe mollicce e spezzate. E credo che a tutti piaccia pensarci su un pianeta ancora blu, e non color merda.
La nostra indifferenza ai problemi di impatto ambientale non è innocua, anzi.
Per essere crudeli basta rinunciare all’empatia. E con essa, al nostro essere umani.
Chiudo citando un altro libro che consiglio vivamente, contiene una lettera preziosa di Rosa Luxemburg e testi di Karl Kraus, Kafka, Canetti e Joseph Roth. Forse, la sintesi eccelsa di quello che claudicando ho cercato di dire è nelle parole di Kafka, in Una vecchia pagina. Credo sia il modo migliore per ricordarci il nostro potere di popolo, senza puntare sempre il dito ipocrita contro allevatori e aziende, mentre con l’altra mano ci ingozziamo dei loro prodotti: “A noi artigiani e mercanti è affidata la salvezza della patria; ma noi non siamo all’altezza di un tale compito, né ci siamo mai vantati di esserne capaci. Un malinteso è questo, ed esso ci porta alla rovina”.



