di Girolamo De Michele*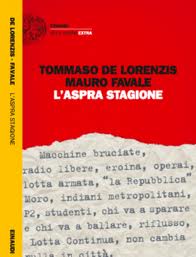
Tommaso De Lorenzis, Mauro Favale, L’aspra stagione, Einaudi Stile Libero, Torino 2012, pp. 272, € 18.00**
That’s the press, baby, the press! And there’s nothing you can do about it. Nothing!
Humphrey Bogart, Deadline — U.S.A.
«L’Italia non sogna più»: inizia così, L’aspra stagione di De Lorenzis e Favale. L’Italia ha smesso di sognare e ha imparato a ingurgitare: di tutto. Un paese senza sonno e senza sogni, senza differenza tra il giorno e la notte. Potevano scegliere, gli autori, di raccontare questa nave, questo Titanic in rotta verso un iceberg che aspetta da trent’anni; potevano raccontare dell’impatto, ormai imminente, con lo sperone di ghiaccio sotto quel pelo dell’acqua che nessuno scruta più, all’estremo limite di una rotta che non ha più vedette esperte di mare, ma solo navigatori satellitari; potevano raccontare del riordino delle sdraio sulla coperta della nave crociera, dei menù sui quali era richiesto di indicare primo, secondo e contorno per il giorno seguente.
Hanno scelto, invece, di raccontare «la storia del tragitto dalle piazze al molo, dalle case al porto, degli ultimi passi sulla terraferma».
E per farlo hanno scelto di tagliare il flusso continuo della storia, la pioggia di eventi grandi e piccoli che moltiplica i segni rendendoli indecifrabili, gli ultimi anni di chi, con in mano un biglietto di terza classe, «è salito prima degli altri sulla nave, per cadere in mare prima che il viaggio avesse inizio»: Carlo Rivolta, in arte cronista. In anni in cui i cronisti erano ancora pistards noir, pistaioli; in cui a leggere le cronache si sentiva il suono delle suole consumarsi sui ciottoli e sui selciati, si respirava il fumo delle sigarette che saturava i locali dei bar, delle osterie, o i gas di scarico delle automobili smarmittate. In cui si scriveva sul taccuino e sull’Olivetti 22, non sulle algide tastiere collegate al web, in redazioni senza collegamento con l’Ansa, copincollando dispacci dal web senza alzare il culo dalla sedia: senza verificare, senza fiutare l’usta, senza mordere la notizia. Cresciuto alla scuola di Paese Sera, dove ha imparato l’arte di scrivere due pezzi di seguito già pronti per la stampa, Rivolta arriva a Repubblica giusto in tempo per scrivere sul primo numero un’inchiesta sulla politica corrotta alle porte di Roma. Tempo un anno, e la sua prosa racconterà di quando Luciano Lama si recò all’Università di Roma per e di come ne fu cacciato, degli scontri del 12 marzo 1977 con parole che finiranno all’interno della ballata di Claudio Lolli I giornali di marzo, del movimento e della sua repressione, e dell’ombra lunga del brigatismo che su quel desiderio di radicale si allungava. Sempre un passo avanti: cronista di razza e poeta involontario, Rivolta nasconde all’interno del racconto dei crudi fatti i travagli e le doglie di ciò che, all’interno del vecchio, comincia a farsi spazio. Mentre ancora fumano le macerie della sala d’attesa della Stazione di Bologna, Rivolta è a San Francisco, a raccontare di altre macerie che seppelliscono «tutti i miti degli anni Sessanta»: quella scena punk nella quale «chi ha tempo di ascoltare un assolo di chitarra rock che dura più di tre minuti? Chi ha tempo di parlare bene? E soprattutto, chi se ne fotte di tutte queste cose?»
Gli anni Ottanta, per l’appunto.
Presi non per la coda, ma in anticipo, colti in quei primi vagiti che si sarebbero chiamati riflusso, ma soprattutto eroina: e dunque disgregazione, disperazione, afasia, impotenza. Morte, infine: la morte dei sogni di una generazione che voleva cambiare il mondo, e dopo i sogni di una generazione senza più sogni. Difficile trovare qualcuno che con più lucidità avesse capito, sin dall’inchiesta del gennaio 1979, a cosa avrebbe portato questa subdola amica, la Sweet Lady Jane di cui romanticheggiavano gli Stones: quale fosse il servaggio e l’umile attesa, che genere di sicurezza attendesse le vite legate alla piccola insulina, la “spada” che spuntava sempre più spesso dal taschino o dal borsello.
 La morte diventa una compagna di strada, una presenza quotidiana: per Carlo Rivolta, per la sua generazione, per un paese che ha smesso di credere nella realtà dei propri desideri e scivola tra miti tranquillizzanti e mani pietose che chiudono gli occhi. In attesa di qualcuno che annunci che la guerra è finita, quando ormai non ricorda più nessuno quale guerra, e perché: e soprattutto, non importa più a nessuno chi la guerra l’ha già vinta, a dispetto degli zombie che continuano a mimarla credendo di mirare al cuore dello Stato e colpendo l’usciere o il fattorino di Montecitorio. O Walter Tobagi, il cronista milanese che aveva cominciato a fiutare un’usta “strana” al “Corriere della Sera”, e forse nel paese, quando ancora nessuno sapeva il significato della sigla P2. Anche Rivolta, con Deaglio e Scialoja, viene “condannato a morte” all’interno di un lenzuolo scritto in una prosa che ammazzerebbe, oltre alla lingua italiana, anche il lettore: scampoli di un’impotenza che mette a Rivolta, contro la coazione a ripetere di questi fantasmi, una gran voglia di realtà, di «dare per gli altri, dare per tutti almeno quel poco di realtà che i tuoi occhi vedono, dare brandelli di verità e di vita». «È molto tempo che la parola “dare” ha perso di senso per molti di noi», scrive Carlo a Enrico Deaglio, direttore di Lotta continua, per cui ha lasciato Repubblica, in controtendenza rispetto ai molti che l’eskimo lo lasciano per il campari in Galleria, la Milano da bere e l’orologio sul polsino. Dopo aver anticipato, nell’ultimo pezzo scritto per il giornale di Scalfari, l’Italia che verrà nei tre giorni dell’agonia televisiva del piccolo Alfredino Rampi precipitato in un pozzo artesiano, «il dilatarsi dei palinsesti, lo sbandamento del pubblico da casa, lo smarrimento di un registro e di una cornice». La cronaca urlata, la vita in diretta, la rappresentazione della realtà senza bisogno della realtà: «nessuno vede Alfredino, ma tutti lo ricorderanno per sempre».
La morte diventa una compagna di strada, una presenza quotidiana: per Carlo Rivolta, per la sua generazione, per un paese che ha smesso di credere nella realtà dei propri desideri e scivola tra miti tranquillizzanti e mani pietose che chiudono gli occhi. In attesa di qualcuno che annunci che la guerra è finita, quando ormai non ricorda più nessuno quale guerra, e perché: e soprattutto, non importa più a nessuno chi la guerra l’ha già vinta, a dispetto degli zombie che continuano a mimarla credendo di mirare al cuore dello Stato e colpendo l’usciere o il fattorino di Montecitorio. O Walter Tobagi, il cronista milanese che aveva cominciato a fiutare un’usta “strana” al “Corriere della Sera”, e forse nel paese, quando ancora nessuno sapeva il significato della sigla P2. Anche Rivolta, con Deaglio e Scialoja, viene “condannato a morte” all’interno di un lenzuolo scritto in una prosa che ammazzerebbe, oltre alla lingua italiana, anche il lettore: scampoli di un’impotenza che mette a Rivolta, contro la coazione a ripetere di questi fantasmi, una gran voglia di realtà, di «dare per gli altri, dare per tutti almeno quel poco di realtà che i tuoi occhi vedono, dare brandelli di verità e di vita». «È molto tempo che la parola “dare” ha perso di senso per molti di noi», scrive Carlo a Enrico Deaglio, direttore di Lotta continua, per cui ha lasciato Repubblica, in controtendenza rispetto ai molti che l’eskimo lo lasciano per il campari in Galleria, la Milano da bere e l’orologio sul polsino. Dopo aver anticipato, nell’ultimo pezzo scritto per il giornale di Scalfari, l’Italia che verrà nei tre giorni dell’agonia televisiva del piccolo Alfredino Rampi precipitato in un pozzo artesiano, «il dilatarsi dei palinsesti, lo sbandamento del pubblico da casa, lo smarrimento di un registro e di una cornice». La cronaca urlata, la vita in diretta, la rappresentazione della realtà senza bisogno della realtà: «nessuno vede Alfredino, ma tutti lo ricorderanno per sempre».
In fondo dura “solo” cinque anni la discesa nel gorgo di Carlo Rivolta: un breve, lunghissimo lustro attraversato dal suicidio del movimento e dalla tragedia di Aldo Moro; dall’unità nazionale a Bettino Craxi, il nostromo che studiava da ammiraglio; dalla loggia P2 all’inizio del monopolio televisivo del cavalier Silvio Berlusconi; dalla resistibile ascesa di un mercato delle droghe e dell’antidroga — «Avete mai pensato a quanta gente, oltre ai “fuorilegge”, vive ormai dell’eroina? Cliniche private, medici, preti e comuni, ricercatori, chimici, avvocati, cani poliziotto, esperti giornalisti, eccetera eccetera. Ormai colorato o bianchi, legali o banditi, i pusher del “prodotto eroina” sono troppi». Anni compattati da un’unità di tempo e di luogo, come in una tragedia greca: e raccontati, come in una tragedia greca, in modo corale, con un concerto di giornalisti, uomini politici, celebrità e gente comune che entrano ed escono nella e dalla narrazione, lasciandovi dentro le proprie parole, i vissuti, impronte di vite reali: ma anche voci, canzoni, testimonianze dell’oggi che s’innestano su un passato prossimo/remoto che ancora non passa. Come Francesca Comencini, compagna di Carlo e testimone delle sue tensioni e passioni, ma anche ineludibile anello di congiunzione tra quegli anni e questo presente aperto dai giorni del G8 di Genova, da lei per prima raccontati col documentario Carlo Giuliani ragazzo, reportage giornalistico in puro stile-Rivolta. E, tra un capitolo e l’altro di questo taglio di un’epoca, alcuni articoli di Carlo Rivolta: come se la pluralità delle voci si arrestasse per ascoltare quella che viene da una pagina stampata, e nella sua inattualità continua a ronzare attorno alle coscienze intorpidite del presente, come quel moscone estivo che, nell’Atene dei primi filosofi, credeva nell’importanza di “dire la verità” sempre e comunque, anche a costo di ingurgitare il veleno. «Sarebbe un vero peccato vivere nel 2000 senza ricordare le cose (terribili) accadute negli ultimi decenni del Novecento», scrive un altro cronista d’altri tempi, Marco Nozza, il pistard noir per eccellenza. «O ricordandole male, che è poi lo stesso. Quella sì sarebbe una storia (e una vita) da imbecilli». Merito di De Lorenzis e Favale, aver scritto questo farmaco contro l’imbecillità al potere: sta al lettore, adesso, farne buon uso.
* Una versione più breve di questa recensione è uscita sul numero di luglio/agosto 2012 de L’Indice dei libri del mese, p. 20.
** Su L’aspra stagione vedi anche l’intervista agli autori su Giap, le recensioni di Jumpinshark, Gianluca Veltri, e l’audio dell’intervento di Tommaso De Lorenzis a Fahrenheit.



