di Girolamo De Michele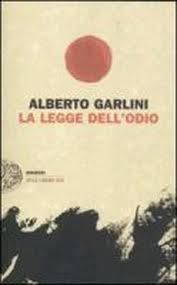
a proposito di: Alberto Garlini, La legge dell’odio, Einaudi Stile Libero, Torino 2012, pp. 814, € 22. Una versione più breve di questa recensione è stata pubblicata sul numero di maggio di L’indice dei libri del mese col titolo “Le scaglie del Leviatano”
L’esplosione del genere noir, negli anni ’90, ha avuto una evidente torsione politica: per un verso, gli autori più “neo-realisti” – Carlotto e De Cataldo per tutti – si sono proposti, tra gli altri, anche il compito di indagare quelle trame cosiddette “oscure” che i giornalisti di professione lasciavano cadere, cercando di illuminare, magari in filigrana o per allusione, seguendo quantomeno per via ideale la lezione dell’Ellroy di American Tabloid. Per altro, il ritorno alla narratività, al romanzo di trame, alla testa dura dei fatti ha visto nascere autori che indagavano aspetti del reale non direttamente legati ai grandi misteri, ma al reale quotidiano, indicando al lettore i punti di penetrazione di uno sguardo che non si ferma alla superficie delle strade e delle case — da Lucarelli e Biondillo ai “vecchi” Camilleri e Macchiavelli. Accadeva così che le tramas putridas (i marci stracci) della storia patria si integravano con la trama figurae (l’ossatura) dei romanzi.
Certo, di acqua sotto i ponti del genere ne è passata molta, a dispetto dei soli 4 anni che separano l’epopea del Libanese dalla pubblicazione di Gomorra: e su come il genere è sopravvissuto, per mutazioni, metamorfosi, autocritiche e ripensamenti, alla sua morte annunciata dalla “critica laureata” si potrebbe scrivere un saggio a sé. Ma queste considerazioni tornano, e torneranno, utili davanti a questo La legge dell’odio, l’ambizioso e corposo romanzo di Alberto Garlini che ha l’ambizione di collocarsi alle altezze della parte migliore del genere noir raccontando la prima stagione dell’eversione nera — dal 1968 a Piazza Fontana fino a Peteano — da un punto di vista eccentrico: quello di Stefano Guerra, militante neo-fascista la cui romanzesca biografia è ricalcata su quella di Vincenzo Vinciguerra (mentre la figura del deuteragonista Franco Revel suggerirebbe accostamenti con Stefano Delle Chiaie: ma è un’identificazione non necessaria al disegno narrativo). In questo modo, La legge dell’odio per un verso si propone come un Italian Tabloid che allude a Romanzo criminale: questo si è imposto come il testo definitivo sui rapporti tra malavita e potere, quello aspira a essere il romanzo definitivo sull’avvio della strategia della tensione; e dall’altro ammicca all’operazione narrativa di Le benevole di Jonathan Littell, torrenziale discesa nel maelstrom del nazismo effettuata dall’ufficiale SS Maximilien Aube. Sul romanzo di Littell la critica si è divisa sulla riuscita dell’operazione, segnalando comunque la pericolosità del materiale, che andava maneggiato con cura (e non saremo noi a dire se Littell vi è riuscito). Su Romanzo criminale il successo di critica ha talvolta oscurato la profonda conoscenza dei meccanismi della tragedia classica, il sottile lavoro di sperimentazione linguistica e la capacità dell’autore di nominare o alludere alla vastità eterogenea dei materiali (magari per recuperarli attraverso le derive filmiche e, soprattutto, televisive). Sta di fatto che, costretti dal prodotto letterario in sé prima ancora che dalla bandella editoriale, a fronte di queste pietre di paragone è non solo inevitabile prendere atto del fallimento di questo La legge dell’odio, ma è necessario indagare — in attesa di altri “romanzi definitivi”, posto che ce ne sia la necessità — le ragioni di questo scacco.
Garlini, come s’è detto, sceglie il noir come genere nel quale far coincidere un certo uso della lingua e un determinato trattamento dei materiali storici. Nello scegliere lo stile che vorrebbe essere noir, però, l’autore non sembra consapevole del lavoro sulla lingua che gli autori del genere hanno portato avanti nel ventennio di riferimento: dal lavoro sul linguaggio cronachistico, con lo slittamento della percezione temporale (descrizione just in time dell’oggetto-contesto del giornale, che viene fruito in tempo reale) che confligge con l’aspettativa del lettore, orientata sul tempo lungo della trama romanzesca; all’uso chirurgico della paratassi come continua sottrazione che apre vuoti di senso da far riempire al lettore (il noir è senz’altro una “macchina pigra”), o spazi in cui inserire gergalità vernacolari, citazioni spiazzanti, uso paronimico dei dialetti (si pensi a come Camilleri modella il rapporto tra italiano e dialetto siciliano a seconda che si tratti di un poliziesco o di un romanzo storico); fino alla costruzione di figure che sono, se il romanzo è ben scritto, allegoriche: la cui decifrazione è un altro aspetto di quel lavoro che la macchina pigra demanda al lettore. La lingua di Garlini, al contrario, è quanto di più scontato possa darsi nella scrittura di genere: paratassi ordinaria, scarsità di consecutive o secondarie — insomma, quanto si aspetterebbe di trovare in un noir uno di quei critici che i noir non li leggono, ma li suppongono. Le inserzioni linguistiche, che dovrebbero innestarsi sulla struttura ordinaria creando uno spiazzante passaggio dal linguaggio medio a quello “alto-retorico”, sono prese di peso dal meglio (cioè dal peggio) della letteratura neo-fascista, a partire da Julius Evola. Ma anche qui, l’operazione ha l’effetto di presentarci figure stereotipate che recitano Evola come i farisei i Salmi, come se avessero il rotolino di Cavalcare la tigre pendente davanti agli occhi: come se non fosse possibile ordinare una birra o un panino senza citare Réné Guénon o Pierre Drieu La Rochelle. Fatto è che in un buon noir i protagonisti non sono mai Tipi Ideali: il noir immette nella trama del reale dosi massicce di individualità, di singolarità. Anche quando i personaggi sono una folla, non si compone mai una figura generale, un simbolo universalizzabile, una metafora buone per tutte le stagioni: questo perché il noir, lungi dall’essere “realistico”, non aderisce all’ordine esistente — non mostra un ordine alternativo all’esistente, non difende una verità contro un falso. Il noir, per dirla con Deleuze, non fa altro che mostrare l’intera società nella più alta potenza del falso. I personaggi di Garlini sono invece stereotipi privi di spessore e psicologia, a partire dalla caratterizzazione sessuata: l’eroe, sul quale l’acqua calda della doccia scivola sulla pelle come le labbra di una vergine [sic!] è perennemente in erezione, al traino di una metafora banale che, reiterata, diventa comica; le donne sono mere figurine, oggetti sessuali sempre a disposizione della turgida verga del Maschio Fascista. È probabile che ciò fosse, nelle intenzioni di Garlini, finalizzato all’espressione del punto di vista fascista, che dovrebbe provocare, immaginiamo, un moto di disgusto nel lettore: ma se lo strumento comunicativo è manchevole, l’effetto è o il comico involontario — «amo le tigri perché coltivano la mia indifferenza» — o, peggio, la comunicazione, in assenza di una presa di distanza stilistica da parte dell’autore, del punto di vista fascista come “realistico” e, in definitiva, “oggettivo”. Esemplare è il punto di vista fascista sul confine orientale, le foibe, l’occupazione fascista della Jugoslavia: dove l’univoca versione dei fatti che esce dalla bocca dei personaggi rischia di far apparire Junio Valerio Borghese e la sua X Mas come un manipoli di eroi. Lo sfondo tragico che dovrebbe sorreggere il tutto diventa un fondale bidimensionale sul quale scorrono figurine di cartone, macchiette imbevute della retorica della “parte sbagliata”; ma lo stesso potrebbe valere per la figura di Giangiacomo Feltrinelli (l’editore Mengaldo, nel romanzo), per la cui raffigurazione Garlini recupera i più triti stereotipi da rotocalco; o Bruce Chatwin, inopinatamente catapultato in una quarantina di pagine al fine di farci sapere che anche l’intellettuale nomade, dopo aver mangiato fagioli, rutta, e quando piscia non si lava le mani.
 Ma questo sfondo è la Storia, che reclama i suoi diritti: a partire dalla documentazione, e dall’intenzione dell’Autore: che manipola materiali problematici senza possederne le chiavi, finendo col prendere per buono quanto letto per dovere di documentazione. Esemplare è la favola di Avanguardia Nazionale a Valle Giulia, avvalorata da una foto [a destra] nella quale si vede sì un drappello di neo-nazisti, alcuni dei quali riconoscibili — ma, per l’appunto, giusto una ventina: pochini, per fare di loro non dei semplici infiltrati, ma uno dei centri propulsori della contestazione. La stessa contestazione, nella quale i movimenti sono sempre composti da “cinesi”, sempre infiltrati da fascisti e servizi segreti, è qualcosa di cui Garlini non coglie, o comunque non riesce a rendere, le cause, le ragioni, l’ampiezza e la portata: scompare non solo il reale, con le sue dinamiche e i suoi conflitti, ma anche quella dialettica tra il potere e gli sconfitti che, alludendo alla risoluzione del conflitto di classe, costituisce il nerbo, secondo Manchette, del noir. Limiti documentari, interpretativi ed espressivi che precipitano in una ricostruzione della strage di piazza Fontana secondo una tesi — quella del doppio attentato, con Valpreda depositario di una prima bomba ignaro della seconda collocata dai fascisti — esposta da Paolo Cucchiarelli in Il segreto di Piazza Fontana, mastodontico volume che pretenderebbe di rovesciare fatti storici coincidenti con le verità giudiziarie dei processi istruiti e portati a termine dal giudice Salvini appoggiandosi sulla capocchia di spillo di un ex funzionario del SISDE e di un misterioso “mister X”, «un fascista operativo, uno che sapeva e che agiva». Una tesi, scrive Adriano Sofri, che riduce «la mole infame di manipolazioni depistaggi provocazioni e delitti di corpi e uomini dello Stato all’unico fantomatico segreto di cui lui è il segretario: il Raddoppio [di bombe e attentatori]», e che Corrado Stajano ha liquidato come «una palla al piede». E che, infine, è stata smentita in termini di «assoluta inverosimiglianza» dagli stessi giudici della procura di Milano. E che però Garlini fa propria «narrativamente» [1], col solo effetto di aumentare quell’impressione di nebbiosa indeterminazione, quella notte in cui i gatti son tutti bigi e, nell’indistinguibilità di vero e falso, restano solo «il verosimile, l’inverosimile e le varie gradazioni della menzogna»: che il narratore ben si guarda dall’affrontare.
Ma questo sfondo è la Storia, che reclama i suoi diritti: a partire dalla documentazione, e dall’intenzione dell’Autore: che manipola materiali problematici senza possederne le chiavi, finendo col prendere per buono quanto letto per dovere di documentazione. Esemplare è la favola di Avanguardia Nazionale a Valle Giulia, avvalorata da una foto [a destra] nella quale si vede sì un drappello di neo-nazisti, alcuni dei quali riconoscibili — ma, per l’appunto, giusto una ventina: pochini, per fare di loro non dei semplici infiltrati, ma uno dei centri propulsori della contestazione. La stessa contestazione, nella quale i movimenti sono sempre composti da “cinesi”, sempre infiltrati da fascisti e servizi segreti, è qualcosa di cui Garlini non coglie, o comunque non riesce a rendere, le cause, le ragioni, l’ampiezza e la portata: scompare non solo il reale, con le sue dinamiche e i suoi conflitti, ma anche quella dialettica tra il potere e gli sconfitti che, alludendo alla risoluzione del conflitto di classe, costituisce il nerbo, secondo Manchette, del noir. Limiti documentari, interpretativi ed espressivi che precipitano in una ricostruzione della strage di piazza Fontana secondo una tesi — quella del doppio attentato, con Valpreda depositario di una prima bomba ignaro della seconda collocata dai fascisti — esposta da Paolo Cucchiarelli in Il segreto di Piazza Fontana, mastodontico volume che pretenderebbe di rovesciare fatti storici coincidenti con le verità giudiziarie dei processi istruiti e portati a termine dal giudice Salvini appoggiandosi sulla capocchia di spillo di un ex funzionario del SISDE e di un misterioso “mister X”, «un fascista operativo, uno che sapeva e che agiva». Una tesi, scrive Adriano Sofri, che riduce «la mole infame di manipolazioni depistaggi provocazioni e delitti di corpi e uomini dello Stato all’unico fantomatico segreto di cui lui è il segretario: il Raddoppio [di bombe e attentatori]», e che Corrado Stajano ha liquidato come «una palla al piede». E che, infine, è stata smentita in termini di «assoluta inverosimiglianza» dagli stessi giudici della procura di Milano. E che però Garlini fa propria «narrativamente» [1], col solo effetto di aumentare quell’impressione di nebbiosa indeterminazione, quella notte in cui i gatti son tutti bigi e, nell’indistinguibilità di vero e falso, restano solo «il verosimile, l’inverosimile e le varie gradazioni della menzogna»: che il narratore ben si guarda dall’affrontare.
Compito del narratore che s’avventura in queste lande dovrebbe essere lasciare intravvedere almeno una delle scaglie del Leviatano: accrescere la fumara che lo avvolge è un gesto, politico ed etico oltre che letterario, reazionario.
[1] È emblematico che nella puntata di Fahrenheit del 3 aprile 2012 Garlini abbia dichiarato, rispondendo a una domanda sulla tesi della doppia bomba: «È una tesi cui ho aderito dal punto di vista narrativo, ma dal punto di vista storico non ci aderirei: sono perfettamente d’accordo sul fatto che sia una tesi che fa acqua da tutte le parti» (ascolta qui, al minuto 12:30)



