di Fabio Deotto
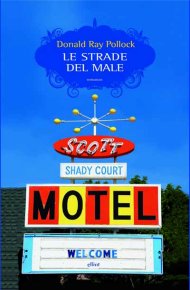 Donald Ray Pollock, Le strade del male, Elliot, 2011, pp. 256, € 16,50.
Donald Ray Pollock, Le strade del male, Elliot, 2011, pp. 256, € 16,50.
La risposta, nel caso ve lo stiate domandando, è: no. In questa recensione non si parla di “banalità del male”. Qualcun altro, in qualche altra recensione lo farà. Scomoderà Hannah Arendt e Le Benevole di Jonathan Littel, Winter’s Bone di Debra Granik o The Killer Inside Me di Michael Winterbottom. Si avviterà in un citazionismo carpiato ostruito da virgolette e corsivi. Alla fine proverà a convincervi di saperne più dell’autore stesso, sugli obiettivi e le tematiche del libro in questione.
Io invece voglio parlare del primo romanzo di Donald Ray Pollock, Le strade del male (titolo originale: The devil all the time) lasciando da parte questo genere di speculazioni. E non per vezzo, o capriccio, ma per rispetto: perché una cosa che traspare chiara e inequivocabile dalla prosa di Pollock, è la sua assoluta estraneità a riflessioni etiche e ambizioni filosofiche.
Le strade del male intreccia tre diverse linee narrative che corrispondono a tre diversi frammenti di miseria. C’è quella di Arvin Russel, ragazzino cresciuto nella provincia più dimenticata dell’Ohio meridionale, con un padre psicologicamente devastato dai ricordi della Seconda Guerra Mondiale e pericolosamente ossessionato dalla fede. C’è quella di Carl e Sandy, un’improbabile coppia che alterna inverni di lavoro e squallore urbano a estati dedicate alla “caccia” di autostoppisti. Ci sono poi due predicatori in esilio: uno che ingoia ragni per dimostrare la sua fede agli astanti, l’altro, un ciccione storpio e pedofilo, che lo accompagna strimpellando una chitarra da una carrozzella.
Per quanto possa risultare strano, considerata l’attenzione che questo romanzo riserva alla violenza e al fondamentalismo religioso, Pollock non sembra voler affrontare queste due tematiche, né tantomeno fornire uno spaccato dell’Ohio del sud degli anni ’50 e ’60. Il suo intento è puramente narrativo.
Quello che fa Pollock, sostanzialmente, è piazzare il lettore di fronte a un’immagine narrativa così nitida da non lasciare spazio alle interpretazioni. Più una foto in bianco e nero che una tavola di Rorschach, uno scatto privo di sfumature di grigio davanti a cui si hanno due e due sole alternative: o lo si accetta come un frammento di realtà, oppure no. Insomma, una sorta di “fatto narrativo” che viene sottoposto al giudizio del lettore.
Per capirci, ecco un esempio di fatto narrativo che troverete in Le strade del male:
C’è una coppia di individui ordinariamente mediocri che gira il Paese in auto lasciando dietro di sé una scia di cadaveri di autostoppisti. Lei siede al volante, lui si stuzzica i denti cariati sul sedile del passeggero. Gli autostoppisti che vengono caricati stanno sempre dietro. Ogni volta, a un certo punto del tragitto, la donna comincia a saettare occhiate maliziose dallo specchietto retrovisore, l’autostoppista coglie l’antifona e accetta l’offerta sessuale. I tre scendono dall’auto, l’autostoppista comincia a darsi da fare, nel frattempo il marito della donna prepara la sua macchina fotografica da professionista. Comincia a scattare solo dopo aver piantato una pallottola in testa all’autostoppista, ancora in pieno amplesso. Questa cosa si ripete una dozzina di volte ogni estate. La coppia lo chiama “andare a caccia”.
La domanda che sorge spontanea nel leggere tutto ciò è la seguente: è possibile rendere plausibile una vicenda simile senza dare ai due personaggi il ruolo degli squilibrati? Niente retorica, niente simbolismi o riferimenti specifici alla realtà. Pollock ti piazza davanti agli occhi questo fatto narrativo e tu non puoi fare altro che chiederti: riesco a credere a questi personaggi senza bisogno di tirare in ballo tare psichiche, stupri pregressi o infanzie problematiche? Questione che in realtà conduce a un interrogativo più ampio, e scomodo: è possibile che un essere umano compia azioni tanto crudeli (disumane?) pur avendo tutti gli ingranaggi al loro posto — o meglio: pur avendo tutte le carte in regola per giocarsi un’esistenza ordinaria? Se alla fine del romanzo la risposta è “sì”, allora Pollock ha vinto. Ha consegnato al lettore una storia assurda e plausibile, senza servirsi di artifici retorici, corollari filosofici, incursioni biografiche ex-machina o distorsioni stilistiche diversive (come invece farebbe Chuck Palahniuk).
Il fatto è che Donald Ray Pollock non ha risposte da dare. E se è per questo, nemmeno domande. Si limita a presentare dei fatti narrativi, nudi e spogliati d’ogni intento retorico, bianchi come ossa spolpate lasciate a seccare sotto un sole freddo. Tutto il resto spetta al lettore. È questi che, a lettura conclusa, può decidere di porsi interrogativi più o meno esistenziali e darsi risposte più o meno soddisfacenti. Ma in fin dei conti, non è nemmeno tenuto a farlo.
E il recensore? È per sua natura tenuto a porsi questo tipo di domande a lettura conclusa? Probabilmente sì. E una domanda che sarebbe interessante porsi è: questa attitudine apparentemente immune a ogni trucchetto, strizzata d’occhio o concessione nei confronti del lettore, questa capacità (o qualità inconscia) che Pollock ha di presentare fatti narrativi nella loro più cruda essenza, fottendosene del cosiddetto “lettore ideale”, quanto ha a che fare con il fatto che Pollock ha cominciato a scrivere a 60 anni e che è dunque del tutto estraneo agli stilemi e alle sottili competizioni che ingessano il panorama letterario odierno?
Perché é inutile provare a ignorarlo, il fatto che Pollock sia un esordiente di 62 anni che è approdato alla narrativa dopo una vita a spellarsi i palmi in una cartiera lo leggi nella quarta di copertina e ti rimane addosso per tutta la lettura.
Ci pensi quando cominci a seguire le vicende di Arvin Russel, ragazzino cresciuto nell’America culla del white trash più estremo, fatta di crocefissi ubiqui, predicatori lascivi e denti guastati da pasti rifritti. Ci pensi perché i Russel sono di Knockemstiff, paese natale di Pollock, e come Pollock Arvin è nato all’inizio degli anni ’50. Ci pensi e ti convinci che nella storia ci debba essere necessariamente una sostanziosa padellata di materiale autobiografico.
Il che è vero, ma solo fino a un certo punto. Giusto un mese fa, i ragazzi che gestiscono l’ottimo portale di lettura e scrittura LitReactor.com, hanno organizzato un gruppo di lettura su Le strade del male. Chi aderiva era tenuto a leggere il romanzo di Pollock entro una certa data e poi, attraverso il forum, poteva porre le domande direttamente all’autore. Tra le risposte date da Pollock, una in particolare ha catturato la mia attenzione. Un lettore chiedeva appunto a Pollock se il materiale alla base del suo romanzo fosse in qualche modo autobiografico:
“Anche se molto del mio lavoro ha dentro pezzetti di ‘realtà’ — brandelli di conversazioni ascoltate di sfuggita, la vecchia auto di qualcuno, un dettaglio che ho visto da qualche parte, roba così — rimane comunque finzione. Eppure, credimi, un sacco di gente nel mio paesino è convinta che sia basato su fatti reali, pur non essendo in grado di indicare un evento specifico. Questo, a mio modo di vedere, è un complimento.”
Ecco fatto: l’autore presenta un fatto narrativo (o fittizio se preferite) che va oltre i limiti dell’assurdo e i lettori dell’Ohio del sud, che pure avrebbero più ragioni di chiunque altro di storcere il naso, si ritrovano a chiedersi se sia o meno reale. Palla in buca, Pollock vince la partita.
Il lavoro nella cartiera, le brutture dell’America del dopoguerra e l’età di Pollock sono ingredienti marginali. Man mano che l’intreccio si dipana capisci che il fatto che sia nato e cresciuto nel buco del culo dell’Ohio, o che abbia iniziato a scrivere dopo aver completato un percorso lavorativo ai operaio, non sono poi caratteristiche così determinanti nel fare di Pollock un buon autore. Semplicemente, Pollock è un narratore nato, nel senso più americano (e meno europeo) del termine. Un autore capace di raccontare una storia ai limiti del parossistico (a proposito, astenersi stomaci deboli) senza interrompere mai l’ipnosi operata nel confronto del lettore.
In Le strade del male ci sono storpi pedofili, predicatori che si ingozzano di ragni, una coppia che caccia autostoppisti per fotografarli mentre li scopano e poi freddarli a revolverate, animali sgozzati su un ceppo trasformato in altare, predicatori pedofili e sceriffi corrotti, e un nugolo di persone che muoiono schiacciate come mosche da eventi poco più che aleatori. Il rischio di scivolare nel pretenzioso si nasconde dietro a ogni pagina, eppure Pollock riesce a rimanere saldamente in piedi e a organizzare tutta questa brodaglia nera in una storia ben calibrata che sprizza umanità da ogni personaggio, anche il più spregiudicato, anche il più disumano.
Certo, non tutti i fatti narrativi sono ugualmente plausibili (la storia dei due predicatori vagabondi, ad esempio, lo è poco), e il romanzo è appesantito da alcuni problemi che ricorrono negli autori esordienti. Ad esempio, Pollock mostra il suo fianco più vulnerabile nelle descrizioni, quando non riesce a evitare di calcare la mano sui dettagli della sporcizia umana e ambientale che caratterizza il Midwest degli anni 50-60: i denti sono costantemente marci, cariati o ingialliti, i capelli sono unti e stopposi, i colletti delle camicie sono necessariamente logori, i corpi devastati, gracili, gli indumenti lerci, le scarpe bucate, le stanze inevitabilmente occupate dal tanfo acre della decomposizione. Questo è un problema, perché così facendo l’autore toglie realismo a una storia che pur nella sua estrema crudezza conserva un cuore vivo e pulsante.
Ma è comunque un problema secondario. La vera forza del romanzo consiste nella capacità dei suoi fatti narrativi di seminare dubbi pronti a germogliare a lettura finita. Vi faccio un altro esempio: A un certo punto, nel romanzo, un uomo scopre che la moglie sta morendo di cancro, a 30 anni. Deciso a fare di tutto per salvarla comincia a sacrificare decine di animaletti su un vecchio ceppo nel bosco dietro casa. Ne fa fuori a centinaia, rovescia intere secchiate di sangue sul ceppo e ogni giorno passa ore a pregare inginocchiato in una brodaglia rossiccia di fango e sangue rappreso. Man mano che le condizioni della donna peggiorano lui passa a sgozzare pecore, volpi, addirittura cani, ne inchioda i resti alle braccia di una croce eretta dai resti di una staccionata. Le urla e l’odore di morte scendono dalla collina e raggiungono le case dei vicini.
Sempre sul forum di LitReactor, un lettore chiede a Pollock se anche questo personaggio avesse qualcosa di biografico:
“C’era un vecchio, molto religioso, che viveva dietro di noi quando ero un ragazzino. Ogni sera, verso l’ora di cena, si incamminava nel bosco e pregava per alcuni minuti. Alcune volte si metteva a urlare, e se il vento soffiava dalla parte giusta, capitava di riuscire a sentirlo. Non mi fraintendete, non era pazzo o roba simile, solo molto devoto.”
E allora ecco che chiudi Le strade del male e ti ritrovi per le mani, insistente, una verità fastidiosamente plausibile, la risposta che nessuno vorrebbe mai dare a domande di questo tipo:
E se il Male non fosse banale, né straordinario, né tantomeno descrivibile? Se si trattasse solo di una parola di cui abbiamo un folle bisogno, per rassicurarci e convincerci dell’esistenza di un Bene? E se dunque non esistessero persone malvagie? Riusciremmo ad accettare di essere tali e quali ai personaggi di Le strade del male? Riusciremmo ad accettare che la nostra “normalità” non sia frutto del nostro corredo genetico o della nostra educazione, ma solo di un felice intreccio di circostanze? Insomma, avremmo mai il coraggio di ammettere che le persone malvagie probabilmente non siano pazze o roba simile, ma solo molto devote?



