di Franco Pezzini
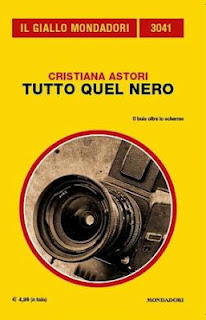 Il negozio me l’aveva segnalato un amico: ci trovi un sacco di roba — aveva detto — e tra l’altro molto horror, tutto di seconda mano. In una via appartata di San Salvario, zona uffici, a due passi da dove lavoravamo: un edificio moderno rispetto agli altri intorno, di quelli un po’ grigi che avrebbero sperato di affittare meglio ma accontentiamoci, con grandi vetrine. A ben vedere, uno spazio francamente eccessivo per le necessità del negozio: aria da luogo d’incontro (manifesti psichedelici, volumi sull’LSD e opuscoli underground seminati in giro, lattine di beveraggi) più che di commercio, e in effetti scopro che c’è di mezzo un’associazione. A gestirlo alcuni giovani: ma i banconi con file di vhs — non si parla ancora di dvd — si rivelano di qualche interesse, e soprattutto uno scaffale (a sinistra, entrando) con videocassette a noleggio. C’è anche un catalogo organizzato alla buona, basta prendere la tessera per garantirsi a prezzo economicissimo la visione di film che altrove non troverei facilmente. Molte pellicole del fantastico meno comune o di exploitation, dalle provocazioni americane degli anni Settanta a un ampio parco del Vecchio Mondo per il leggendario marchio Redemption: e tra questi, naturalmente, una buona scelta di titoli di Jean Rollin e Jess Franco, che all’epoca conosco quasi solo di fama e ovviamente corro a vedere.
Il negozio me l’aveva segnalato un amico: ci trovi un sacco di roba — aveva detto — e tra l’altro molto horror, tutto di seconda mano. In una via appartata di San Salvario, zona uffici, a due passi da dove lavoravamo: un edificio moderno rispetto agli altri intorno, di quelli un po’ grigi che avrebbero sperato di affittare meglio ma accontentiamoci, con grandi vetrine. A ben vedere, uno spazio francamente eccessivo per le necessità del negozio: aria da luogo d’incontro (manifesti psichedelici, volumi sull’LSD e opuscoli underground seminati in giro, lattine di beveraggi) più che di commercio, e in effetti scopro che c’è di mezzo un’associazione. A gestirlo alcuni giovani: ma i banconi con file di vhs — non si parla ancora di dvd — si rivelano di qualche interesse, e soprattutto uno scaffale (a sinistra, entrando) con videocassette a noleggio. C’è anche un catalogo organizzato alla buona, basta prendere la tessera per garantirsi a prezzo economicissimo la visione di film che altrove non troverei facilmente. Molte pellicole del fantastico meno comune o di exploitation, dalle provocazioni americane degli anni Settanta a un ampio parco del Vecchio Mondo per il leggendario marchio Redemption: e tra questi, naturalmente, una buona scelta di titoli di Jean Rollin e Jess Franco, che all’epoca conosco quasi solo di fama e ovviamente corro a vedere.
Per un certo periodo, vado al negozio una volta la settimana: noleggio i vhs per un paio di giorni, e me ne torno a casa trionfante. Si tratta forse di una collezione messa insieme da un appassionato, e la visione frequente non ha ovviamente giovato ai nastri — nelle cui stanchezze perlacee immagino apparirà prima o poi impressionato qualche arcano segreto di retrobottega (una poesia che la nettezza dell’immagine dvd farà inevitabilmente perdere). Tutto insomma procede bene: o almeno fino al giorno in cui, recatomi al negozio, trovo mesto il ragazzo dietro il banco. Il prezioso parco film, mi dice, è stato appena confiscato dalla Finanza per irregolarità SIAE… e cosa ne sia stato in prosieguo, lo ignoro. Tornerò al negozio sempre più raramente per buttare un occhio alle videocassette in vendita, non trovando più niente d’interessante — e dopo un po’ chiuderanno i battenti.
Ma grazie a quei noleggi involontariamente abusivi di tanti anni fa ho incontrato Soledad Miranda. A lei la scrittrice Cristiana Astori, saggista e traduttrice, ha di recente dedicato un romanzo bellissimo, Tutto quel nero, meritoriamente accolto dai responsabili de Il giallo Mondadori per un’uscita in edicola (ottobre 2011, n. 3041), ma che ora andrebbe riproposto in libreria. Un testo del genere, elegantemente cinefilo e e fitto di echi, frutto (si avverte) di lunghe ricerche ma anche pieno di fantasia e scritto benissimo, ha tutti i numeri per diventare oggetto di culto e insomma non dovrebbe sparire dopo un mese dal giornalaio.
Laggiù ho incontrato, dicevo, Soledad Miranda; ma anche il suo simbolico contraltare che pure appare nel romanzo di Astori, Lina Romay, la notizia della cui morte — a metà di febbraio, non ancora sessantenne — merita rammentare. Proprio a loro, Soledad e Lina, può in fondo riconoscersi il ruolo di patrone di quell’ideale cineteca di Babele che dal vecchio negozio di San Salvario all’odierno brulicare di riproposte in dvd o su internet oppone alle produzioni da red carpet un cinema ruspantemente diverso. Circonfuso di una propria paradossale poesia e capace di evocare, prima ancora che i fremiti dei sensi tanto biasimati dai censori, un malinconico e potente magnetismo.
“Questa donna mi sta dando qualcosa che nessun’altra attrice mi ha mai dato” avrebbe detto Christopher Lee di Soledad Miranda, sua partner ne El Conde Drácula, 1969: e se si è spesso criticato il film per la fedeltà un po’ coatta al romanzo stokeriano (erano del resto le attese dei produttori), una visione meno frettolosa permette non solo di apprezzarlo nella sua unità ma di goderne le prove d’attori — in particolare quella di Soledad/Lucy, coi suoi abbandoni al buio che incalza. Sul suo set poi, in un’epoca in cui documentari making of non sono ancora di moda, viene girato da Pere Portabella e Joan Brossa il poetico film-vampiro (di un’altra pellicola) Vampir-Cuadecuc, 1970: dove tra l’altro si conserva l’unica testimonianza di Soledad dietro le quinte. Vengono così fermati i momenti in cui si applica da sola il trucco di scena, e il collega Jack Taylor (nel film, Quincey Morris) la raccoglie tra le braccia per posarla con delicatezza nella bara. Ma il resto, non immortalato dalla pellicola, sorge dalle memorie dei colleghi come Lee che, pur avendo azzannato in anni di draculations un parco cospicuo di gentili partner, resta tanto colpito dalla giovane spagnola.
Soledad era nata a Siviglia (cognome d’anagrafe Rendón Bueno) il 9 luglio 1943 da genitori portoghesi — e aveva l’arte in famiglia, perché era nipote della celebre Paquita Rico, cantante, attrice e danzatrice di flamenco. Prima di El Conde Drácula, Soledad aveva già avuto una carriera relativamente lunga in film spagnoli e persino produzioni internazionali di un po’ tutti i generi, dalla commedia al peplum, dall’horror al dramma. La sua icona di bellezza latina, tratti regolari e grandissimi occhi, la sua eleganza naturale e l’idea di fragilità e passione che evocava, la stessa ricchezza di artista (cantava, danzava, ma insieme amava la lettura, dipingeva e scriveva poesie) non potevano che attirarle l’attenzione dei produttori e di alcuni pigmalioni — tra i quali il portoghese José Manuel da Conceiçao Simões, pilota e in seguito industriale dell’auto, che l’aveva sposata nel ’66 rendendola madre l’anno dopo. Franco l’aveva già conosciuta sul set di uno dei primi film, il musical La Reina del Tabarín, 1960, dove Soledad aveva una piccola parte: e ora per El Conde Drácula le offriva nuovamente un ruolo.
Inizia così quel breve, incredibile sodalizio che trasforma una starlette da rotocalco nell’oggetto di un culto celebrato in tutto il mondo: la forza visionaria e provocatrice dell’uomo dal nome due volte blasfemo — Jésùs Franco Manera, a evocare (involontariamente) Gesù e il Generalissimo — trae dalla fragilità e dalla finezza malinconica di Lucy/Soledad rinata come vampira una potenza di icona che lei stessa non avrebbe mai pensato di acquisire. I sette film che seguono tra fine ’69 ed estate ’70 vedono il regista abbandonare pulp e costume per un taglio nuovo, spiazzante e di ormai conclamato erotismo: e ciò grazie a Soledad, mattatrice assoluta. Opere come De Sade 2000, Vampyros Lesbos e Sie Tötete in Ekstase (tutti 1970), mostrano come l’attrice conservi anche in scene scabrose — peraltro velate da una tristezza che non permette allo spettatore letture grossolane — un’incredibile dignità: qualcosa che al di là dei limiti delle sceneggiature e delle non sempre apprezzate peculiarità registiche (le famose zoomate acide di Franco) coinvolge con forza tutta nuova. L’ultimo dei sette, Juliette, ancora una volta ispirato da Sade, non sarà terminato; e se in genere si indica l’avventuroso Der Teufel Kam aus Akasava come ultima interpretazione dell’attrice, in almeno un’occasione Franco ha forse simbolicamente identificato per tale Sie Tötete in Ekstase, dove il personaggio di Soledad muore tra le fiamme di un incidente d’auto. In effetti la mattina del 18 agosto ’70, mentre la giovane si appresta festosamente a firmare un contratto che la impegnerebbe per più anni con il produttore di Franco e sotto la sua entusiasta regia, si trova in macchina col marito sulla Costa do Sol in Portogallo: quando all’improvviso uno stupido incidente sulla strada dell’Estoril frantuma ogni progetto. Giunta in coma in ospedale a Lisbona, Soledad muore.

L’impatto della notizia su Franco è devastante: il regista sprofonda in una tristezza ossessionata da spettri di morte da cui lo strapperà, col tempo, solo il rapporto con Lina Romay, destinata a succedere alla collega quale fetish actress. Se d’altronde parecchie sono le interpreti dei film di Franco, si è osservato come Soledad resti unica per il mistero di cui resta circonfusa in scene che metterebbero a nudo qualunque altra attrice di genere (e probabilmente non solo di genere). Il critico Tim Lucas nota che Soledad Miranda corrisponde per il cinema ispanico a ciò che Barbara Steele rappresenta per quello italiano degli anni Sessanta, ma il concetto va rettamente inteso: se Steele, col suo fatale e vampiresco carisma, appartiene in fondo alla grande famiglia dei mattatori del macabro, il ruolo della collega spagnola resta più perturbante e meno etichettabile.
La tragedia influisce ovviamente sulla produzione di Franco, che conosce in quel periodo un’ulteriore, rabbiosa svolta iconoclasta. Al gotico classico di El Conde Drácula con Soledad fa dunque ora seguire alcune disperate, grottesche e totalmente folli riletture delle vecchie macedonie all monsters; e se la draculesca contessa Nadine interpretata da Soledad in Vampyros Lesbos rappresentava un’indimenticabile icona di erotismo, ecco il regista riproporre vampire dalla parossistica voracità sessuale. Nel ’72 nota una giovane attrice teatrale, Rosa Maria Almirall, nata a Barcellona nel ’54 e moglie di un suo collaboratore: e dopo averla coinvolta per un film che non vedrà la luce, Relax baby, le costruisce addosso una trama secondaria in una delle fantasie pseudogotiche del periodo, La maldición de Frankenstein, 1972. Rosa diventa così Lina Romay, e il suo esordio da protagonista giunge l’anno dopo nei panni (piuttosto esigui) della vampira muta Irina del franco-belga Female Vampire, tra i più celebrati caposaldi dell’exploitation di tutta la storia del cinema: dove l’iniziale incedere seminuda dalla nebbia ha quasi il sapore di un’evocazione dai morti della collega scomparsa. Il temperamento ardente di Lina, il suo disinvolto erotismo e la fedeltà al mentore Franco caratterizzeranno da allora un lungo iter artistico — sviluppato presto anche come sodalizio di vita — e un’indimenticabile galleria di corpi femminili soggetti od oggetti di funamboliche perversioni, permettendo al regista lo sviluppo di fantasie sessuali sempre più tortuose ed esplicite. Qualunque valutazione si possa offrire su quel genere porno che tende a mercificare pesantemente la donna, le frequenti scampagnate in tale linguaggio di Lina Romay presentano tuttavia caratteristiche particolarissime: sia per la complicità affettuosa col regista e l’entusiasmo di una partecipazione in storie niente affatto banali, sia per la progressiva conquista a partire da lì di uno spazio creativo sempre maggiore. Infatti Lina non sarà solo attrice — in centodiciannove film, quasi tutti di Franco — e musa, ma anche produttrice, aiuto regista e regista a sua volta, sceneggiatrice, montatrice e comunque collaboratrice attivissima e custode del Provocatore con l’incalzare degli anni: una donna intelligente e fedele, che nelle interviste ammette il proprio esibizionismo (“Ogni attore lo è, io lo accetto con piacere — non sono un’ipocrita”) e pur affermatasi come capace di percorsi autonomi non smette di collaborare col compagno. Fino alla fine, il 15 febbraio scorso, portata via da un tumore.

Già comunque dall’interpretazione in Female Vampire (per l’epoca notevolmente audace) il paragone con Soledad s’impone allo spettatore: la malinconia, il tedio e la disperazione intessuti nella sensualità insolente di Irina appaiono richiamare e insieme contrapporsi alla tristezza misteriosa e carismatica della languida, elegante Nadine di Vampyros Lesbos. Come attestato da Franco, Soledad Miranda subiva con l’inizio delle riprese una trasformazione quasi fisica nei suoi intensissimi personaggi; ma dopo la sua morte tutte le attrici che lavorano col regista finiranno con l’essere profondamente influenzate dalla leggenda di lei, e la stessa Lina Romay avrà momenti di completa possessione e trasformazione nella defunta. Le due muse di Franco appaiono così idealmente come in rapporto di opposizione speculare o negativo fotografico: la perturbante ed enigmatica Soledad chiamata a possedere ogni altra interprete e soprattutto Lina, quasi a voler continuare una collaborazione stroncata dall’incidente, o piuttosto convocata negromanticamente dal sortilegio del cinema; la sensuale Lina disposta invece a offrirsi tutta, con una disponibilità devota e selvaggia, generosa e sconcertante, inabissandosi nell’altrove di una possessione e nel labirinto delle fantasie del partner per riemergere a un più ampio ventaglio di possibilità espressive. Un trasmutare di identità personali che è però in fondo parallelo e omologo al trasmutare di identità delle opere di quello stesso cinema: quella cineteca di Babele sperimentalissima e provocatoria, spesso bollata come impresentabile, fitta di versioni plurime (con tagli, scene diverse, rimontaggi, dotate ciascuna di un diverso profilo) o incomplete o mai girate, di titoli non trovati o equivocamente spalmati su versioni diverse. Un orizzonte di cui proprio i film di Franco rappresentano il caso più esplicito ed estremo — basti rammentare le differenti versioni diramate rispettivamente da Vampyros Lesbos e Female Vampire.
A voler presentare Tutto quel nero di Cristiana Astori senza sciuparlo svelandone la trama, si tratta proprio della storia — o meglio delle storie, indefinitamente biforcate tra inventiva umana e casualità bizzarra — di tali trasmutazioni d’identità: la ricerca di un film (la protagonista Susanna è stata ingaggiata per questo) perduto o incorporato in un altro. Un film in cui compare Soledad Miranda, e oscuramente connesso con la sua morte sulla strada dell’Estoril; un film che richiama indirettamente le possessioni di Lina Romay e forse di altri personaggi, e sprofonda in un dedalo di delitti, malinconie, avventure tra il Portogallo e Torino, tra i vecchi set di Franco e gli odierni blog di fan dell’exploitation. C’entrano poi Christopher Lee, Aleister Crowley, La nona porta di Polanski e il perduto Maldoror di Cavallone: un insieme di volti, temi, sentieri che la narratrice muove con abile lievità e scatenata fantasia, fino a una conclusione niente affatto scontata.
Tutto quel nero può essere letto come un poliziesco o un horror, o come un romanzo fantastico: in ogni caso qualcosa che ben recupera il senso di meraviglia del cinema e il trasporto (di simpatia, in qualche modo d’affetto) per le vite intessute nelle sue pieghe. E quello stesso trasmutare o rifrangersi d’identità per cui misteriosamente ci troviamo coinvolti attraverso la proiezione — persino a dispetto di gravi limiti di sceneggiatura, o di qualche zoomata di troppo — coi nostri sogni e passioni, struggimenti e ossessioni. Il labirinto di specchi insomma di quella cineteca di Babele che, come in una versione per adulti di Harry Potter, si schiude per me ancora in qualche muro di un edificio di San Salvario.



