di Franco Pezzini
 Parigi, maggio 1900. Senza aspettare lo spegnersi dell’eco dei passi dalle scale, Deo Duce Comite Ferro chiuse seccamente la porta. Nella luce un po’ smorta del gas le due stampe sul muro (de Molay sul rogo e una fantasia rosicruciana, con cornici pretenziose) si decifravano a stento. E i suoi occhi già piccoli parevano due fessure.
Parigi, maggio 1900. Senza aspettare lo spegnersi dell’eco dei passi dalle scale, Deo Duce Comite Ferro chiuse seccamente la porta. Nella luce un po’ smorta del gas le due stampe sul muro (de Molay sul rogo e una fantasia rosicruciana, con cornici pretenziose) si decifravano a stento. E i suoi occhi già piccoli parevano due fessure.
— Così il valoroso Plenipotenziario ha fallito — mormorò Vestigia ironica, dall’ingresso del salotto. La chioma le avvampava ribelle sul viso pallido: vista in quel momento, semplice tunica e senza un’ombra di trucco, sarebbe stato difficile riconoscere la bistrata sacerdotessa isiaca delle recite al Théâtre Bodinière. Un discorso simile, del resto, valeva per il grande ierofante in kilt e baffetti militari, rigido avanti a lei e perso nei suoi pensieri.
Vestigia riprese, sorridendo: — E sconvolto di abbandonare la sua bella cantante (un’americana, vero?) si prende una vacanza. In Messico.
Le luci di Montmartre brillavano su voci e rumori di Rue Saint Vincent, mentre una nuvolaglia carica di elettricità pareva raccogliersi lentamente nella sera. —Ha fallito — suonò a quel punto bassa, come trattenuta, anche la voce di Deo Duce Comite Ferro: un segno che la moglie riconosceva per pessimo, e smise di sorridere.
 Poi all’improvviso l’uomo in kilt si lanciò a passo di marcia verso la cucina. — L’insurrezione sarà stroncata — ringhiò, teatrale (uno sguardo a de Molay, anche lui tradito nel suo sacro ruolo) — e saranno quegli idioti a tornare piangendo a riconsegnare la Cripta! Dove hanno mancato gli uomini… — Vestigia gli andò dietro, ora il marito spalancava la dispensa rovistando rumorosamente tra barattoli, confezioni di gallette e bottiglie di salsa — …riusciranno gli Arconti.
Poi all’improvviso l’uomo in kilt si lanciò a passo di marcia verso la cucina. — L’insurrezione sarà stroncata — ringhiò, teatrale (uno sguardo a de Molay, anche lui tradito nel suo sacro ruolo) — e saranno quegli idioti a tornare piangendo a riconsegnare la Cripta! Dove hanno mancato gli uomini… — Vestigia gli andò dietro, ora il marito spalancava la dispensa rovistando rumorosamente tra barattoli, confezioni di gallette e bottiglie di salsa — …riusciranno gli Arconti.
Quando Deo Duce Comite Ferro raggiunse il pacchetto di piselli secchi, alla moglie sfuggì un’espressione perplessa.
Abbiamo lasciato la Golden Dawn in piena rissa coi fatti di Blythe Road (cfr. Victoriana 7), dove il plenipotenziario Aleister Crowley non è riuscito a imporre ai ribelli la volontà del vecchio capo Samuel Liddell MacGregor Mathers, nome magico Frater Deo Duce Comite Ferro. Vestigia (o, più precisamente, Soror Vestigia Nulla Retrorsum) è naturalmente la moglie di Mathers, Moina — per l’anagrafe Mina — Bergson, sorella del filosofo Henry, talentuosa artista e veggente nei riti del coniuge; e i due si sono trasferiti a Parigi, dove Deo Duce Comite Ferro può continuare ricerche e siparietti magici. E prima di raccontare cosa farà in quel frangente coi piselli secchi, dobbiamo concederci una digressione, passando però dalla farsa a toni più malinconici.
Quando, dopo lunga malattia, la scintillante e indipendente Amy Hogg muore prematuramente di cancro (1899), il marito Arthur Llewellyn Jones, più noto come Arthur Machen, pare trasformarsi all’improvviso in un personaggio dei propri racconti, alla deriva per Londra come un’anima senza pace. Amy insegnava musica, era appassionata di teatro, e aveva condotto per mano il compagno in quella Boheme letteraria londinese dove s’erano aperti rapporti profondi e duraturi. Per esempio con il narratore popolare e traduttore Edgar Alfred Jepson, e col Matthew Phipps Shiel autore di The Purple Cloud (1901/1929); ma anche, in particolare, con l’esoterista e scrittore Arthur Edward Waite, che, presentatogli da Amy, diverrà uno dei suoi più cari amici.
Non è comunque solo per lo sbandamento interiore di quel lutto che Machen aderisce alla Golden Dawn. A trascinarvelo è proprio Waite, che spera di coinvolgere una penna tanto febbrile nella stesura dei rituali dell’Ordine ermetico; ma in effetti un’alta marea dei sogni sembra calamitare a quella scuola gran parte degli spiriti insoddisfatti del cuore dell’Impero, compresi parecchi artisti (cfr. Victoriana 4). Se poi l’adesione rappresenta per Machen — nome magico, Frater Avallaunius — una sorta di ricreazione emotiva e un tuffo nel bizzarro, il letterato gallese non vi incontrerà il sollievo e la comunanza spirituale che cerca: ultimo ad aderire (21 novembre 1899) sotto la vecchia regola, prima cioè che la rivoluzione interna defenestri l’autoritario Mathers e una serie di convulsioni organizzative conduca alla scissione dell’Ordine, Machen avrà anzi modo di trovarsi ampiamente deluso dall’esperienza. Nel teatrino della rissa, il fascino del laboratorio Golden Dawn va in frantumi, e Machen stigmatizzerà con parole dure gli “impotent and imbecile Abracadabras” in cui l’Ordine, come il mondo vittoriano nel cui ventre era sorto, finisce fatalmente col morire.
Proprio per questo, l’associazione di frequente proposta tra il Machen narratore di genere fantastico e l’orizzonte magico dell’Alba dorata si riduce a dato storico o al segno di una ricerca, peraltro non esaurita: ciò che del resto il lettore attento dovrebbe avvertire da più indizi. L’idea di plaghe inferiori della realtà, e di una degenerazione che inverte il processo darwiniano nel tracollo di categorie sociali, morali, emotive e persino fisiche, evocata in testi come The Great God Pan, 1890/1894, e The Three Impostors or The Transmutations, 1895, rimanda agli anni precedenti l’affiliazione, e non c’entra con l’Alba dorata: le fonti sono letture personali (stregoneria, sopravvivenze di culti pagani, ipotesi sulla materia ectoplasmica in quelle che Machen pure considera sciocchezze medianiche) rielaborate in termini originalissimi e nutrite di suggestioni dei suoi anni più verdi. D’altra parte, a differenza che nell’opera di confratelli come Algernon Blackwood o lo stesso Yeats, la vertigine magica dell’Ordine non lascia tracce nelle narrazioni macheniane su trasalimenti della natura (il famoso The Terror, 1917) o sussurri e glorie dello spirito — come nell’ampio corpo delle sue fantasie mistiche, decadenti e simboliste, oggi forse meno apprezzabili dal grosso pubblico. E che rimandano semmai al clima del Tempio di Iside-Urania, il frammento di Golden Dawn cui Machen rimarrà affiliato senza eccessivi coinvolgimenti, e dove sotto la guida dell’amico Waite l’occulto viene rimpiazzato da speculazioni cristiano-esoteriche dal sapore medievaleggiante (con buona pace di Lovecraft, che secondo Robert M. Price si ispirerebbe proprio a Waite per l’omonimo stregone di The Thing on the Doorstep).
Al contrario, I tre impostori mantiene a oggi intatto il suo fascino: Machen vi propone una delle più straordinarie prove della letteratura fantastica moderna, un “capolavoro circolare” — come lo definirà Elémire Zolla — i cui singoli racconti, spesso scorporati in antologie, svelano un sapore diverso e persino più inquietante innestandosi in una struttura unitaria di atroce armonia e leggerezza. Pur dovendone anticipare qualcosa, sarebbe imperdonabile svelare l’intreccio di queste Mille una notte vittoriane, che tanto devono a Stevenson pur in termini di estrema libertà; e si rinvia il lettore — che sia giunto, beninteso, al termine del labirinto — alla bella introduzione di David Trotter all’ultima edizione italiana (I tre impostori, Fanucci 2004).
Per il lettore colto del tempo l’allusione più ovvia del titolo riguarda ovviamente quel Trattato dei tre impostori che ingiuriava le figure-chiave dei tre grandi monoteismi. Le origini del tema pare rimontino al X secolo, e tre secoli più tardi l’esistenza del blasfemo trattato passava per certa, anche se mancano testimonianze che qualcuno l’avesse mai letto. Forse si trattava di una semplice ipotesi nel segno degli pseudobiblia, o invece di una costellazione di libelli sullo stesso spunto polemico — e in ogni caso, perché la certezza venga documentata devono trascorrere altri secoli. Attorno al 1688 viene infatti composto un testo in latino, De tribus impostoribus, dato alle stampe a Vienna nel 1753; e nel frattempo all’Aja è apparsa anonima nel 1719 un’opera diversa in francese, La Vie et l’Esprit de Mr Benoît de Spinoza, che in successive edizioni verrà titolata Traité des trois imposteurs. Non è questa la sede per ripercorrere la tortuosa saga di un simile Necronomicon filosofico, che del resto non c’entra direttamente col romanzo di Machen: e tuttavia la sua eco blasfema e un po’ sulfurea ben si sposa al discorso sul Male articolato dallo scrittore gallese, e che nella figura dell’impostore trova inquietante epifania.
D’altra parte, come allude il sottotitolo originale al romanzo, qualche legame non accidentale collega impostura e trasmutazioni, nell’ambito del medesimo orizzonte di una materia ingannatrice che comprende lo stile. Già The Great God Pan evocava un’allarmante mutazione incidente sull’identità: ed è almeno suggestiva l’assonanza tra l’infernale meretrice Helen Vaughan lì evocata e la presunta Diana Vaughan, satanista pentita di quel famoso “affare Taxil” che fingendo di denunciare la natura demoniaca della massoneria si rivelerà alla fine (1897) un’enorme beffa ai danni dei cattolici. Se non è escluso che il nome Diana Vaughan appartenesse a qualche innocente conoscenza del burlone Léo Taxil, nella finzione si sarebbe trattato di una discendente dell’alchimista seicentesco Thomas Vaughan in odor di Rosacroce; e visto che Machen, gallese come lui, doveva a sua volta ben conoscerlo, i nomi delle due fanciulle infernali potrebbero richiamarsi alla stessa fonte. Anche se ovviamente, alla luce della comunanza nel segno dell’impostura, sarebbe suggestivo immaginare che la protagonista della truffa francese traesse diretta ispirazione dalla creatura di Machen.
Ma un’Helen c’è anche ne I tre impostori: e come la mitica, losca Elena di Sparta fa trascolorare le proprie identità tra continui cambi di versione (fino al sospetto che a Troia con Paride restasse un semplice simulacro), così qui la sua omonima è deputata a evocare le storie più nere all’insegna della menzogna e della confusione d’identità. Le fittizie trasmutazioni dei racconti, con spiriti e corpi dissolti in una febbre affabulatoria di disgusto, conducono però all’autentica devastazione psichica e fisica del raggelante finale: dove il narcisismo dei protagonisti Dyson e Phillipps, le loro pose di letterati-detective e la rifrazione in loro dello stesso lettore trascinano al tragico fallimento dell’indagine.
Impostore è colui che si finge altro — quanto a dati anagrafici o caratteristiche — per propri scopi, un nemico della verità che irretisce menti e cuori: nella fattispecie tre personaggi che corrono per il romanzo in un gioco allegro, la cui natura spietata si percepisce soltanto alla fine. Per la nostra cultura mediterranea adagiata sul culto del furbo non è immediato cogliere lo specifico intrinsecamente maligno dell’impostura denunciato in tutto un filone di autori vittoriani, connesso a un valore della fiducia diffuso nel mondo anglosassone e sostenuto da riferimenti alle Sacre Scritture. Emblematiche sono le immagini dell’Apocalisse sulle bestie asservite al Drago/Satana e in arrivo rispettivamente dal mare e dalla terra, in particolare la seconda (13, 11-18) subdola e ingannevole. E del resto i tre impostori di Machen sono a loro volta asserviti a quel terribile, sedicente dottor Lipsius che potrebbe essere lo stesso Moriarty di Conan Doyle (creato, non a caso, solo un paio d’anni prima). Lipsius, come Moriarty, unisce insospettabilità — anche caratteriale, visto che appare “sereno e benevolo” — e immensa cultura, abilità manipolatoria da Vecchio della Montagna e culto dello stile (“Per noi lo stile è veramente tutto”): nel teatro mitologico di una struttura criminale fantasmagorica e improbabile, si tratta in sostanza del mestatore per antonomasia, l’Arci-impostore mentitore e assassino, una sorta di ipostasi laica del diavolo.
Eppure, in termini che divertirebbero Machen, qualcuno ha indicato quali tre impostori proprio i padri fondatori della Golden Dawn, le cui farraginose vicende troverebbero nel clima di inganni e disinformazioni del romanzo una collocazione non incongrua. Tutto parte dal misteriosissimo manoscritto cifrato che costituirà poi base per tutti i riti e l’intelaiatura dell’Ordine, e che forse il reverendo e massone A.F.A. Woodford rinviene tra le carte del defunto occultista Frederick Hockley (ma esistono altre versioni). In ogni caso si tratta di una sessantina di fogli incomprensibili: e alla decrittazione (1887) provvede il dottor William Wynn Westcott, coroner nel Nord-Est di Londra nonché antiquario e filologo, studioso di occultismo e traduttore del Sepher Yetzirah e degli Oracoli Caldei. Quel che emerge dai fogli fa intuire il colpo grosso, per cui il bravo coroner si affretta a coinvolgere due amici, massoni come lui: cioè il proprio mentore in cose esoteriche William Robert Woodman (a sua volta medico e studioso di Cabala, antichità egizie e gnosticismo, filosofia e astrologia, alchimia e Tarocchi, e per sovrapprezzo Mago Supremo della Societas Rosicruciana in Anglia alla morte del fondatore Robert Wentworth Little) e il più promettente dei propri discepoli, appunto Mathers.

Il fatto è che il manoscritto si è rivelato la schematica traccia, in inglese, di cinque misteriosi rituali rosicruciani; e ad accompagnarli, su un foglio a parte pure in cifra, ci sarebbero credenziali e indirizzo di tale Fräulein Sprengel di Norimberga, Rosacroce di grado elevato nel gruppo Die Goldene Dammerung come Soror Sapiens Dominabitur Astris. Ma qui, direbbe il Poeta, casca l’asino: perché se i rituali sono probabilmente veri, grossi dubbi sussistono sulla presunta adepta tedesca, o almeno sulla corrispondenza che Westcott afferma a quel punto di instaurare con lei — ricevendo per sé e i compagni inestimabili insegnamenti ermetici, il grado onorario di Adeptus Exemptus e soprattutto l’autorità di creare in Inghilterra un’organizzazione occulta semipubblica, in cui operare con un elaborato cerimoniale magico. Secondo i malevoli, a confezionare la corrispondenza sarebbe invece il solo Westcott, bisognoso di un documento di legittimazione e successione gerarchica da qualche fonte autorevole per tirar su l’organizzazione dei suoi sogni: una specie di pia frode, insomma, per attrarre un maggior numero possibile di confratelli in studi magici. In fondo il meccanismo del documento ritrovato non risulta nuovo: già vent’anni prima la Societas Rosicruciana in Anglia era sorta in seguito alla scoperta, da parte di Robert Wentworth Little, di alcuni antichi manoscritti nella Freemasons’ Hall. Sia vera o meno, la storia riecheggia le voci sui fantomatici ritrovamenti templari a Gerusalemme e altre infinite cacce al tesoro a talismani di fondazione, indefinitamente ricamate e più o meno sospette.
Sia come sia, dalla scatenata fantasia di questi tre uomini nasce nel 1887 The Hermetic Order of the Golden Dawn, il cui tempio di Iside-Urania viene aperto a Londra l’anno successivo, presto seguito da altre fondazioni.
 Ancora Parigi, maggio 1900. Vestigia guardò dalla finestra il cielo ormai buio. Il temporale non riusciva a scatenarsi e montava sempre più, liberando ora un barbaglio livido tra nubi crestate, guglie e tetti, ora un tuono in sordina. Una tensione che saturava lo spazio sublunare d’inquietudini e fremiti elettrici.
Ancora Parigi, maggio 1900. Vestigia guardò dalla finestra il cielo ormai buio. Il temporale non riusciva a scatenarsi e montava sempre più, liberando ora un barbaglio livido tra nubi crestate, guglie e tetti, ora un tuono in sordina. Una tensione che saturava lo spazio sublunare d’inquietudini e fremiti elettrici.
I due confratelli venuti dal Messico, Vestigia rammentava, sarebbero restati fuori per la serata; quanto al prode Plenipotenziario, stava probabilmente preparando i bagagli. Nessuno insomma per qualche ora avrebbe suonato all’appartamento. Tormentandosi le mani, tornò a pensare quanto fossero lontani i primi tempi di quell’avventura: la possibilità di sfiorare i Mondi Altri o addirittura di pellegrinarvi in estasi, godendone le gioie e i poteri… Alla luce bassa del gas alla spalle, l’immagine della donna nel vetro strappava un sembiante spettrale — come quella, non poté impedirsi di pensare, di certi pericolosi sortilegi con gli specchi. E in effetti tutta la casa pareva impregnata dei brontolii vaghi oltre la porta chiusa della cappella, appena spezzati da saltuarie invocazioni per sprofondare all’improvviso in tesi silenzi.
Vestigia sapeva cosa il marito stesse celebrando, e avvertiva una spiacevole consonanza tra l’accumulo sornione di nubi nel cielo e quella porta chiusa, via via vibrante di suoni gutturali. Sapeva chi il marito stesse chiamando, e per quali scopi, e quale rancore assoluto lo animasse; e perché avesse preferito non esporla ai rischi del rituale, rifiutando la sua assistenza ministeriale. Un rito, in realtà, dall’avvio grottesco come le immagini dei grimori che Deo Duce Comite Ferro andava traducendo, glifi bizzarri a suggerire poteri incongrui, arabeschi e ritratti di dominazioni schizoidi e anche per questo temibili.  Nello spazio chiuso del tempio il mago aveva pazientemente battezzato i piselli secchi della dispensa coi nomi magici di ciascuno degli adepti ribelli: e ora, grazie alle formule della Grande Tabella degli Spiriti Enochiani, stava evocando le forze dei Principi Immondi, probabilmente Belzebù l’Arconte Tafano e il Fratricida Tifone-Set. Avrebbe poi scosso i piselli in un setaccio, convocando i demoni contro gli sciagurati ex-confratelli perché li disperdessero tra discordie e avversità: e poco si curava, pensò Vestigia angustiata, dello sfinimento di anima e corpo che un simile commercio avrebbe per lui stesso inevitabilmente comportato.
Nello spazio chiuso del tempio il mago aveva pazientemente battezzato i piselli secchi della dispensa coi nomi magici di ciascuno degli adepti ribelli: e ora, grazie alle formule della Grande Tabella degli Spiriti Enochiani, stava evocando le forze dei Principi Immondi, probabilmente Belzebù l’Arconte Tafano e il Fratricida Tifone-Set. Avrebbe poi scosso i piselli in un setaccio, convocando i demoni contro gli sciagurati ex-confratelli perché li disperdessero tra discordie e avversità: e poco si curava, pensò Vestigia angustiata, dello sfinimento di anima e corpo che un simile commercio avrebbe per lui stesso inevitabilmente comportato.
Nonostante la scienza magica conseguita, o forse proprio per quella, la Protoadepta finì col trasalire quando, nell’eco bassa dei nomi barbari a blandire i troni degli Arconti, parve di avvertire nell’aria un vago odore acre e dolciastro, come di feci miste a sangue…
Moina poteva ben pensare con nostalgia ai primi tempi di quell’avventura, con la partnership dei tre maghi — o impostori che fossero — e gli anni di entusiastiche ricerche nell’occulto. Con la sua barba da patriarca biblico e un’intera corazza di regalia massonici, il dottor Woodman (Frater Vincit Omnia Veritas) era stato il primo a raggiungere l’Oriente Eterno nel 1891. A sua volta, Westcott (Frater Sapere Aude) nel ’96 si era defilato: il malaugurato ritrovamento di certi documenti in una carrozza aveva causato un cazziatone del Ministro, e l’aut-aut tra Golden Dawn e ufficio pubblico. Per di più nel corso del caso Taxil il coroner veniva additato quale eminenza grigia satanista — e in seguito le accuse di falsificazione del carteggio Spregel e le blande giustificazioni addotte dal Nostro non gioveranno alla sua fama (che per inciso nelle foto in circolazione ha sempre un’aria un po’ triste). A reggere l’Ordine era insomma rimasto Mathers: e questa è la situazione al momento della rivolta.
Ma certo, se ci liberiamo dalla impressioni che potevano ristagnare nell’appartamento di Rue Saint Vincent, quel rotolare di piselli appare piuttosto comico. Tanto più che non c’era bisogno di disturbare i demoni: la compagine sociale era abbastanza litigiosa da rovinarsi da sola, e i cocci magici dell’Alba Dorata — fraternità e templi in continue polemiche, riavvicinamenti e crisi — presto riempirono l’Impero.
 Di tali storie poteva ben sapere qualcosa Bram Stoker, che pur non essendo affiliato all’Ordine vi vantava vari amici: anche se pubblicando nel 1910 il saggio Famous Impostors — meritevolmente proposto nel 2009 in traduzione italiana (Doppie identità. I più famosi impostori della storia) per i tipi Robin — si guarda bene dal citare nomi del giro. Dopo aver narrato la storia virtuale — le gesta del Grande Impostore Dracula, un altro anticristo che cambia identità come abiti, e tenta d’iniettare la propria infezione a Londra — Stoker passa a quella reale: e scopre che gli esempi si sprecano. Dai tribus impostoribus del paradigma macheniano si passa così a una ben più vasta tribù degli impostori, una storia universale dell’infamia — a dirla con Borges — che corre attraverso i secoli. Tra le pagine di Stoker troviamo così pretendenti al trono e figure dell’occulto, l’Ebreo Errante, il finanziere John Law, il truffatore Arthur Orton; troviamo donne che si spacciano per uomini, ma anche il diplomatico-spia Cavaliere d’Eon dai presunti, leggendari travestimenti muliebri; e troviamo una certa varietà di altri inganni, burle e strane storie.
Di tali storie poteva ben sapere qualcosa Bram Stoker, che pur non essendo affiliato all’Ordine vi vantava vari amici: anche se pubblicando nel 1910 il saggio Famous Impostors — meritevolmente proposto nel 2009 in traduzione italiana (Doppie identità. I più famosi impostori della storia) per i tipi Robin — si guarda bene dal citare nomi del giro. Dopo aver narrato la storia virtuale — le gesta del Grande Impostore Dracula, un altro anticristo che cambia identità come abiti, e tenta d’iniettare la propria infezione a Londra — Stoker passa a quella reale: e scopre che gli esempi si sprecano. Dai tribus impostoribus del paradigma macheniano si passa così a una ben più vasta tribù degli impostori, una storia universale dell’infamia — a dirla con Borges — che corre attraverso i secoli. Tra le pagine di Stoker troviamo così pretendenti al trono e figure dell’occulto, l’Ebreo Errante, il finanziere John Law, il truffatore Arthur Orton; troviamo donne che si spacciano per uomini, ma anche il diplomatico-spia Cavaliere d’Eon dai presunti, leggendari travestimenti muliebri; e troviamo una certa varietà di altri inganni, burle e strane storie. 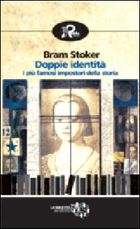 Compresa quella un po’ delicata del fantomatico Ragazzo di Bisley in cui si identificherebbe nientemeno che Elisabetta I — un’ipotesi, in fondo, un tantino provocatoria (almeno nell’Inghilterra vittoriana ed edoardiana) verso una delle icone nazionali e monarchiche più venerate. Ma è la verità, spiega sornione Stoker, che impone di ribellarsi al Male dell’impostura; e poco importa se ad avvincerci nella lettura è poi soprattutto la sua scintillante abilità affabulatoria. Che anzi dai profili repertoriati finisce col ricondurre indirettamente a schiere d’altri personaggi, anche più recenti e discutibili: quelli per esempio che tra istituzioni malate — acquisti di voti, luridi interessi gabellati per pubblico bene, dissenso criminalizzato, strumentalizzazioni mediatiche, nomine spalancate da firme false — sentiamo pontificare tutti i giorni dalle cattedre di politica, economia e finanza. O quelli che, dopo averli finalmente rottamati (perché la storia va avanti, non foss’altro per senescenza anagrafica, e prima o poi i vecchi leader crollano), reazionari o presunti progressisti, ne prenderanno il posto con simili maschere, con analoga impostura.
Compresa quella un po’ delicata del fantomatico Ragazzo di Bisley in cui si identificherebbe nientemeno che Elisabetta I — un’ipotesi, in fondo, un tantino provocatoria (almeno nell’Inghilterra vittoriana ed edoardiana) verso una delle icone nazionali e monarchiche più venerate. Ma è la verità, spiega sornione Stoker, che impone di ribellarsi al Male dell’impostura; e poco importa se ad avvincerci nella lettura è poi soprattutto la sua scintillante abilità affabulatoria. Che anzi dai profili repertoriati finisce col ricondurre indirettamente a schiere d’altri personaggi, anche più recenti e discutibili: quelli per esempio che tra istituzioni malate — acquisti di voti, luridi interessi gabellati per pubblico bene, dissenso criminalizzato, strumentalizzazioni mediatiche, nomine spalancate da firme false — sentiamo pontificare tutti i giorni dalle cattedre di politica, economia e finanza. O quelli che, dopo averli finalmente rottamati (perché la storia va avanti, non foss’altro per senescenza anagrafica, e prima o poi i vecchi leader crollano), reazionari o presunti progressisti, ne prenderanno il posto con simili maschere, con analoga impostura.



