di Marilù Oliva
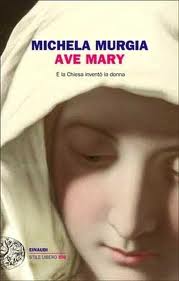 Ave Mary. E la chiesa inventò la donna di Michela Murgia, Einaudi Stile Libero Big, Torino 2011, pp. 166, € 16,00.
Ave Mary. E la chiesa inventò la donna di Michela Murgia, Einaudi Stile Libero Big, Torino 2011, pp. 166, € 16,00.
Per parlare di questo libro vorrei partire dal titolo, Ave Mary, binomio in parte vocativo, in parte nominale che riassume nell’accostamento — saluto latino e religioso + nome inglese/izzato — una serie di connotazioni che si amplieranno. Prima tra tutti l’agilità di scorrere, nelle pagine, da un riferimento sempiterno e apparentemente statico, la Madonna, alla donna archetipica, Eva, fino a quella terrena di oggi e dei secoli, la donna che si trasforma, che si rimbocca le maniche, la Mater ma anche la madre mancata e la donna che fa i conti con la quotidianità, come la stessa autrice ha chiarito in quarta di copertina: «Dovevo fare i conti con Maria, anche se questo non è un libro sulla Madonna. È un libro su di me, su mia madre, sulle mie amiche e le loro figlie, sulla mia panettiera, la mia maestra e la mia postina. Su tutte le donne che conosco e riconosco».
Mary è la Vergine non in quanto “stampino perfetto di tutte le donnine per bene”, Mary siamo tutte noi, stigmatizzate da una deformazione che non è semplicemente indotta da un antico — e in parte persistente — maschilismo, ma è tanto più sottile da infiltrarsi perfino nell’immaginario della morte, la cui riproduzione artistica è sempre stata negata a Maria, pur con le dovute eccezioni. E tra queste, una delle più sorprendenti è la Morte della Vergine di un impavido Caravaggio, che subito si vide infatti rifiutata l’opera dai frati committenti. Se da un lato le raffigurazioni iconografiche celano il memento mori mariano, dall’altro traboccano di rappresentazioni del suo dolore umano, un dolore che non è mai personale ma, derivando dalla crocifissione di Cristo, si fa «traslato, eco e conseguenza di quello del figlio», ovvero non si concentra sul tormento della madre ma massimizza l’effetto della morte di Gesù.
Dalla sofferenza si passa a trattare diversi significativi temi specifici del femminile, quali il senso di colpa istillato dalla consapevolezza dell’errore provocato dalla madre primigenia: il dislivello tra il credente e il debito dovuto è inaccessibile, assunto che si spiega e si sviluppa nelle pagg. 45-49: «uno degli aspetti psicologicamente più interessanti della dottrina del peccato originale è implicare uno stato di mancanza permanente e incolmabile: non essendo stato commesso dalla persona a cui viene imputato è l’unico peccato che non può essere confessato né perdonato in maniera individuale. La macchia di Eva è cronica, inscritta nel nostro Dna e si contrae con la nascita in modo incancellabile: basta tirare il primo fiato e davanti a Dio si è già perduti».
Nel titolo è anticipata anche l’ironia, la non-pesantezza con cui vengono trattate questioni importanti e non certo di appannaggio solo sacro. La competenza della scrittrice non è data tanto dai numerosi e pregiati riconoscimenti precedenti — il suo romanzo Accabadora ha vinto il Campiello, il SuperMondello e il Dessì, dando lustro alla natìa e cara Sardegna — ma dagli studi teologici compiuti (ai quali aggiungo che è socia onoraria del Coordinamento teologhe italiane) e soprattutto da un metodo che conferisce al testo un’impronta saggistica e scientifica: vengono espresse tesi e vengono sostenute da un’impalcatura di argomentazioni logiche, citazionistiche e documentali.
Interessante il rimando costante alle Sacre Scritture come punto di partenza (e di ricongiungimento) di un ragionamento che punta a riaffermare l’imago Virginis in tutta la sua centralità, dignità, dinamicità, totalità di esistenza, dai momenti più pregnanti — il sì dell’annunciazione serba una portata sovversiva celata dall’interpretazione tradizionale del docile assenso — fino al decesso.
Interessante (in negativo) il contributo di Suor Teresa di Calcutta, promotrice del già espresso concetto secondo il quale «il mestiere femminile nell’economia strutturale della Chiesa fosse fare l’angelo del focolare». E si scopre così che la suora albanese si inserì nella questione del ruolo della donna senza una discussione critica alla lettera apostolica Mulieris Dignitatem di Giovanni Paolo II, anzi ne appoggiò la subordinazione gerarchica.
Interessante anche la figura femminile scolpita paragrafo dopo paragrafo, parabola dopo stralcio autobiografico, dall’iconografia bizantina ai riti popolari, dalla pop music alla santità, al calvario, fino alla lotta quotidiana. Ma più interessante ancora la donna che potrebbe scaturirne, come dalle parole stesse della scrittrice di Cabras: «Il processo di riappropriazione della propria complessità per le donne deve passare attraverso la costruzione di un sano immaginario del limite. È una questione di sopravvivenza, e non solo in rapporto a se stesse, perché la donna rappresentata da Maria offre anche all’uomo un modello inaccessibile e frustrante con cui rapportarsi. Impossibile da possedere, intangibile al tempo e alla sua consunzione, la donna-santuario resta un mistero davanti al quale o ci si inginocchia o si bestemmia».



