di Marilù Oliva
“Bacchiglione Blues”, Matteo Righetto, Perdisa Pop, 2011
 Non si può recensire un libro di Matteo Righetto — padovano classe ’72, insegnante di lettere, autore teatrale e scrittore al suo secondo romanzo, dopo Savana Padana (Ed. Zona) — senza spendere due paroline su Sugarpulp, il movimento letterario da lui fondato (insieme a Matteo Strukul), basato su pochi ma intensi elementi: la territorialità, l’apertura critica a 360 gradi, lo sguardo non catalizzato su un punto fisso, ma che sconfina nell’internazionalità, con particolare attenzione ad autori come Cormac McCarthy, Joe Lansdale, Victor Gischler.
Non si può recensire un libro di Matteo Righetto — padovano classe ’72, insegnante di lettere, autore teatrale e scrittore al suo secondo romanzo, dopo Savana Padana (Ed. Zona) — senza spendere due paroline su Sugarpulp, il movimento letterario da lui fondato (insieme a Matteo Strukul), basato su pochi ma intensi elementi: la territorialità, l’apertura critica a 360 gradi, lo sguardo non catalizzato su un punto fisso, ma che sconfina nell’internazionalità, con particolare attenzione ad autori come Cormac McCarthy, Joe Lansdale, Victor Gischler.
Niente astrattismi vuoti né solipsismi: Sugarpulp, come recita la dichiarazione d’intenti, «affonda le proprie radici nella natura fiera e selvaggia del Nordest, è la polpa narrativa, adulterata con lo zucchero di barbabietola, con una gradazione saccarometrica crescente che rende lo scrivere più alcoolico, più tossico, più anfetaminico…
…Sugarpulp è narrazione a duecento all’ora, è scrittura montata in modo ipercinetico, è un modo di scrivere che mescola il linguaggio cinematografico della sceneggiatura con i profumi di sangue e zucchero della Bassa, dei campi di mais, delle case coloniche, le osterie…».
Chiarito questo preambolo, si può leggere “Bacchiglione Blues” di Matteo Righetto, ultima uscita per la collana “I corsari” di Perdisa Pop, come un omaggio al movimento da lui creato, perché ne propone tutti gli ingredienti e lo fa in tono ironico-grottesco — ma senza tralasciare importanti spunti di riflessione anche in chiave sociologica—, da vero precursore di un rinnovato sabroso genere di polenta-western: siamo in quella Bassa provincia patavina che tanto assomiglia alla Louisiana occidentale, non ci sono mandrie né sceriffi ma barbabietole a gogo e tre delinquenti scalcagnati, Tito, Ivo e Toni, magistralmente rappresentati nei loro difetti e nelle loro miserie. Organizzano alla meno peggio il sequestro della moglie di un grande industriale dello zucchero: la rapiscono, chiedono il riscatto e, in attesa di riscuoterlo, la tengono rinchiusa nel loro rifugio cadente, specchio disadorno della loro pochezza umana. I luoghi, sfondo alle imprese pochi eroiche e ai dialoghi demenziali dei tre tipacci, alle loro flatulenze, alle grasse e fritte mangiate, alla matta bestialità, sono uno scorcio filmico che il lettore prenderà il vizio d’immaginarsi: «Percorsero ancora varie stradine immerse tra una moltitudine di topinambur in fiore e i vigneti di friularo e di barbera vendemmiati da qualche settimana. Poi finalmente, dopo molti scossoni, giunsero fin quasi ai piedi dei Colli Euganei, oltre gli ultimi filari di vigne. […] Il covo si trovava a venti passi dalle sponde del Bacchiglione, presso una sorta di baracca lontana dal mondo abitato e totalmente nascosta da vari alberi di alto fusto, per lo più pioppi neri, noci e castagni che stavano già ingiallendo d’autunno».
Questo romanzo è una pastiche di piombo e nebbie, vino rosso e devianze, momenti spassosi ed epica dissacratoria alla Pulp Fiction nostrana: l’imprevedibile s’intrufola dall’inizio alla fine, perché ce n’è per tutti. Crimine, territorio, stranieri, vecchiette, e tante, tantissime barbabietole da zucchero, mentre il Bacchiglione sbircia dalle sue acque e, ci scommetto, strizza pure l’occhiolino.
“Mia madre è un fiume”, di Donatella Di Pietrantonio, Elliot, 2011
 “Mia madre è un fiume”, di Donatella Di Pietrantonio, dentista che vive a Penne, in provincia di Pescara, è un romanzo d’esordio anche se ha avuto come preludio altre forme narrative: l’autrice scrive da sempre racconti, fiabe e poesie. La storia è intimistica e corale allo stesso tempo e si dilata, con una spontaneità poetica, dall’individuale all’universale, dalla cellula familiare alla grande Storia novecentesca.
“Mia madre è un fiume”, di Donatella Di Pietrantonio, dentista che vive a Penne, in provincia di Pescara, è un romanzo d’esordio anche se ha avuto come preludio altre forme narrative: l’autrice scrive da sempre racconti, fiabe e poesie. La storia è intimistica e corale allo stesso tempo e si dilata, con una spontaneità poetica, dall’individuale all’universale, dalla cellula familiare alla grande Storia novecentesca.
Una figlia e una madre, due vite alternate tra il presente dei gesti quotidiani e il passato del ricordo, una prima persona e poi un “tu” fatto d’amore che coinvolge il lettore e lo catapulta dal nunc al tempo che fu. La madre è ora malata — atrofia cerebrale: il nulla che avanza — e la figlia, voce narrante, si occupa di lei con l’amorevolezza materna e l’abnegazione che, al contrario, da lei non ha mai ricevuto.
I conti tra le due sono ancora aperti, la figlia l’aveva inseguita e lei le era sempre sfuggita, ora ne è consapevole attraverso la rassegnazione contratta, sublimata in dedizione: «Tutta la vita l’ho cercata, accattona che non sono altro. Ancora la cerco. Non la trovo. La cerco. Madre dolorosa».
Dagli anni Quaranta ai nostri giorni, il rapporto viene raccontato attraverso le radici che lo precedettero, l’albero genealogico e i suoi peccati originali, tutti consumati in una terra — quella d’Abruzzo — impervia, mitica, remota, dove i contadini “cacciavano le pietre” dai campi, là dove si poggiavano i pezzetti sgretolati, rotolati giù dalle montagne porose. Una terra impervia ma non esente da magia, perché potevano comparire all’improvviso, pur nel pieno del loro realismo, le creature delle favole: «Quando la neve lo affamava, il lupo abruzzese usciva dal bosco per avvicinarsi alla casa, di notte, una sagoma scura e guardinga sul grande prato di luce. Lo vedevi dalla finestra, l’ululato ti aveva tolto il sonno. Ti assalivano brividi di freddo e dell’antica paura umana. Poi l’animale scompariva dal vetro appannato del tuo stupore e scappavi a letto, al calduccio di una sorella».
Per addentrarci più nel valore dei luoghi del romanzo ripropongo le parole di Loretta Santini, direttrice editoriale della casa editrice Elliot: «Ho trovato bellissimo il ritratto di un paese costruito su una ruralità quasi primitiva, in cui la sopravvivenza fisica aveva la priorità, mentre gli affetti, le relazioni all’interno della famiglia si basavano su una ruvidezza fatta di pochi gesti e poche parole». Quest’essenzialità è riproposta da Donatella Di Pietrantonio nella lingua: una sintassi sostanziale, a tratti sintagmatica, che investe di un lirismo antico ma universalmente condivisibile ogni frazione di vita narrata e ogni singolo momento di lettura.
Settanta acrilico trenta lana,Viola Di Grado, edizioni e/o, 2011
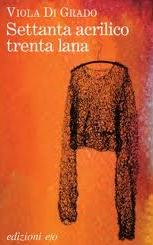 Altra esordiente interessante è la ventitreenne Viola Di Grado, nata a Catania, laureata in lingue orientali. Il suo romanzo ha un titolo di tessuto e viene ricamato con la maestria di un autore rodato: la giovane Camelia vive a Leeds, una città del Regno Unito, capoluogo dell’omonimo distretto metropolitano ubicato nella regione dello Yorkshire e Humber. Qui regna un inverno in grado di spodestare anche i primi timidi accenni di primavera e qui la stagione del meteo si sovrappone a quella metaforica che gela Livia, madre di Camelia, e, di riflesso, anche Camelia stessa, protagonista e voce narrante del romanzo. Un improvviso lutto in famiglia stravolge la scansione temporale e la comunicazione verso l’interno e verso il mondo esterno: è proprio la comunicazione — o la sua distorsione — il filo conduttore di queste incredibili pagine in cui le parole smarriscono la loro via d’uscita dalla bocca per ritrovarla negli occhi. Camelia e la madre si parlano e si sgridano con un alfabeto fatto di sguardi ma, per contrasto, la ragazza sopravvive aggrappandosi disperatamente proprio all’universo dei lessemi. E lo fa in vari modi: col suo lavoro di traduttrice, o giocando con le singole lettere o incaponendosi d’imparare — e ci riuscirà — gli ideogrammi cinesi. Proprio la nuova lingua, complicata, fatta di ideogrammi e di chiavi interpretative, sarà galeotto di un amore per nulla scontato.
Altra esordiente interessante è la ventitreenne Viola Di Grado, nata a Catania, laureata in lingue orientali. Il suo romanzo ha un titolo di tessuto e viene ricamato con la maestria di un autore rodato: la giovane Camelia vive a Leeds, una città del Regno Unito, capoluogo dell’omonimo distretto metropolitano ubicato nella regione dello Yorkshire e Humber. Qui regna un inverno in grado di spodestare anche i primi timidi accenni di primavera e qui la stagione del meteo si sovrappone a quella metaforica che gela Livia, madre di Camelia, e, di riflesso, anche Camelia stessa, protagonista e voce narrante del romanzo. Un improvviso lutto in famiglia stravolge la scansione temporale e la comunicazione verso l’interno e verso il mondo esterno: è proprio la comunicazione — o la sua distorsione — il filo conduttore di queste incredibili pagine in cui le parole smarriscono la loro via d’uscita dalla bocca per ritrovarla negli occhi. Camelia e la madre si parlano e si sgridano con un alfabeto fatto di sguardi ma, per contrasto, la ragazza sopravvive aggrappandosi disperatamente proprio all’universo dei lessemi. E lo fa in vari modi: col suo lavoro di traduttrice, o giocando con le singole lettere o incaponendosi d’imparare — e ci riuscirà — gli ideogrammi cinesi. Proprio la nuova lingua, complicata, fatta di ideogrammi e di chiavi interpretative, sarà galeotto di un amore per nulla scontato.
Oltre alla comunicazione verbale, l’alterazione contamina anche le altre dimensioni: i vestiti non sono cuciti ma tagliati, i cibi non vengono mangiati ma vomitati, il genitore non si occupa del figlio ma viceversa, l’amore si traveste da insegnamento e la fisicità si corona solo attraverso un desiderio obliquo.
Il romanzo scorre intenso, polposo, ciò che stupisce è la padronanza stilistica di Viola Di Grado. La sua è una lingua fatta di immagini, sensazioni, evocazioni, una lingua che, come recita la seconda di copertina, riesce a mantenere intatta la forza poetica senza rinunciare alla storia.
E chiudendo coi i luoghi, ecco un assaggio della fredda città dove vive Camelia, la città dove l’inverno è cominciato da così tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cose c’era prima: «Leeds è come quei padroni che sventolano sadicamente un pezzo di carne davanti al cane e poi se lo mangiano, quando esci vedi quel sole appeso al cielo e diventi più felice. Pensi “Forse la neve finirà”, chiudi gli occhi per sentirli scaldare, invece il sole se n’è già andato, lasciando il cielo opaco e bianchiccio come una coscia di pollo».



