di Andrea Ponso
 Il “blocco Artaud” ci permette di entrare nel vivo di una crisi, una crisi di pensiero e di rappresentazione, con un movimento che non può non chiamare in causa il rapporto con il mondo e con il reale, la lucidità e le mille trappole del letterario: tutto il suo lavoro è un vero e proprio corpo a corpo con il sistema delle conoscenze occidentali e non solo, con la religione (certo Artaud non era un ateo: un ateo non lotta così a lungo con Dio) e con le varie suddivisioni dei saperi. Partendo dalla tematica principale attorno alla quale si raccolgono questi scritti (
Il “blocco Artaud” ci permette di entrare nel vivo di una crisi, una crisi di pensiero e di rappresentazione, con un movimento che non può non chiamare in causa il rapporto con il mondo e con il reale, la lucidità e le mille trappole del letterario: tutto il suo lavoro è un vero e proprio corpo a corpo con il sistema delle conoscenze occidentali e non solo, con la religione (certo Artaud non era un ateo: un ateo non lotta così a lungo con Dio) e con le varie suddivisioni dei saperi. Partendo dalla tematica principale attorno alla quale si raccolgono questi scritti (![]() Sul suicidio e altre prose, Via del vento, 4 euro) cercheremo di dimostrare, entrando nel vivo di questi brevi ma veramente preziosissimi testi, le frizioni che la macchina da pensiero produce a contatto con la mobilità e il corpo del nostro autore.
Sul suicidio e altre prose, Via del vento, 4 euro) cercheremo di dimostrare, entrando nel vivo di questi brevi ma veramente preziosissimi testi, le frizioni che la macchina da pensiero produce a contatto con la mobilità e il corpo del nostro autore.
La morte è vista da Artaud come un eterno presente:
“… il sentimento dell’uniformità di ogni cosa. Un assoluto magnifico. Avevo senza dubbio appreso ad avvicinarmi alla morte…”
In realtà, la morte è quindi in sé l’abolizione della differenza, dello smembramento (ricordiamo l’invenzione artaudiana del corpo senza organi) ma, tramite il suicidio, non si può raggiungere che attraverso un atto di smembramento, di distacco, di rottura di una uniformità, che ci rende prigionieri ancora una volta del pensiero che lo ha pensato, dividendo e preparando, tra l’altro, l’infiltrazione del divino e di ogni trascendenza che, insinuandosi, crea continuamente il due, la divisione, il “non”, rubandoci il dolore-essere in cambio di una rappresentazione, espropriandoci, eternizzandoci:
“il suicidio non è che la conquista favolosa e lontana degli uomini che pensano bene.”
Non una preclusione morale quindi, bensì una impossibilità: il non poter risolvere l’organicità e la differenza con una ulteriore divisione-differenza; non ci sono vie di fuga per il rigore di Artaud e per un pensiero che pensa l’unità di un corpo senza organi da una prospettiva (ma anche qui, di nuovo, ogni prospettiva è una parzialità) che esclude risolutamente ogni metafisica.
In realtà, è da sempre troppo tardi:
“non sento l’appetito della morte, sento l’appetito del non essere, di non essere mai caduto in questo trastullo d’imbecillità, di abdicazioni, di rinunce e di ottusi incontri che rappresenta l’io di Antonin Artaud”
; nonostante ciò, Artaud si rende conto che in questa insofferenza si nasconde la tentazione della trascendenza: 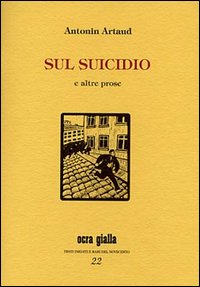 è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).
è in fondo la stessa visione di certo cristianesimo (e non solo) che svaluta la terra e propone prospettive salvifiche future (è lo stesso meccanismo che nella testualità promette un senso a venire e nello stesso momento instaura e salva una oscurità strategica?).
Allora Artaud tronca ogni possibile via di fuga e nello stesso tempo accetta i mille rivoli che smembrano ogni uomo, poiché neanche il corpo senza organi deve essere visto in prospettiva, ma anche (rompendo l’ordine della logica, come succede sempre nei punti di maggiore tensione della scrittura artaudiana) non può che essere visto così: è un In — stante per chi sceglie di rimanere nel cortocircuito, nel punto in cui ogni rappresentazione persiste e non smette di crollare:
“questo io virtuale, impossibile, che si trova tuttavia nella realtà.”
Tutta la speculazione di questo autore, il suo continuo cortocircuitare nel pensiero che lo pensa, non è altro che una lotta sul posto, contro il “pensare ciò che mi vogliono far pensare” (del resto, lo ricorda lui stesso nel suo Van Gogh “mi si è suicidato”), infatti ci si sente
“fin nelle ramificazioni più impensabili (…) irriducibilmente determinati ( … ) e il fatto che mi ucciderò è probabilmente inscritto in un ramo qualsiasi del mio albero genealogico”
(viene in mente il lavoro di liberazione dalle ‘parti’ e dal ‘modo’ del teatro di Bene).
Artaud arriva quindi alla perentorietà di questa bruciante affermazione:
“Dio mi ha collocato nella disperazione come in una costellazione di vicoli ciechi il cui irradiamento approda a me stesso. Non posso ne morire, ne vivere, ne desiderare di morire o vivere. E tutti gli uomini sono come me.”
C’è una ricerca di chiarezza in questa scrittura, davvero sconvolgente (soprattutto se pensiamo alla vita dell’uomo Artaud, ai suoi dolori, all’elettrochoc e ai vari internamenti psichiatrici) – una chiarezza che, per illuminarsi non accetta la logica e il pensiero sul mondo in vigore ma che non li accantona sbrigativamente ma li vive dal di dentro, li porta come abiti che continuamente si è costretti a togliere e a rimettere: per arrivare alla chiarezza, Artaud non vuole semplificare, bensì adattare il suo sguardo e il suo corpo alla complessità della materia e all’ordine non rappresentativo del mondo poiché
“la vita non mi appare che come un consenso all’apparente leggibilità delle cose e alla loro relazione nello spirito”
e ancora,
“la nostra attitudine all’assurdo e alla morte è quella della migliore ricettività”
, sgombrando da subito il campo da atteggiamenti di passività o maledettismo, e spostando lo sguardo verso l’attenzione e la lucidità, verso un mondo in movimento, privo d’ombra e di rifugi (soprattutto rifugi letterari, artistici: ad Artaud non basta più essere un artista, poiché l’artista è diventato un uomo della consolazione o della rassegnazione infinita; poiché l’artista è anch’esso determinato e inserito nella casella che la divisione aristotelica dei saperi ancora gli impone ).
Insomma, si tratta di scegliere la lucidità, il proprio dolore, la propria pulizia anche (e si badi bene: tutto ciò non presuppone l’accantonamento di quel “trastullo d’imbecillità, di abdicazioni (…) che rappresenta l’io di Antonin Artaud” e, aggiungiamo noi, di tutta l’armatura del nostro occidente …) oppure di rimanere passivi all’esproprio del nostro essere ( del nostro dolore senza motivo) in cambio di una rappresentazione che non è il mondo e che si frappone tra noi e il nostro oggetto.
E a questo proposito, fatte naturalmente le dovute proporzioni, verrebbe forse da pensare agli immensi depositi di larve umane del film Matrix, derubate e risucchiate della propria energia, della propria vita vera (ha senso usare questo aggettivo?), sezionate e aperte da fori, in cambio di una vita che è rappresentazione e spettacolo. E tuttavia questa sorte, che tocca ai poveri umani del film, ricade anche, aldilà della finzione, su ogni singolo spettatore, sommerso da un numero imprecisato di effetti speciali: insomma, sono gli stessi cattivi di Matrix a creare il film, Matrix è il programma e il film stesso.
Il lavoro di Artaud ingloba le dicotomie e le aporie del pensiero senza parificarle, non procede per disgiunzioni ed esclusioni, non sostituisce alla prepotenza della materia un sistema simbolico convenzionale : in questo suo vagabondaggio eversivo, non poteva non approdare ai bordi, alle valvole di sicurezza che il sistema stesso ha ideato, quindi alla medicina e in particolare alla psichiatria — anche qui Artaud soccombe e vince:
“Ecco psichiatri (…) radunatevi attorno a questo corpo (…) è intossicato, vi dico, e si attiene alle vostre inversioni di barriere, ai vostri vuoti fantasmi (…) tu hai vinto, psichiatria, hai vinto ed egli ti oltrepassa”
ed è proprio quel “ed” che mette in crisi il tutto
Sotto l’insopprimibile ombra del dover essere, dietro alla parte determinata, dietro ai modi che ci perseguitano e ci salvano
“in fondo dunque a questo verbalismo tossico, c’è lo spasmo fluttuante di un corpo libero e che riguadagna le sue origini, la muraglia di morte essendo chiara, essendo capovolta e rasente il terreno. Poiché è qui che la morte procede, attraverso il filo di un’angoscia che il corpo non può finire di attraversare.”



