di Dziga Cacace
 305 – Essere John Malkovich del farlocco Spike Jonze, USA 1999
305 – Essere John Malkovich del farlocco Spike Jonze, USA 1999
Ci sono film che sono delle cagate. E questa è verde, sciolta e mefitica. Io non volevo andarci al cinema, sentivo delle chiare bad vibrations e avevo fortissimi dubbi su quanto di buono di questo film m’avevano detto Pier Paolo ed Elena. Barbara mi convince e smetto il lutto cinematografico: approfittiamo della Milano senza macchine e andiamo al cinema Ariosto. La città sembra 1997 Fuga da New York e tutte le auto, posteggiate e silenti – al posto di intasare le strade -, sono inquietanti. Vediamo il film, mi scompongo e quanto segue è un’invettiva vecchio stampo, quando ancora sapevo indignarmi se mi sentivo preso per il culo da un mestierante.
Se c’è una cosa che mi fa incazzare come una belva è cacciare nel cesso un’ottima intuizione: Essere John Malkovich è un film che spreca un’idea geniale e che irrita per l’approssimazione e per la presunzione con cui si sprecano tutte le implicazioni che ne potrebbero nascere. Craig (Cusack) è un burattinaio che, pur di lavorare, diventa archivista in un misterioso ufficio che si trova al settimo piano e mezzo di un palazzo di New York. Bella idea, okay, risolta attraverso un buon lavoro scenografico. Però la faccenda muore lì. E vabbeh, praticamente una gag visiva. Chiuso. Craig è sposato con Lottie (Cameron Diaz, imbruttita all’inverosimile), ma non è contento e s’invaghisce — i misteri del cinema — di Maxine (la Keener, attraente come Capezzone in giarrettiere). Casualmente scopre che nel settimo piano e mezzo di cui si diceva esiste un cunicolo che porta nella mente di John Malkovich: siamo nell’ambito delle intuizioni fantastiche, quelle che rendono il cinema il cinema, benissimo. E che accade? Nasce un quadrangolare amoroso in cui Maxine seduce Malkovich (quello vero) posseduto da Craig e Lottie a turno, ambedue innamorati di Maxine. La follia. Quale fascino dovrebbe avere ‘sta qui, non è dato saperlo e il fatto che Craig caschi come una pera cotta appena la vede o Lottie scopra la sua prepotente voglia omosessuale viene narrato come situazione data. Non c’è evoluzione o scoperta, neanche uno straccio di fottutissimo motivo, anche il più banale o stereotipato. Perché succede? Boh, quest’anno andrà di moda il gay-chic… che ne so. Ma torniamo alla trama: lo stesso Malkovich viene a sapere della cosa e prova l’esperienza di entrare in se stesso: è forse l’intuizione migliore del film, tre minuti di delirio in cui tutto è Malkovich. Per il resto, come va avanti la storia? Craig riesce a possedere Malkovich e ottiene notorietà mondiale come burattinaio, ma Maxine – ora compagna del Malkovich/Craig – è innamorata di Lottie… Finisce che Craig viene espulso dal corpo di Malkovich che torna in sé (o quasi) e Lottie e Maxine coronano il loro amore con una figlia. Un’ora e cinquanta di casino, confusione, fumi intellettualistici gestiti con la profondità di un marmista alle prese con un blocco di travertino, incoerenza narrativa e registica, attori con facce da cazzo, dialoghi pessimi. Perfino il doppiaggio è irritante. Jonze è un ottimo regista di videoclip, ma qui non regge cinque minuti cinque. La scoperta del tunnel che ci porta nella mente di Malkovich – idea clamorosa che in mano a un Gilliam ci avrebbe dato un capolavoro – avviene dopo TRENTADUE minuti in cui mi ero già trifolato le palle a morte. I personaggi sono odiosi e non c’è, nell’allucinata vicenda, un minimo di coerente credibilità ed empatia. Nel primo tempo il personaggio principale è Cusack, poi – nel secondo – lo diventa la Diaz in un bailamme narrativo che alla letargia sostituisce all’improvviso un crescendo scomposto. E tutti i simboli? La scimmia che Lottie coccola? I burattini che dipendono dalle mani di Craig? Simboli, nient’altro, cui appiccicare chissà quali significati. Non appena si supera la lunghezza canonica del clip musicale Jonze boccheggia: fatelo tornare a lavorare con Fat Boy Slim, perché qui passa solo che Jonze è un parvenu sgrammaticato, che vorrebbe ma non può. Non ho verificato, ma ritengo che il film provenga dal Sundance, supermarket della stronzata a cui abboccano i tanti babbioni che esultano per ogni presunta novità solo perché hanno visto troppo pochi film per distinguere tra sensazioni e sensazionalismi. Tiè. (Cinema Orfeo, Milano; 16/1/00)
306 – The Doom Generation del pallone gonfiato Gregg Araki, USA 1995
Concludo un week end di film bruttini se non pessimi con questa prima visione di Retequattro perché m’intriga il nitore fotografico di alcune scene che ho già visto. Due giovani adolescenti, Amy e Jordan, caricano in macchina Xavier, un novello Lucignolo che li trascina in un viaggio fatto di droghe, sesso, rapine, uccisioni e altro… Succede che Retequattro mandi in onda una versione di 57 minuti e che alcune cose di cui parla il Mereghetti scompaiano (l’FBI e la TV che inseguono i protagonisti, per esempio); e che il film si concluda con Amy che molla Jordan (ucciso da non si sa chi) per Xavier. Stop. In mezzo ammazzatine, sesso a go-gò (triangoli, perturbazioni omosessuali, perversioni etc.), conti nei fast food che sono sempre di 6 dollari e 66 centesimi, citazioni d’accatto del Lynch di Cuore selvaggio e del Tarantino di Pulp Fiction… tutto con un ritmo da nosocomio infarcito di dialoghi che dovrebbero mostrarci il vuoto morale dei protagonisti e sono invece la prova lampante della cialtronaggine dello sceneggiatore. Una bella e solenne cazzata, condita da una cifra stilistica narcisistica, iper leccata e falsa. Dei tagli di Retequattro non me ne può fregare di meno: la versione integrale non la vedrò mai, né ne sentirò la mancanza. È un’ingiustizia, lo so, ma così va il mondo e non posso farci niente. (Diretta da Retequattro; 17/1/00)
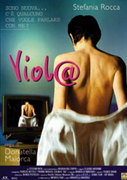 309 – Viol@ dell’imbarazzante Donatella Maiorca, Italia 1998
309 – Viol@ dell’imbarazzante Donatella Maiorca, Italia 1998
Viol@ è un film francamente sordido e ributtante, ma lo sapevo e, ciò nonostante, ho voluto vederlo: ho scientemente deciso di sottopormi a questa inquietante esperienza visiva. Marta è intervistatrice per una società di ricerche di mercato (o qualcosa del genere, poco importa). Scopre le chat-line in Internet e intraprende un dialogo privato con tale Mittler (Le affinità elettive, così, tanto per far vedere che s’è frequentato un liceo, ecco). La relazione telematica cresce, il gioco si fa pericoloso e la vita di Marta (che in Rete si firma Viola) va in merda: perde il lavoro, ha una storia di sesso con un idraulico (come mestiere, non come attributo sessuale), le muore il cane (evidente sostituto del pene — ma si può?!?), arriva quasi alla follia. Allora va a scoprire chi cacchio sia ‘sto benedetto Mittler che la perseguita. Dopo un primo pseudo colpo di scena (Mittler è una donna? Erezione dello spettatore medio maschio che si pregusta la lesbicata), zac, ecco che l’interlocutore zozzissimo di Viola altri non è che un segaiolo di 13 anni con la faccia del ritardato di Un tranquillo week-end di paura. Significato della cosa? Boh. E Marta/Viola, personaggio di un’imbecillità improponibile, dopo tanta paura si fa una risata, come se un maniaco di 13 anni fosse meno pericoloso di uno di 35: valla a capire. La trama è inattendibile per molti versi e non regge né da un punto di vista tecnologico (computer parlanti, processori con tempi di reazione infinitesimali, animazioni da George Lucas etc.) né da quello narrativo: chi è Viola? Perché si fa intrigare da questo interlocutore senza volto che le manda una fialetta col suo sperma? Perché si tromba il muratore/idraulico (dopo un tira e molla che ha del comico)? Domanda: sarà forse perché è sola? O è tutto un semplice pretesto per mettere su un film pruriginoso? A tratti pensavo: qui c’è uno spunto degno di un filmaccio soft degli anni Settanta, solo che lì non c’erano pretese registiche, menate intellettuali. E poi, questa messa in scena che più leccata e finta non si può: interni high-tech, una Roma così fredda che sembra Milano, una recitazione da spot. Nessun calore, fotografia gelida, erotismo risibile. E l’ha girato una donna che dovrebbe avere quel minimo di sensibilità per non scadere nel pecoreccio alla Brass… E vabbeh: Viol@ è una porcata. Stefania Rocca è spesso nuda (e con gli alluci valghi) e più che guardare l’intensità del volto si nota quella delle tette. Tra i comprimari c’è Rossana Mortara (Pier e io ci capiamo). Film pessimo che non riesce neanche a farmi incazzare. (Vhs da Tele+; 29/1/00)
P.s.: togliamoci due sassolini, va’. Com’è che Duel ha dedicato al film grande attenzione e interviste addirittura mesi e mesi prima che il film uscisse? Tra l’altro questa Maiorca è la regista della fiction Giornalisti, su Canale5. Per chi non l’ha vista — cioè, praticamente tutti – ricordo che è una tra le cose peggio realizzate nella storia della televisione mondiale di tutti i tempi: tecnicamente scandalosa (fotografia che sembra una vhs riversata diverse volte), abusa involontariamente di scelte Dogmatiche gestite senza raziocinio alcuno. Dopo una riga di risultati che han fatto la gioia della Rai, la messa in onda è stata sospesa.
314 – Al di là della vita – Bringing Out the Dead di uno spompo Martin Scorsese, USA 1999
Giacché sono un temerario mi avventuro solingo nel sabato sera milanese. Affronto l’attraversamento della città in macchina, diretto al cinema Splendor, esattamente agli antipodi di dove abito io. Ci metto 45 minuti d’orologio, passati accelerando e frenando o perlopiù inchiodato in coda tra centinaia di milanesi che s’insultano, martoriano il clacson, dormono in piedi, si superano da ogni lato, bestemmiano, parcheggiano in terza fila e sui marciapiedi, mentre i vigili son già tutti tornati in centrale perché c’è un casino di lavoro arretrato da compiere, sí sí. Come avrete subito capito, non sono dell’umore migliore: questa città infame ha il potere di togliermi il buonumore. Arrivo col fiatone: ho parcheggiato a due chilometri dal cinema e ho fatto una corsa disperata. Biglietto nell’entrata che puzza di pop-corn e finalmente posizionamento in sala: sono le 19.59, perfetto. Intorno a me torme di milanesi che ciancicano l’odioso granturco scoppiato, Ferrero Rocher e altre schifezze. Qualcuno deve essere imbarazzato da una bagna cauda perché arrivano fiatate agliose degne di un film di zombie. Vabbeh, cazzi miei che vado al cinema il sabato. E com’è questo Scorsese, sceneggiato da Schrader? Mah. Per me è doloroso ammettere che l’amato regista stavolta toppa un po’. Già Kundun, pur con momenti lirici altissimi, lasciava qualche dubbio; questo Al di là della vita funziona a tratti, possiede momenti sapidi, intrattiene per lunghi brani, ma non funziona nell’insieme. Il legante della vicenda, la crisi di Frank Pierce, paramedico che non salva più vite umane e che è perseguitato dal fantasma di Rose (una ragazza che non è riuscito a salvare), stenta a decollare e va avanti a strattoni. Frank, come un angelo, si prende cura della figlia di un ricoverato il cui corpo si rifiuta di morire: uccidendo l’uomo, sente di essere riuscito a dare di nuovo la pace (più che la vita) a un bisognoso, a se stesso e alla ragazza. Le assonanze con Taxi Driver sono molte. La stessa New York notturna e piovosa con un eroe solitario, un vendicatore buono o un angelo sporco, che si occupa delle anime in pena che vagano per la metropoli. Le quasi due ore del film passano tra musiche splendide (dai REM a Van Morrison, da Janis Joplin ai Clash di I’m So Bored With the USA) e scene dall’impatto visivo notevole, specialmente quando l’ambulanza di Pierce corre in aiuto di qualcuno. Come sempre è bello il montaggio della Schoonmaker e se la cavano anche gli attori (con un Nicholas Cage insolitamente misurato). Ma ripeto: è la vicenda che non piglia e il ritratto di una società che all’alba degli anni Novanta va a combattere l’Iraq ma non si cura dei suoi disperati si perde in questa scrittura un po’ confusa. Peccato. (Cinema Splendor, Milano; 12/2/00)
 321 – Toy Story 2 di John Lasseter, USA 1999
321 – Toy Story 2 di John Lasseter, USA 1999
Aspettavo questo momento dall’estate ’97, quando vidi il primo Toy Story. Il momento è giunto. Siccome Barbara è a Parigi e io mi trovo di passaggio a Genova, decido di condividere con chi mi è caro quella che ritengo sarà una visione celestiale. D’accordo con mia sorella Francesca chiamiamo Enrico che dal programma non è sconfinferato per niente, ma che alla fine accetta. Quando entriamo al cinema Universale la visione di tanti bambini in coda lo convince che lo stiamo prendendo per il culo. Non ha visto il primo episodio né Bug’s Life per cui non conosce minimamente le sensazioni straordinarie che ti può dare un film della Pixar. Gli offro il biglietto: voglio rischiare in tutto. Il film è preceduto da un corto che nell’86 lanciò Lasseter nel mondo del cinema. Enrico ridacchia: carino, vabbeh. Poi andiamo a cominciare e la prima scena del film è già genio puro. Lasciamo perdere le qualità tecniche del film (l’animazione è a livelli stratosferici e non so proprio cosa si potrà fare di meglio in futuro): quello che è incredibile sono la qualità e il ritmo della vicenda. In sala non fiata neanche un bambino, anche perché credo che non possano capire un cacchio di ciò che gli viene raccontato. Toy Story 2 ha una sceneggiatura ancora più articolata del prototipo della saga di Woody e Buzz, ha trovate ancora più divertenti, cita a più non posso e in maniera sempre intelligente, giocando con lo spettatore (vengono irrisi 2001 Odissea nello spazio, Forrest Gump, Pulp Fiction, Guerre Stellari e Jurassic Park). Insomma: è la commedia più divertente che ho visto negli ultimi anni. Non saprei come stilare una classifica ma poche, pochissime volte sono uscito dal cinema con un tale senso di appagamento senza riuscire a indicare punti deboli nel film che ho appena visto e che, forse, ci saranno pure. Ma dopo il clamoroso incipit è un susseguirsi di trovate in crescendo che culminano in un magnifico finale, reiterato senza mai annoiare. Trama: Woody è preda di un collezionista di giocattoli, ma gli amici riusciranno a scongiurare la sua partenza per un museo del Giappone. Detta così sembra facile, ma la vicenda è arricchita da tanti episodi mai scontati e ricchi di invenzioni. A un certo punto interviene una canzone e penso che sia una concessione al gusto dei bambini; e invece la regia riesce a costruire un clip splendido dove la narrazione per immagini supera ogni aspettativa. E che dire del momento delle Barbie anfetaminiche che ballano surf rock? O il nuovo personaggio del pinguino singhiozzante? O il doppelganger di Buzz che trova il padre nel suo acerrimo nemico? Sembrerà assurdo ma questi giocattoli animati hanno più psicologia e dialoghi sensati di tutto il cinema americano recente. Sarà un capolavoro? La voglia di urlare di sí è forte. So che non mi divertivo così completamente da tempo. In futuro rivedrò il film e riuscirò a essere meno schierato, ma non è detto che non mi esalti ancora di più. Film clamoroso. Co-diretto da Ash Brannon e Lee Unkrich. (Cinema Universale, Genova; 20/2/00)
325 – Rambo del fraudolento Ted Kotcheff, USA 1982
Povera stella, il Rambo: torna dal Vietnam e nessuno gli dice una parolina dolce o gli offre un lavoro. Allora il nostro eroe mutanghero vagabonda e lo arrestano. E lo irritano, sicché il veterano più cazzoso del conflitto indocinese prende e scappa pei boschi menando gran strage di poliziotti. Non basta la Guardia Nazionale, qui serve il vecchio colonnello Trautmann, suo padre putativo e addestratore nei Berretti Verdi. Lo ricondurrà alla ragione dopo una scena splendida: Rambo ha messo a ferro e fuoco la cittadina dove lo hanno arrestato ma bastano le parole del vecchio comandante a ridurlo in lacrime, a piangere i commilitoni morti, tra cui quello che gli è esploso addosso come una tartare… Ah, che film! Erano anni che non lo rivedevo e l’ho ritrovato ottuso e ottusamente divertente come allora, un B-movie che al livello più basso si gode come buon film d’azione. Rambo ha ritmo e intrattiene, dura il giusto e amministra saggiamente avventure e colpi di scena. Se invece, messe da parte le pulsioni pantofolaie dello spettatore, si presta attenzione (?) ai dialoghi (i grugniti, in realtà) del soldato John Rambo, allora vengono i brividi. Questo è un atto d’accusa all’America dalla memoria corta, certo, ma un atto d’accusa in nome dell’“avevamo ragione noi”, del “ci hanno impedito di vincere” etc. Espressione perfetta dell’era reaganiana, Rambo non ragiona, agisce d’istinto (animale) e poi ci pensa, forse. E tutto sommato il fascismo di Rambo è più subdolo qui che negli altri espliciti film della serie, dove si combatteva contro russi, vietnamiti e arabi, nemici ormai a livello di cartone animato. (Diretta su TMC; 1/3/00)
327 – Toy Story 2 di John Lasseter, USA 1999
A fine visione, attraversando una Parigi piovosa, Barbara tace, ma so che il film le è piaciuto. E io tornerò a vederlo per una terza volta, credo. Se alla prima visione sono stato catturato dal ritmo scatenato della vicenda, la seconda volta sono stato più attento alle modalità narrative adottate da Lasseter. Siamo di fronte a uno che conosce perfettamente la grammatica cinematografica e i meccanismi della commedia. Cosa differenzia Toy Story 2 da tanti altri film comici? Solo il fatto che è realizzato con la computer-grafica e, soprattutto, che è realizzato meglio, all’ennesima potenza, sfruttando l’estrema libertà che l’animazione concede: il montaggio parallelo delle due storie che si vengono a creare è gestito con un equilibrio clamoroso e così le gag o i concisi ma saporiti ritratti dedicati a tutti i personaggi. Tra i nuovi amici come non apprezzare l’ottuso nemico di Buzz, suo padre Zurg (anche lui non consapevole dell’essere giocattolo), il tenero Wheezy – pinguino asmatico – o l’indiavolata schiera di Barbie danzerecce? Anche se col paint brush dei programmi di animazione, a Lasseter bastano poche pennellate per rendere unici i suoi giocattoli. Insomma, una vera immensa goduria dove, nell’ambito di un film che si vuole leggero, ci si permette non banali considerazioni parlando del destino dei giocattoli rotti, dell’aridità del collezionismo, della superiorità dei giocattoli materiali sui videogiochi e, soprattutto, del particolare rapporto che si crea tra giocatore e giocattolo, tema su cui si potrebbero dire tante banalità intrise di sciropposo infantilismo e che invece questi geniacci della Pixar sanno trattare con poesia e/o ironia, in un equilibrio che ha del miracoloso. Torno a Milano e lo rivedo per la terza volta, è deciso. (Cinema MK2, Parigi; 4/3/00)
 328 – American Beauty di Sam Mendes, USA 1999
328 – American Beauty di Sam Mendes, USA 1999
È già un po’ che mi s’invita ad andare a vedere questo film, ma diffido dei consigli e m’insospettisce la massiccia campagna di stampa che ha accompagnato l’uscita: ovunque articoli di tuttologi a esaltare il film, soprattutto per la supposta capacità di riuscire a fotografare gli anni Novanta da cui siamo appena usciti. Mah. Rimando la visione perché sono un caratteraccio e accolgo le perplessità di amici di cui mi fido; infine, due settimane fa, provo ad andare in un cinema inesorabilmente pieno di gente e desisto (è l’inconscio che mi ha fatto arrivare solo dieci minuti prima dell’inizio, è sicuro)… poi, però, sono a Parigi e lì la possibilità di vedere il film in lingua originale e la voglia di condividerne la visione con Barbara fanno il resto. Andiamo al MK2 Beaubourg, una sala piccola, ma non minuscola come quella di ieri sera. E si va a cominciare. La prendo larga: dal punto di vista tecnico e formale il film mi sembra ineccepibile, ma nel cinema nordamericano è semmai raro il contrario. Ciò che subito colpisce è l’eleganza della messa in scena. È subito evidente la presenza di un gusto nel gestire le inquadrature e nell’utilizzare il montaggio, il colore, le capacità degli attori e altro ancora. Cioè, ho visto cinema che risponde a una volontà autoriale molto forte (e che apprezzo esteticamente), dove ogni fotogramma è pensato, curato e compiuto. Gli attori sono in parte e tutti di una bravura clamorosa, le musiche (originali e di repertorio) sono azzeccate, il montaggio è sobrio e puntuale con alcune sgrammaticature molto espressive nelle scene oniriche (con ipnotici attacchi ripetuti). Okay, abbiamo messo un po’ di fieno in cascina. Ma i contenuti? Se la sceneggiatura fa schifo? E invece, miracolo, ecco una scrittura che si fonde col racconto visivo in maniera entusiasmante con una coerenza che spesso sfugge ai registi americani, immolata sull’altare dello spettacolo a tutti i costi. Qui, oltre a tutto, Mendes, regista con lunga esperienza teatrale, si dimostra autore a tutto tondo sapendo gestire anche il famigerato intrattenimento, senza soffocare il film in un vuoto estetismo o in una scrittura arida. Kevin Spacey è un uomo medio, quarantenne. Guadagna bene, ha una bella moglie in affari e una figlia adolescente con cui ha problemi comunicativi. Sente il suo impasse, tanto che masturbarsi la mattina nella doccia sembra l’unico momento della giornata degno d’essere vissuto. Gli si prospetta pure il licenziamento, ma, alla constatazione della morte coniugale si contrappone un incontro fondamentale: conosce un’amica della figlia, un animaletto che sprizza sesso da ogni poro, provocante e sensuale. Allora Spacey si ribella e si riprende la vita. Si fa licenziare con una buonuscita clamorosa (sessantamila dollari, ottenuti col ricatto di future delazioni a proposito delle spese illecite del principale), si dedica all’esercizio fisico, riprende a fumare marijuana e a sentire la musica di quando aveva quattordici anni (magnifico hard rock anni Settanta), si compra una Corvette rossa cafonissima e, come estrema presa di coscienza che il Sistema lo costringerebbe in qualche modo a fare del male agli altri, si sceglie un lavoro senza alcuna responsabilità, in fondo alla catena decisionale, responsabile solo per se stesso. Torna alla condizione edenica di un adolescente del 1971 – birra, spinello e Free a palla nell’autoradio – prima che venissero gli spietati anni di Reagan e quelli ipocriti di Clinton. E si rende interessante agli occhi della lolita di cui si diceva. Arriva alla resa dei conti con la moglie (che lo tradisce) ma non riesce a riallacciare i rapporti con la figlia, nonostante ne conosca l’ombroso ragazzo, Rick (che gli vende l’erba). Questo è forse il personaggio più poetico del film: ritenuto matto perché parla poco, ma capace di cogliere l’insostenibile bellezza delle cose, talvolta su nastro magnetico. Figlio di un marine nazi e omofobico, è lui una delle chiavi di volta nel cambiamento di Spacey, capace, col suo atteggiamento distaccato eppure cosciente, di riconsegnarlo all’innocenza e alla libertà. Poco dopo aver conosciuto la fragilità dell’amica della figlia (e non averci concluso niente), Spacey viene ucciso. Lo ammazza il padre di Rick, credendolo il traviatore omosessuale del figlio. Il marine, l’America che rifiuta di guardarsi allo specchio, non tollera l’ipotesi di un figlio gay e non vuole ammettere neanche la sua supposta devianza sessuale (scena splendida, quando bacia Spacey). (Ormai non so assolutamente più scrivere un riassunto. Vabbeh.) La conclusione parrebbe amara, ma dal momento che Spacey si sentiva comunque un morto vivente, sembra che l’ultimo anno di vita contrassegnato da un dionisiaco ritorno ai piaceri dell’esistenza sia valso la pena, per lo meno per aver compreso cosa c’è al di là di ciò che ci viene imposto dalla società. (Non so neppure più trarre delle conclusioni degne di un essere senziente. Vabbeh bis.) Dunque, American Beauty come bignamino sociopolitico degli anni Novanta? Mah. Come Happiness l’anno scorso, American Beauty affronta alcuni dei temi di più stretta attualità, ma più che analizzare constata, senza prendersi la briga di giudicare e condannare come avveniva nel film di Solondz. Tanto Solondz era gelido, spietato, compiaciuto nell’indicarci l’atroce esistenza loro, nel puntare il dito chiamandosi fuori e quasi compiacendosi nell’aver individuato i cattivi, tanto Mendes offre uno sguardo compassionevole ai suoi personaggi, comprendendone i difetti, mostrandoci i lati buoni e cattivi (tutti hanno un punto di svolta nel film, in cui smentiscono la prima idea che ci eravamo fatta di loro), senza condannare in toto. Mendes ci mostra un malessere diffuso (con tanto di memento mori finale), ma anche la via di fuga: la quieta bellezza che lui sa credibilmente mettere in scena e che per alcuni personaggi è l’antidoto alla vuota esistenza. Gran film che dimostra che Pier Paolo ed Elena possono prendere una cantonata (Essere John Malkovich), ma non due. (Cinema MK2 Beaubourg, Parigi; 5/3/00)
(Continua — 9)



